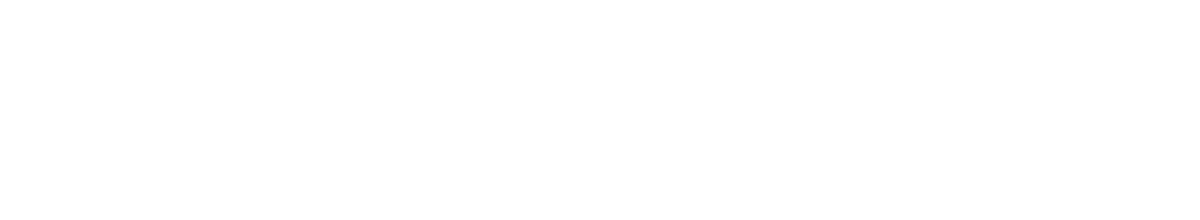Relazioni asimmetriche tra trafficante e trafficato: un’indagine antropologica
Le ondate migratorie che si sono riversate in Italia soprattutto dagli anni Novanta in poi, hanno svelato un fenomeno criminale di proporzioni massicce: il traffico di esseri umani. Esso indica «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi» (Art. 3 del Protocollo ONU sulla prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, adottato dall’Assemblea Generale con la Risoluzione A/RES/55/25).
L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite stima approssimativamente 2.4 milioni di persone trafficate l’anno, l’80% delle quali comprate e vendute a scopo di sfruttamento sessuale, per un fatturato di circa 32 miliardi di dollari l’anno. Lo human trafficking si configura, quindi, come «un nuovo mercato criminale la cui genesi scaturisce dall’incontro tra una domanda di emigrazione e un’offerta di immigrazione, entrambe illegali: dal lato della domanda perché fatta attraverso canali non ufficiali, dal lato dell’offerta perché soddisfatta con mezzi non legali e per realizzare profitti illeciti» (Ciconte e Romani, 2002, p.23).
Tale mercato comprende, dunque, non solo la tratta stricto sensu, ma anche il contrabbando di persone, lo smuggling of migrants. In questo secondo caso, si presuppone che l’organizzazione criminale coinvolta gestisca solamente il trasporto dei clandestini e la loro introduzione illegale nel Paese richiesto: appare piuttosto evidente che, spesso, i clandestini non vengano assolutamente rilasciati e finiscano per essere ridotti in schiavitù. Non esistono garanzie sul fatto che il migrante venga trasportato nel Paese di destinazione richiesto, né che il denaro versato per coprire i costi del viaggio risulti sufficiente all’holding mafiosa; infine, che quest’ultima liberi il contrabbandato una volta attraversati i Paesi di transito (Pangerc, 2008).
È chiaro perciò che il mercato illecito si differenzia da quello lecito per l’asimmetria delle relazioni tra i contraenti. I rapporti di potere sono completamente a favore dei trafficanti, che dispongono di capitali, mezzi, reti e informazioni in quantità assolutamente sproporzionata rispetto alle poche risorse del migrante. Ecco perché il Protocollo ONU soprammenzionato specifica che «il consenso di una vittima della tratta di persone […] è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi [di costrizione, abuso, minaccia, inganno] è stato utilizzato».
Le risposte fornite per contrastare questo fenomeno criminale seguono tre principali modelli: quello della migrazione non regolata utilizzato da agenzie quali l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni; quello giuridico-operativo adoperato ad esempio dalle attività congiunte dei vari Ministeri dell’Interno; infine, quello relativo al riconoscimento dei diritti umani, appannaggio delle varie Organizzazioni Internazionali. Tuttavia, neppure i tre modelli integrati riescono a porre un freno al dilagare del fenomeno criminoso. Cerchiamo di capire innanzitutto la complessità della tematica, illustrando dei casi di ricerca specifici.
Applicando il metodo antropologico, dal 2005 ad oggi ho cercato di ripercorrere una delle rotte del traffico di persone: nello specifico, mi sono occupata della direttrice che convoglia i vari flussi di migranti in alcuni Paesi di transito balcanici quali Bosnia Erzegovina, Croazia e Slovenia, per giungere in Italia e, più precisamente, nel Friuli Venezia Giulia. Durante questi anni, ho svolto numerose interviste rivolte perlopiù a immigrati – anche clandestini ‑, ma anche a rappresentanti istituzionali e operatori sia sociali che delle Forze di Polizia dei vari Paesi. Le informazioni ottenute mi sono risultate fondamentali ai fini di quella che il criminologo francese Alain Bauer definisce crime perception. Un giovane ragazzo afghano di 19 anni, F.R., intervistato a Trieste, mi ha raccontato la sua storia: nato a Medashar, vi frequenta la scuola. Gruppi di talebani si presentano quotidianamente fuori dall’istituto scolastico e vessano il giovane affinché si unisca a loro. Il ragazzino si rifiuta; le minacce vengono estese alla famiglia. Un giorno, F.R. rientra da scuola e trova il padre morto. Scappa dallo zio materno, ma altri talebani continuano a tormentarlo: l’unica soluzione è scappare dal Paese, pagando qualche gruppo criminale che si dedica a questo genere di “trasporto”. Così inizia un viaggio che durerà quattro mesi: dall’Afghanistan, attraverso l’Iran, la Turchia, poi la Grecia, il cuore dei Balcani. Il ragazzo viene scaricato da un container al confine trala Slovenia e Trieste. Da lì, assieme ad altri clandestini, camminando in mezzo ai ruscelli e nascondendosi tra gli anfratti, arriva in Italia. Nel caso di F.R., l’organizzazione criminale risulta perciò funzionale alla sua sopravvivenza: la relazione di asimmetria tra le parti si manifesta nelle continue richieste di ulteriori pagamenti al resto della famiglia rimasta nel Paese di origine, pena la morte del ragazzo, i maltrattamenti quotidiani, la detenzione in condizioni di estremo disagio e malnutrizione.
Sempre a Trieste, si sono svolti nel 2007 i miei incontri con il Procuratore Antimafia Nicola Maria Pace, il quale mi ha illustrato la celebre operazione Oriente 1. Operazione che ha portato allo smantellamento di una rete transnazionale capeggiata dal boss mafioso cinese Xu Bailing e dedita al traffico di persone (Pangerc, 2012). La rete era formata da Bailing e da due mafiosi croati; l’attività criminale rendeva qualcosa come 130 miliardi di vecchie lire l’anno ed era riuscita a introdurre in Italia 5.000 clandestini provenienti dall’Estremo Oriente in poco più di nove mesi. Secondo il Procuratore, alcuni di questi migranti rappresentavano dei “carichi speciali”, essendo destinati al prelievo di organi con eventuale soppressione del clandestino. Inoltre, dalle conversazioni sono emersi alcuni particolari scabrosi, come ad esempio il fatto che i vari carcerieri dei centri di smistamento utilizzassero pestaggi e torture per agevolare ulteriori riscossioni di denaro per il transito della merce umana: nel “gioco del toro”, due clandestini erano costretti a prendersi a testate mentre le loro urla di dolore venivano registrate e successivamente fatte sentire a parenti e amici per pretendere il pagamento del viaggio. Spesso capitava anche che gli aguzzini rivendessero le vittime ad altre organizzazioni che, a loro volta, pretendevano ulteriori pagamenti per il trasferimento dei malcapitati.
Nel 2008, invece, è iniziata la mia ricerca sul campo in Bosnia Erzegovina: tutti gli attori sociali da me intervistati nel corso di un biennio sono convenuti su un punto, ovvero sul fatto bisognasse insistere sulle campagne di informazione e sensibilizzazione della società civile, per modificare l’errata percezione che il traffico di esseri umani non fosse un vero e proprio crimine, ma semplicemente un business con vantaggi anche per chi eventualmente decidesse di affidarsi ai trafficanti. L’aspetto più inquietante emerso dall’analisi del contesto Paese è rappresentato dal fatto che a volte la cronaca ha riportato casi di human trafficking gestiti non da mafiosi, ma da “comuni” famiglie che decidevano di investire nella compravendita di ragazze destinate alla prostituzione (Pangerc, 2012). L’analisi antropologica ha evidenziato come spesso vi fosse un’iniziale congruenza di interessi: le ragazze venivano facilmente reperite e reclutate anche sul mercato interno in seguito alla loro risposta ad annunci per incontri, pubblicizzati nei locali d’intrattenimento o anche via Internet.
La vittima, nel sistema di counter-trafficking, si trova chiaramente al centro del processo giudiziario: testimonianze e dichiarazioni dei trafficati sono essenziali ai fini dello smantellamento delle reti criminali. La protezione degli stessi appare l’ovvia contropartita per le informazioni ricevute, nonostante protezione e reinserimento siano misure molto difficili da applicare: in seguito ad alcune operazioni di Polizia, si è registrato come alcune delle donne liberate siano ricadute nella rete di altri trafficati o ne abbiano create di proprie. Antropologicamente ed epistemologicamente, questo genere di reazioni si spiega nella cristallizzazione dell’identità di vittima, nell’instaurazione di un rapporto immodificabile con il carnefice e nell’impossibilità di creare progetti esistenziali alternativi (IOM, 2007). Queste considerazioni sono state confermate anche durante la mia ultima missione in Bosnia Erzegovina, a luglio 2012: alcuni psicologi che si occupano del recupero delle trafficate sistemate presso una casa rifugio hanno evidenziato le difficoltà quotidiane, annoverandovi addirittura la necessità di sfogo sessuale delle donne, che potrebbero sembrare paradossale ai non-addetti al settore.
Le relazioni asimmetriche fin qui analizzate si rivelano giustificate in primis dal bisogno per i criminali di recuperare le spese sostenute anticipatamente per consentire l’ingresso irregolare del migrante – anche se queste risultano generalmente ben inferiori a quanto viene rivendicato in seguito – o la sua gestione nel caso dei trafficati, e sono mantenute e regolate talvolta attraverso il ricorso alla contrattazione ma anche attraverso l’uso sistematico di violenza, inganno, minaccia e ricatto. In molti casi, la relazione tra vittima e carnefice appare ad entrambi i soggetti come basata su comuni interessi: l’aguzzino dispone di risorse umane gratuitamente, anzi nel caso dello smuggling con pagamento anticipato dalle famiglie nei Paesi d’origine, il migrante riesce invece a giungere dove non sarebbe mai potuto arrivare ma crede di poter saldare in tempi brevi il debito accumulato (Pastore, Rapporto CeSPI). Nelle fasi iniziali del rapporto di dipendenza, dunque, il migrante dimostra lealtà e fiducia nei confronti dell’imprenditore illegale o, comunque, del trasportatore. Per le autorità giudiziarie e per gli operatori sociali risulta , perciò, necessario indurre una cessazione del reciproco comportamento omertoso per slegare la vittima e processare il carnefice.
Le campagne di sensibilizzazione e di informazione dirette alla società civile rappresentano un essenziale strumento atto a far, perlomeno, conoscere alle potenziali vittime le forti asimmetrie che si creano all’interno di quella che viene inizialmente percepita come una relazione consensuale. In seconda battuta, esse mirano a diffondere l’esistenza di tutele negli ordinamenti normativi dei Paesi di arrivo o di transito e di misure sociali quali l’accoglienza in centri d’accoglienza o case-rifugio. Per tutti gli operatori che si occupano di human trafficking, risulta necessario applicare un approccio multidisciplinare focalizzato sulla centralità dello status di vittima, con particolare attenzione agli studi di genere – essendo la maggior parte delle vittime donne.
«The most successful strategies are those that address the root causes and vulnerabilities related to trafficking in persons, strengthen the legal framework in place to prosecute traffickers and sensitize relevant actors to ensure that victims are at the center of counter-trafficking activities. Though responding to human trafficking is a daunting task, it is a challenge that the global community must continue to address through increased, improved and sustainable counter-trafficking measures and enhanced cooperation» (IOM, 2007) [1].
Bibliografia