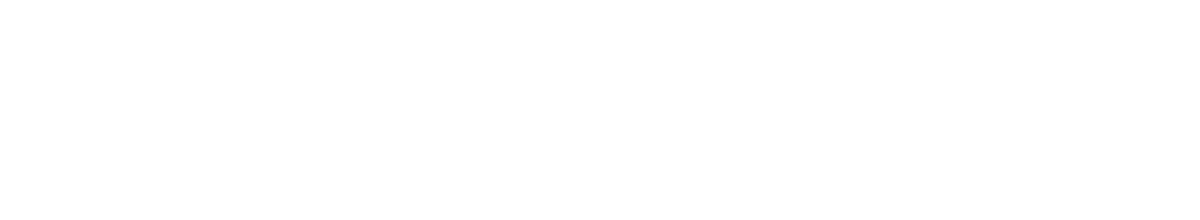Prima infanzia e tecnologie digitali
Esiste una definizione univoca, universalmente (o almeno nelle società occidentali) condivisa, di infanzia? Può essere accettata quella dei dizionari, che spesso la definiscono come quella categoria di soggetti che “ancora non sanno parlare”? O quella di alcune enciclopedie che parlano di una “fascia di età che va da zero a 12 anni”? La difficoltà nel definire la categoria dell’infanzia consiste principalmente nell’impossibilità di rendere conto, in una singola spiegazione, di tutte le specificità che ciascun bambino, già singolarmente, possiede. Essendo stato definito il Novecento anche come il “secolo dell’infanzia”, nell’ambito delle scienze dell’educazione molte sono state le definizioni di infanzia. Si pensi, ad esempio, all’attivismo, alla psicanalisi, all’anti-pedagogia francese, ma anche alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo approvata nel 1959 e revisionata nel 1989.
Per affrontare il rapporto tra bambini e nuove tecnologie può essere utile ricordare la definizione di infanzia che Neil Postman, agli inizi degli anni ottanta, ha tracciato nel suo testo, La scomparsa dell’infanzia. L’infanzia – sostiene il sociologo americano (Postman, 1984) – non è una categoria biologica, ma una categoria culturale. Se è innegabile che i bambini sono sempre esistiti, la categoria di infanzia si sarebbe diffusa soltanto quando l’adulto ha preso consapevolezza della specificità dell’infanzia e ciò sarebbe avvenuto soltanto a partire dal XV secolo, in seguito all’invenzione della stampa. La tesi forte, provocatoria ma suggestiva, di Postman è che il XX secolo abbia rovesciato quel percorso di costruzione dell’idea di infanzia avviato a partire da Gutenberg per effetto dei mezzi di comunicazione elettronici, e soprattutto della televisione. Essa elimina la linea di demarcazione tra l’adulto e il bambino perché, attraverso l’uso dell’immagine, non rende più rilevante la distinzione tra coloro che sanno leggere e coloro che ancora non hanno sviluppato tale capacità. Il bambino, dunque, diventa per la televisione un destinatario non distinto e non distinguibile dall’adulto, tanto che viene immerso in contesti culturali (mediatici) non filtrati e, spesso, non adatti a lui. Postman pensa, in primo luogo, alla società americana, nella quale non di rado – già negli anni ottanta – sono presenti più televisioni nelle abitazioni e che colloca tale medium anche nella stanza dei bambini.
Le tesi di Postman possono essere collegate a quelle di alcuni autori che hanno parlato di Bedroom Culture (Livingstone, 2007), ovvero di una cultura che forma i bambini senza che essi escano dalla camera da letto e senza che essi si relazionino con le figure adulte educative tradizionali (i genitori e gli insegnanti). Con la televisione nella propria camera da letto i bambini sono immersi in contesti non più “ovattati” e “protetti”, ma entrano potenzialmente in contatto con tutti i segreti del mondo adulto senza nessun filtro e senza adeguate spiegazioni.
A circa venti anni di distanza dalle provocatorie tesi di Postman, un’altra definizione di infanzia ha costituito un punto di riferimento per molti studi pedagogici. Mark Prensky, nel suo articolo Digital Natives, Digital Immigrants (2001), ha introdotto la distinzione tra “nativi digitali” e “immigrati digitali” e ha definito l’infanzia (o, meglio i bambini nati nell’epoca della rivoluzione digitale) come quella fascia di età in grado di relazionarsi con le nuove tecnologie in modo spontaneo ed intuitivo. Anche se le posizioni successive di Prensky (2013) hanno rivisto le tesi del 2001, ciò che l’autore ha scritto in quel breve saggio ha dato avvio ad un dibattito anche in ambito accademico: in alcuni casi quelle tesi, che ipotizzavano una mutazione a livello cerebrale delle nuove generazioni per effetto delle tecnologie digitali, sono state condivise e hanno circolato senza un’adeguata problematizzazione. A partire da queste posizioni, si è sostenuto ad esempio che le tesi di Postman non fossero più attuali: in primis perché la televisione è stata sostituita da altri media, ma anche perché si è ritenuto che, anziché denunciare la mancanza di protezione dell’infanzia da parte del mondo adulto, si dovesse fare i conti con un mondo adulto non pronto per stare al passo con le trasformazioni attuali, dunque inadeguato ad abitare i contesti mediatici dei bambini-nativi.
Le tesi sono state criticate sia dalle neuroscienze, che hanno fornito prove scientifiche secondo le quali non sarebbe in atto una mutazione antropologica per effetto delle nuove tecnologie (Rivoltella, 2012), ma anche da alcuni autori che hanno sollevato le loro perplessità dal punto di vista sociologico e pedagogico.
Definire i “nativi digitali” in funzione della nascita in una determinata epoca non terrebbe conto del contesto geografico, culturale e sociale in cui un bambino nasce e potrebbe portare a trascurare l’esistenza di un digital divide all’interno anche dei paesi economicamente più sviluppati. In ambito pedagogico si sottolinea poi come sia rischioso parlare di competenze “innate” nell’infanzia, finendo per scambiare quella che è una confidenza con una competenza. Se infatti la confidenza che le nuove generazioni hanno con la tecnologia è innegabile, la competenza nel loro uso si costruisce invece faticosamente, attraverso un’alfabetizzazione che può provenire soltanto dal mondo scolastico e dal contesto famigliare. Per Henry Jenkins (2007) la metafora dei nativi digitali può risultare sì utile per chiarire la potenza comunicativa dei linguaggi usati dalle nuove generazioni, ma al tempo stesso può risultare pericolosa in quanto riassume attraverso stereotipi sia le nuove generazioni che i cosiddetti immigrati: definendo gli adulti come inadeguati all’innovazione, si assume come una posizione di resa di fronte all’innovazione tecnologica e, al tempo stesso, si sopravvalutano le capacità dei giovani, senza sottolineare la necessità di alfabetizzarli all’uso delle nuove tecnologie. Nota inoltre Ranieri che «nel determinismo tecnologico sotteso alle tesi sui nativi digitali, l’educazione sembra doversi adeguare ai cambiamenti indotti dalla tecnologia piuttosto che orientare i cambiamenti tecnologici emergenti in accordo con le istanze educative e con le esigenze di insegnanti, dirigenti e studenti» (Ranieri, 2011).
Giuseppe Riva, specificando che si può parlare di “nativi digitali” soltanto se si riflette in termini di capacità nell’uso delle tecnologia e non in termini anagrafici, individua quattro fasi rispetto alla “digitalizzazione” dell’infanzia. Da una fase “text”, si è passati ad una fase “web”, per arrivare ad un “web 2.0” e, oggi, all’uso delle tecnologie “touch”. Questo articolo si soffermerà in particolare su questa ultima trasformazione. Non soltanto perché le tecnologie “touch screen” fanno parte in modo sempre più consistente della nostra quotidianità, ma perché esse riguardano in modo significativo la fascia di età dagli zero ai sei anni. E dunque quella fascia relativa alla prima infanzia che sarà oggetto di indagine in queste pagine. Lo stesso Riva parla di “baby nativi digitali”, notando come la capacità di interagire con le superfici interattive da parte dell’infanzia porti i bambini, già dal primo anno di vita, a comprendere gradualmente le strategie per rapportarsi con questi strumenti. A questo riguardo, meritano riflessioni quei filmati che mostrano bambini di poco più di un anno interagire con riviste cartacee in modo perplesso, cercando in loro quella parte della superficie in grado di modificare spostare, allargare i contenuti. Dagli occhi di un “baby nativo digitale”, la tradizionale rivista cartacea rischia di essere un tablet che, per qualche strano motivo, non funziona.
Tornando alle riflessioni di inizio paragrafo, l’infanzia è davvero una categoria definibile in funzione degli strumenti tecnologici che caratterizzano un’epoca? Detto altrimenti, l’idea che l’adulto ha del bambino non dovrebbe rimanere intatta a prescindere dagli strumenti che la caratterizzano? Se si pensa ad una risposta affermativa a questo interrogativo, la tesi di Postman non è così distante dall’essere attuale. Ovvero, occorre preservare l’idea di infanzia tanto faticosamente costruita nel corso della modernità, per far sì che il bambino, come ricorda la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, sia quel soggetto che “a causa della sua immaturità fisica intellettuale”, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un’adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita.
Oltre le etichette, alcuni dati significativi
Come si è visto, una discussione che si interroga sull’esistenza dei “nativi digitali” rischia di far perdere di vista i temi pedagogicamente, sociologicamente e psicologicamente più rilevanti del problema. E di considerare l’infanzia come una fascia di età che ha qualcosa in più degli adulti per il fatto di essere immersa in contesti nuovi. Può risultare utile invece, al di là delle etichette, partire dai dati per comprendere come le trasformazioni in atto all’interno della società stiano portando i media sempre più al centro della vita quotidiana del soggetto e, indirettamente, li rendano sempre più disponibili (e dunque utilizzati) anche dalla prima infanzia.
Le statistiche raccolte negli ultimi cinque anni (si vedano i dati Istat del 2014, ma anche il 12° Rapporto sulla comunicazione Censis-Ucsi del 2014 e i precedenti) testimoniano come anche in Italia sia in costante aumento l’uso delle tecnologie nella vita quotidiana degli adulti. Al di là delle ricerche e dei rapporti statistici, è sufficiente l’osservazione di quanto avviene nei contesti di vita pubblica (dai mezzi di trasporto, a spazi fisici di condivisione come le piazze) per comprendere come le tecnologie mobili stiano diventando, come aveva già notato McLuhan (1967), delle estensioni del corpo di ciascun soggetto. Si stanno diffondendo varie ricerche in ambito europeo rivolte all’uso delle nuove tecnologie da parte dell’infanzia: la più significativa è sicuramente quella avviata dal Regno Unito UK Children Go Online, poi estesa su scala europea anche grazie al contributo di Giovanna Mascheroni (Mascheroni & Olafsson, 2013).
Rispetto alla primissima infanzia, invece, non sono ancora molti gli studi che descrivano quanto (e “come”) siano presenti gli strumenti digitali nella vita dei bambini prima dei tre anni. La ricerca attualmente che descrive in modo più analitico il rapporto tra la prima infanzia e le nuove tecnologie è quella svolta nel 2013 da Common Sense Media negli Stati Uniti, replicando un rapporto già sviluppato nel 2011. Il rapporto, oltre a confermare come la televisione sia ancora un medium molto presente nella vita dei bambini statunitensi tra gli zero i gli otto anni, nota come i nuovi media entrino a far parte della vita dell’infanzia già prima del compimento del primo anno di età. Nei primi ventiquattro mesi di vita, secondo le statistiche di questo rapporto, il bambino fruisce mediamente della televisione per 44 minuti al giorno: un tempo decisamente molto ampio nell’arco della giornata, che supera il tempo di ascolto di storie lette dagli adulti (19 minuti) e l’ascolto di musica (34 minuti). Un tempo decisamente ampio, anche se si considera l’impossibilità del bambino di comprendere il contenuto di televisivo e l’effetto di fascino-ipnosi che essa produce. Tra le altre attività legate all’uso dei media, un significativo spazio è dedicato alla fruizione di DVD, mentre è circoscritta la fruizione di giochi su dispositivi mobili (un minuto) o di software educativi sul personal computer. Tra i dati registrati nel 2011 e quelli del 2013, si nota come, mentre rimane stabile la percentuale di bambini che nei primi due anni di vita guardano abitualmente la televisione almeno una volta al giorno (48%), risulta in netto aumento la percentuale di bambini che hanno fatto almeno una volta uso di dispositivi mobili (dal 10% al 38%) ed è circa raddoppiata anche quella che ha utilizzato almeno una volta un personal computer (dal 4% al 10%).
Tendenze analoghe vengono confermate nella fascia di età da due a quattro anni: aumentano il tempo di fruizione media della televisione (che supera di poco l’ora al giorno) e il tempo di ascolto di storie narrate dagli adulti (29 minuti), diminuisce il tempo dedicato all’ascolto di musica, ma cominciano a diffondersi l’utilizzo di dispositivi mobili, sia per la fruizione di videogiochi (7 minuti), l’uso di console per videogiochi (2 minuti), l’uso del computer per videogiochi o per software educativi (rispettivamente 3 minuti) e anche la fruizione di contenuti televisivi attraverso tablet e smartphone. In generale viene calcolato che, mentre nei primi due anni di vita il bambino “spende” un’ora della propria giornata nella fruizione dei media citati, fino ai quattro anni tale tempo raddoppia. Studi dell’Ofcom relativi al Regno Unito notano che l’utilizzo di Internet attraverso dispositivi mobili è in costante aumento nella fascia di età dai cinque ai sette anni e, se nel 2007 riguardava il 68% della popolazione, nel 2012 ha raggiunto circa il 90% (Ofcom, 2012). I dati riportati da Paolo Ferri in un recente studio (Ferri, 2014) confermano come anche in Europa e, soprattutto nel Nord, sia sempre maggiore il numero di bambini di età inferiore ai sei anni (e anche sotto ai tre) che utilizzano abitualmente dispositivi touch screen: ad esempio in Norvegia il 32% dei bambini fa il suo primo utilizzo di superfici digitali interattive prima dei tre anni.
In attesa di altri dati ed altre ricerche a livello europeo ed italiano che consentano di fare un raffronto rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti, non è difficile ipotizzare, vista la sempre maggiore diffusione delle tecnologie digitali nella vita adulti, un costante aumento nella fruizione di questi strumenti anche da parte dell’infanzia. In generale comunque i dati riportati confermano come i media, sia quelli tradizionali come la televisione sia quelli di nuova generazione come i dispositivi mobili, stanno entrando in modo sempre più capillare nella vita dell’infanzia dei paesi occidentali. Piuttosto che discutere sull’esistenza dei “nativi digitali”, forse sarebbe opportuno che le scienze dell’educazione si occupassero di chiedersi cosa facciano i bambini con tali strumenti e come cambi il loro modo di conoscere la realtà se insieme alle esperienze tradizionali si diffondono nuovi modi e nuovi strumenti per conoscere.
Tra rischi e opportunità
Nell’ambito dei Cultural Studies, e in particolare secondo Sonia Livingstone (2011), occupandosi del rapporto tra nuovi media e bambini occorre necessariamente considerare come direttamente proporzionali i rischi e le opportunità. La citata Livingstone si sofferma in particolar modo sulla fascia di età dell’adolescenza, notando come quei bambini che sono maggiormente propensi all’utilizzo dei media siano sì esposti ad un numero superiore di rischi, ma anche abbiano anche più opportunità per conoscere e per formarsi. Allo stesso modo, quei ragazzi che fruiscono in minore misura del web e degli strumenti digitali sarebbero sì meno esposti a pericoli, ma avrebbero anche minori opportunità. Possiamo chiederci se questa diretta proporzionalità tra rischi ed opportunità possa essere ritenuta valida anche per la prima infanzia e dunque per la fascia di età da zero a sei anni. È vero che un bambino che nei primi tre anni di vita non fa utilizzo di dispositivi mobili incorre in minori rischi e in minori opportunità di un bambino che viene immerso da subito in contesti digitali?
Indubbiamente la prospettiva di Livingstone consente di sfuggire alla tentazione, tipica di molta letteratura pedagogica, di cedere alla tentazione di schierarsi su posizioni, ancora, o “apocalittiche” o “integrate” (Eco, 1964). Legare rischi ad opportunità può significare non focalizzarsi sulle preoccupazioni legate al possesso/uso di uno strumento da parte del bambino, senza chiedersi quali siano le operazioni che il bambino svolge con tale strumenti, quali i software che utilizza e con quali finalità (soltanto ludiche o anche educative?) e soprattutto valutare come il contesto familiare “media” la fruizione di tali strumenti.
Quali sono dunque i rischi di un utilizzo prematuro da parte dell’infanzia delle nuove tecnologie digitali? E quali le opportunità? Partiamo da queste ultime.
Secondo lo studio condotto dall’Accademia Francese delle Scienze, intitolato L’enfant et les écrans, l’utilizzo di tablet e smartphone può essere consigliabile nei bambini a partire dai 12 mesi di vita. Tale attività sarebbe infatti preferibile rispetto alla fruizione di schermi non interattivi, in quanto le superfici touch, diversamente dalla televisione, se utilizzate per un periodo di tempo limitato (al massimo 15 minuti al giorno) e attraverso la supervisione di un adulto potrebbero contribuire allo sviluppo cognitivo e promuovere la conoscenza del mondo e di se stessi. Dai due anni in poi l’utilizzo di alcune App potrebbe favorire la capacità di attenzione selettiva, la categorizzazione e l’apprendimento del fare di conto. L’uso dello strumento digitale interattivo dunque potrebbe rientrare tra le attività che portano il bambino ad interagire e a trasformare la realtà, allargando le sue possibilità conoscitive. Secondo i ricercatori francesi che hanno sviluppato il rapporto citato, i giochi interattivi, attraverso la loro dimensione multimediale che integra narrazione e interazione (Riva, 2014), avrebbero la capacità di coinvolgere sia il lobo frontale, deputato alle funzioni cognitive superiori, sia il lobo parietale, che controlla l’attività visuospaziale.
Una riflessione che si sofferma soltanto sulle opportunità, tuttavia, rischia di produrre approcci “integrati” e adozioni acritiche degli strumenti tecnologici. È sufficiente osservare l’uso che viene fatto di tablet e smartphone da alcuni genitori in situazioni pubbliche (si pensi ad esempio al ristorante) per comprendere come tutte le potenziali opportunità citate rischino di tradursi automaticamente in rischi e in “abusi”. Se lo strumento, infatti, viene inteso come una “tregua” che il genitore si concede dal suo ruolo educativo, quell’accompagnamento adulto che la stessa Accademia Francese delle Scienze auspica rischia di venire meno, in quanto la fruizione avviene in autonomia. Il rischio, dunque, è che si superino i quindici minuti auspicati, che il bambino sia portato a fare esperienza in modo sempre più mediato dagli strumenti e non tramite la propria esplorazione diretta e che si diffondano, già dalla prima infanzia, forme di dipendenza dalla tecnologia. Per quanto possa essere utile l’interazione con una superficie touch e la narrazione di una storia interattiva grazie ad un’apposita applicazione, occorre ricordare che difficilmente tali esperienze potranno essere più significative della manipolazione degli oggetti da parte del bambino e dell’interazione che un genitore può garantire attraverso la narrazione e la lettura in prima persona di una storia. In estrema sintesi, le citate opportunità si traducono rapidamente in rischi qualora il genitore percepisca la tecnologia (dalla televisione ai nuovi media) non come un veicolo di testi per l’infanzia (che dunque – come tutti gli altri testi – necessita di essere fruito con la mediazione adulta), ma come uno strumento al servizio della propria genitorialità, dunque una sorta di baby-sitter alla quale affidare il proprio figlio per svolgere in tranquillità altre attività. Rientra poi pienamente tra i rischi anche l’alta esposizione a radiazioni nell’uso di smartphone e tablet, approfondita da alcuni autori (Provantini & Longoni, 2014).
Non sono legati tanto ai rischi, quando al ridimensionamento delle opportunità alcuni studi prodotti dal Cohen Children’s Medical Center di New Yourk (Milanaik & al., 2014): nei risultati, presentati nel 2014 durante il Congresso delle Pediatric Academic Societies svolto a Vancouver, emergerebbe che non esistono differenze a livello cognitivo tra i bambini che non hanno mai fatto uso di applicazioni digitali nei primi tre anni di vita e quelli che le utilizzano abitualmente. Lo stesso studio individua una correlazione anche tra l’elevato uso di dispositivi mobili con App non educative ma soltanto ludiche e il ritardo nello sviluppo del linguaggio, anche se tale relazione potrebbe essere anche dovuta ad una preferenza da parte dei bambini che presentano uno sviluppo linguistico più lento per l’utilizzo di dispositivi ludici che non prevedono un elevato coinvolgimento a livello linguistico.
Guidati dalla consapevolezza di rischi e di opportunità, genitori ed educatori sono chiamati a scoprire, comprendere, conoscere e spiegare (ai cosiddetti “bambini digitali”) quelle tecnologie che ormai fanno parte del loro scenario di vita quotidiana. A considerare quali sono le loro proprietà strutturali (quelle per le quali la forma condiziona inevitabilmente il contenuto), ma anche quali sono i programmi e le applicazioni che attraverso di esse possono essere utilizzate.