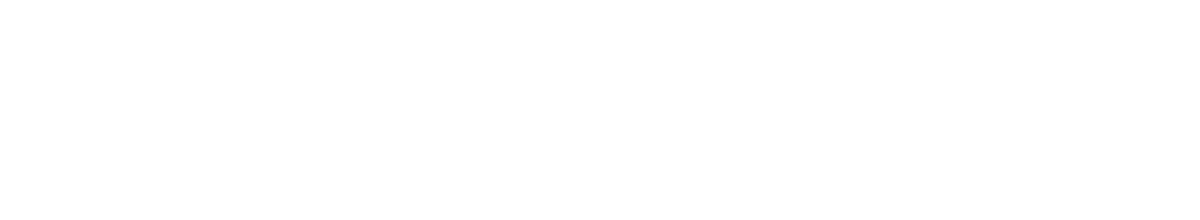Nell’era delle vittime senza giustizia
Negli ultimi tempi, intensi sotto molti punti vista, anche il panorama giudiziario-forense è stato scosso da alcuni avvenimenti che, non possono essere trascurati: la sentenza d’appello per l’omicidio di Meredith Kercher con l’assoluzione con formula piena di Amanda Knox e Raffaele Sollecito e la sentenza d’appello per Alberto Stasi, imputato con l’accusa di aver ucciso la sua fidanzata Chiara Poggi, che per la seconda volta, è uscito da un processo con l’assoluzione. Solo due esempi, se ne potrebbero aggiungere molti altri.
Per ben due volte in tempi ravvicinati l’opinione pubblica si è trovata di fronte a qualcosa che ha lasciato stupiti ed amareggiati, due situazioni che non esiteremmo a definire “delitti risolti male”. Non delitti irrisolti, attenzione, in cui l’oscurità e il dubbio sul colpevole sono totali. Bensì casi ‑ che peraltro hanno occupato l’attenzione pubblica per anni ‑ in cui regna l’ambiguità. O quella che viene percepita, collettivamente, come un’opacità del giudizio, una sorta di “grey-zone”, che lascia insoddisfatti tutti. Se vogliamo, una sorta di “ambivalenza” del giudizio in cui se da una parte si mortifica la certezza della responsabilità dell’autore del delitto, dall’altra emerge, in tutta la sua evidente drammaticità, una vittima che continua a gridare e a chiedere, sia pure nel silenzio di chi non può più parlare, una giustizia che in questo stato di cose nessuno è più in grado di restituirle.
Si avverte, soprattutto la necessità di una riflessione che si impone con urgenza. Immersi, come siamo, nell’era della “scientificità della prova”, che viene sostenuta dagli accurati interventi delle istituzioni preposte, sia i R.I.S. dell’Arma dei Carabinieri che quelle della Polizia Scientifica, investigatori, periti, consulenti tecnici, propongono al magistrato la “soluzione del caso” in termini di “esattezza” delle corrispondenze tra tracce trovate e collegamenti con persone indagate, che a quel punto dovevano essere materialmente sulla scena del delitto. La cosiddetta prova “evidence based”. Ma qual è il rischio di un’amministrazione della giustizia basata sulla prova scientifica?
Anche nella catena procedurale (le analisi di laboratorio, la conduzione e quindi gli esiti di un’autopsia) ci possono essere delle falle, degli errori (ad esempio in una di queste fasi: raccolta, repertazione, classificazione, collocazione, analisi, ed infine di interpretazione dei dati ottenuti, nell’attività di laboratorio), ma soprattutto il valore della prova scientifica sta nella presunzione di certezza assoluta del risultato, poiché basato sul ‘metodo scientifico’. Scienza e verità si legano indissolubilmente.
Siamo passati da un tipo di processo indiziario (chi non ricorda il motto investigativo “tre indizi fanno una prova”?) a un processo basato sull’attività scientifica il che potrebbe anche andare bene se assumiamo che la scienza produca risultati inconfutabili ed incontrovertibili. Questi risultati dell’attività scientifica, dovrebbero essere inequivocabili e quindi portare a conclusioni certe. La consequenzialità ‘logica’ della traccia scientificamente processata dovrebbe consentire di superare ogni dubbio e condurci all’autore del reato. Perché non accade? Come mai la diagnosi (dià-gnosco = conosco per mezzo di, attraverso) spesso non riesce ad ottenere rilevanza giuridica nonostante si costituisca come ‘verità’ scientifica?
Sembrerebbe quindi che l’elemento debole di questa catena sia proprio il valore che viene dato alla diagnosi che si accompagna alla traccia. Ora, è proprio questa ‘diagnosi’ che trasforma una semplice traccia in una prova ‘a carico di’. Non dobbiamo meravigliarci però se nella catena vengono commessi errori da ciascuno dei componenti della catena.
Spesso gli operatori si sono lamentati per la fretta cui erano sottoposti per dare risposte, risultati. Effettivamente le attività di laboratorio sono spesso condotte sotto la pressione non solo degli investigatori e degli organi inquirenti, ma anche dall’opinione pubblica che tramite i media preme per avere un colpevole. Naturalmente, come spesso è accaduto, prove “scientificamente certe” portate a conforto delle tesi del Pubblico Ministero siano state altrettanto scientificamente contestate dall’attività peritale della difesa. Viene da chiedersi: quante scienze esatte esistono?
La prova scientifica, che si basa su un’ipotesi statistico-matematica fondata sul principio della falsificabilità dell’esperienza così come indicato da K. Popper, dovrebbe dare il massimo di affidabilità al risultato dell’esperimento così come accade in tutte le scienze cosiddette positive, fino a nuova ipotesi. É diventata nel tempo una sorta di “evento puntiforme” (Barthes R., 1980) di tutta l’attività forense, dalle indagini che svolge il Pubblico Ministero alle contro-deduzioni ed indagini che, con il nuovo ordinamento, può svolgere anche la difesa.
Dunque la prova scientifica tende sempre più a sostituirsi alla prova tradizionale che è frutto di attività investigative di ascolto di testimonianze e collegamento di eventi, secondo un procedimento che parte da un’intuizione e cerca la conferma mediante un ragionamento logico deduttivo.
Nasce un pensiero che sembra mettere in discussione l’impianto tradizionale dell’attività di indagine, basata sui principi della deduzione e della consequenzialità: una cosa accade, o è accaduta, perché vi sono determinate premesse o condizioni, in origine, che l’hanno determinata.
Il principio logico-deduttivo al quale sembra contrapporsi quello empirico-induttivo. Non solo ermeneutica (dal greco hermeneutikè “tecnica dell’interpretazione”, dal verbo hermeneuein “interpretare” nel senso più ampio, per cui si intende qualsiasi tecnica che permetta di interpretare un testo, un documento, un’epoca storica e qualsiasi altro discorso o segno), ma anche epistemologia, cioè disciplina che si occupa dello studio critico della conoscenza scientifica, attraverso l’analisi del linguaggio, delle metodologie, della strutturazione dei concetti teorici, al fine di stabilirne i criteri di validità. Si tratta, in sostanza, di analizzare i fondamenti, la natura e i limiti della conoscenza scientifica. La verità, non è quindi quello che “rimane al di sopra di ogni cosa”, unica, evidente, stabile e immutabile indipendentemente dai costumi, dalle epoche e dalle diverse società, ma è in qualche modo “la prima vittima del mutamento”, senso che può via via rivestire la realtà entro i cammini mutevoli e soggettivi dati dall’interpretazione degli eventi.
Dobbiamo ancora chiederci perché sta accadendo che i giudizi espressi nelle varie tappe del sistema giudiziario non portino di fatto a un colpevole certo? Perché sta accadendo sempre più spesso che il giudizio, che deve tener conto sia dell’attività investigativa, che di quella peritale, e di quella testimoniale, non possa contare su dati certi e incontrovertibili. E soprattutto perché di fronte a un’attività investigativa che viene svolta in base agli strumenti esistenti, succede poi che il giudice ne prenda in considerazione gli esiti in maniera parziale, ridotta, insomma le dia peso fino a un certo punto.
E qui emerge quel ruolo del giudice sul quale si assiepano i nostri interrogativi principali, ovvero quel rapporto tra giudice e le altre figure professionali che ruotano come specialisti, e forniscono indicazioni a sostegno, o a cancellazione delle “prove” nell’iter processuale, lì dove la prova si forma, lì, dove il giudice ha la facoltà di portare a rilevanza, o ritenere inadeguate o perfino inutilizzabili le risultanze a lui fornite, secondo un proprio insindacabile giudizio.
Nel nostro ordinamento il giudice è peritus peritorum. Cosa fa di un giudice il perito dei periti? Seguiamo un breve percorso logico: se è prevista la figura dell’esperto, del perito, del consulente, è evidente in sé che chi la richiede, di fatto, assume di non avere specifiche competenze in materia, e che, si affida alla competenza di chi, di quella materia, ha fatto oggetto centrale delle sue ricerche. Dovrebbe, quindi, accettarne le risultanti, e invece quando è sottilmente inquietato dal dubbio dispone perizie sulla perizia.
Ora, se è vero il detto latino tot capita tot sententiae, egli si ritroverà in un ginepraio di interpretazioni contrastanti, disunivoche e a volte paradossali. Alla fine su cosa esprimerà le sue valutazioni? A quale delle risultanti darà credito? Cosa è che fa di un giudice un autentico super partes?
Il proprio convincimento insindacabile. Un proprio giudizio, appunto. Un giudizio formulato in base a una formazione che, come sappiamo, è prevalentemente giuridica, poco aperta al versante psicologico, sociologico e criminologico-forense. E sul quale incide, o può incidere, fino alla fine, inevitabilmente, ad esempio, anche quell’idea che si fa dell’imputato (intuitu personae). Un po’ come accade a quell’investigatore che si “innamora” della sua tesi investigativa.
Una toga, o un saio, coprono le fattezze di un uomo, rivelano il suo status sociale, ma non la sua essenza. Pertanto, in quanto essere umano, dobbiamo ritenere che non sia esente da condizionamenti educativi, dalla sua propria struttura di personalità, dalle esperienze fatte, e da come le ha rielaborate. Elementi, tutti, che, come sappiamo costituiscono un vero e proprio “filtro interpretativo” di ogni realtà osservata e di ogni relazione vissuta. Nemmeno va sottovaluto, da ultimo, quel sottile influenzamento percettivo che deriva dall’essere immerso in una collettività, in un contesto di relazioni, espressione di quello che una volta si sarebbe detto il “canone culturale del tempo”. Naturalmente, proprio in quanto essere umano, non potrebbe accadere altrimenti. Dobbiamo accettarlo.
E veniamo al dibattimento. Rappresenta la fase processuale più importante perché è in questa sede che avviene la formazione della prova indispensabile ai fini del giudizio finale. Il procedimento penale si concluderà proprio con un provvedimento giudiziale nella forma di una sentenza. Il giudice, però, quale amministratore della legge, nella sentenza, non esprime soltanto un giudizio, ma è anche colui che commina una pena, valuta, cioè in termini retributivi, il significato e la portata di quell’azione delittuosa che ha in esame.
Vero è che è confortato da un codice che per ogni delitto stabilisce un margine di pena, ma anche in questo caso dobbiamo prendere in considerazione quegli elementi di soggettività, che costituiscono la “fallibilità umana del funzionario”. Nel momento in cui esercita la funzione sociale di iudex, egli non è soltanto colui che pronuncia il dettato della legge. In sostanza, dall’etimo latino iudex, deriva da ius, diritto, e dicere, dire, pronunziare. Il giudice, nella sua imparzialità, non difende la vittima, ma è profondamente impegnato nella restituito ad integrum del bene giuridico leso in quella vittima. Se così è, il peso e perfino l’evidenza della prova, diventano estremamente relativi ed è questo il vero elemento di debolezza della catena: il valore che viene attribuito alla prova in sede processuale, il discrimine, responsabile di indirizzare il giudizio in una direzione o in un’altra.
A questa situazione bisogna aggiungere l’incidenza, legittima, dell’attività difensiva che, nell’esercitare il diritto di tutela dell’imputato, qualora sapientemente condotta, può non solo neutralizzare e/o vanificare l’efficacia di tutte le prove portate in dibattimento contro di lui, ma anche costituirsi come parte che rappresenta quell’orientamento forense impegnato a lavorare per un giusto processo. L’attività difensiva, però, non nel suo ruolo di tutela dell’imputato perché abbia un giusto processo, può, poiché ne cura comunque gli interessi, utilizzare le prove scientifiche anche a vantaggio del reo: altro elemento che porta a un giudizio non certo e portare chi ha commesso il reato a farla franca.
Per finire, ultima ma non in ordine di importanza, ecco l’interferenza dell’attività mediatica che in molti casi oggi sposta letteralmente la sede naturale del processo dall’aula del tribunale direttamente nello studio televisivo procurando quell’esasperazione ed amplificazione della notizia che trasforma inevitabilmente la percezione sociale dell’evento. Quanto viene esibito in tv ha certamente maggiore impatto sulle nostre menti, di quello che succede nella realtà dell’attività investigativa, fino a giungere come eco dentro il palazzo di giustizia il che, procura un’attesa spasmodica per le sentenze, lasciandoci poi insoddisfatti. Questo elemento, nella riflessione complessiva, non va sottovalutato.
Il sistema mediatico a volte confonde acque già confuse. Altre, finisce col diventare stimolo e perfino orientamento delle indagini. E di questo caos l’andamento del processo non potrà rimanere immune. Il dramma degli ultimi delitti, in definitiva, è che appaiono come delitti irrisolti invece sono risolti male. Perché l’irrisolto lascia tutti nel dubbio, nella sospensione e nell’attesa di una “soluzione” certa. Invece relativamente a questi, ci sono state le attività investigative, un’intensa e controversa attività peritale, un giudizio di primo grado. Tutta la macchina ha lavorato nel modo giusto? Come mai rimaniamo con l’impressione che non vi sia, quasi mai, un autore di reato certo?
Esaminiamo brevemente la catena. Dall’evento reato, il delitto, si mette in moto una macchina complessa: dalla notitia criminis scatta l’obbligatorietà dell’azione penale, si muovono investigatori coordinati dal Pubblico Ministero, si cercano testimonianze, e soggetti “idonei” ad aver commesso il fatto, le tracce, gli esiti, quelle fonti di prova che dovranno essere trasformate in prova alla presenza del giudice durante il processo. Attualmente nel processo, durante il quale si costruisce la verità processuale, e non quella storica dell’evento delittuoso, vince chi è più astuto/furbo. Ovvero chi sa condurre ed orientare “epistemologicamente” tutto l’iter.
L’esasperazione mediatica con servizi non più solo di cronaca e di informazione, ma con veri e propri dibattiti che mimano l’iter processuale (sono presenti in studio avvocati, magistrati, esperti di settore), fanno sì che vi sia una rappresentazione anticipata di quello che dovrebbe essere il processo, spostato, ormai, dall’aula allo studio televisivo.
Quanto, sulla percezione sociale dell’evento, influisce, quello che viene esibito in tv, con le caratteristiche dell’amplificazione e di quel fondo di verità che viene attribuito a tutto ciò che appare in tv? Quanto il sistema mediatico finisce per confondere le acque ed influenzare la percezione dei fatti, delle persone, degli eventi?
Possiamo sostenere che ha certamente un impatto maggiore sulle persone, e sull’opinione pubblica di quanto non accada durante il processo vero. Possiamo ipotizzare che l’eco di questa attività “a latere” finisca con l’influenzare in maniera sottile a volte, anche l’orientamento delle indagini. Insomma, alle soglie del XXI secolo, di fronte alle “magnifiche sorti e progressive” della criminologia, fra rilievi, analisi, tecnologie sofisticate, è nato un nuovo linguaggio che sembra spiegare ogni cosa, ma continuano ad esserci molti delitti irrisolti. Nel nostro Paese si alimenta un voyeurismo morboso sui fatti di sangue: da un lato, sembra che la vittima sia al primo posto nei pensieri di chi osserva i dati e si fa interprete dell’umore dell’opinione pubblica, ed invece, ad una lettura più attenta, siamo testimoni del rischio di una vera e propria “apologia dell’autore”.
Il sospettato viene “passato al setaccio” dell’informazione mediatica, è oggetto di innumerevoli interventi, interviste, interpretazioni. La vittima resta nello sfondo della percezione. Questo sistema, non rende quasi mai giustizia alle vittime. Alla fine gli unici a guadagnare da queste situazioni di incertezza e di speculazioni sono i talk show e le tante trasmissioni a tema, che non a caso sono aumentate in modo esponenziale.
E la vittima? È vittima, ulteriore, del trionfo del Dubbio … Ma, non dice il dettato dell’ordinamento … in dubio pro reo??