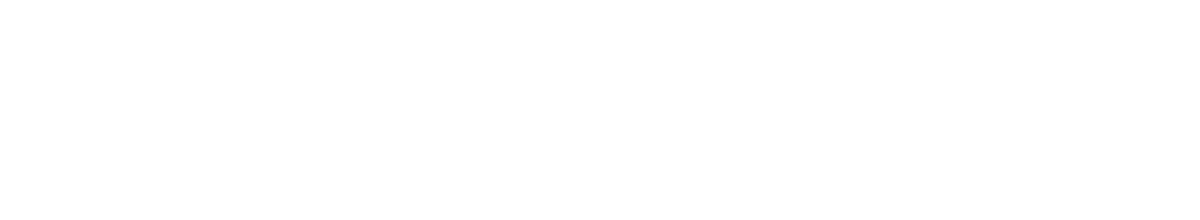Mobbing: verità processuale e danni connessi
Sempre più spesso in Italia e in Europa, quando si parla di diritti dei lavoratori, si affronta l’argomento Mobbing. Solitamente però si fa confusione a riguardo per il fatto che questo termine assume significati molto diversi in funzione dell’ambito a cui viene applicato e, soprattutto, in funzione della nazione in cui il termine è utilizzato. La prima definizione di Mobbing è stata data alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, da Heinz Leymann (Sprini G., 2007), il quale lo descrisse come: «una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica, da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo progressivamente spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa». L’etimo del termine deriva dall’inglese to mob, che vuol letteralmente dire aggredire, circondare per assalire, usato anche dall’etologo Konrad Lorenz (Carrettin S., Recupero N., 2001), per spiegare il comportamento di alcune specie animali che posizionatesi in cerchio, cercano di spaventare e scacciare un proprio simile. In particolare in ornitologia che indica l’attacco di alcune specie di uccelli contro un rapace loro predatore. Oggetto della nostra trattazione sarà solo il mobbing aziendale, nettamente distinto da quello “sociale” come gli abusi familiari, nelle scuole, ecc.
Il mobbing nel mondo del lavoro
Dato il crescente rilievo assunto del concetto Salute, non più come assenza di malattia, ma come benessere fisico, psicologico e sociale, la fattispecie del mobbing sta assumendo sempre maggiore importanza. Nell’ambito lavorativo, in particolare, si declina in tutta una gamma di azioni e pratiche: umiliazioni, schernimento, demansionamento, dequalificazione con negazione di diritti, continui attacchi sul proprio operato, diniego di periodi di riposo, isolamento, minacce. Alcuni studi condotti dall’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) evidenziano come in questi ultimi anni nel nostro paese si siano registrati almeno circa 1500.000 casi di mobbing su lavoro (nel 2000) su 21 milioni di occupati, e prendendo in considerazione anche i familiari raggiungiamo circa i 4 milioni di vittime. Il 48% sul totale dei mobbizzati risultano essere uomini.
Diverse le tipologie di mobbing fra i quali il bossing, verticale, orizzontale, ascendete, trasversale, individuale ed infine collettivo.
Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un abuso perpetrato dal datore di lavoro o da un superiore ai danni di un dipendente. La modalità di aggressione scelta è la demolizione della reputazione, impedendo alla vittima di essere in futuro assunto, o rendendo le prestazioni lavorative impossibilitate da assegnazioni di continui incarichi, spesso troppo onerosi o svalutanti (es. ricevere telefonate, fare fotocopie ecc). Al dipendente possono venirgli attribuiti o sottratti ad nutum incarichi all’ultimo momento; può essere umiliato di fronte agli altri colleghi, non comunicandogli informazioni importanti per lo svolgimento della sua mansione o rivolgendosi a lui con battute sarcastiche o relegando la sua attività lavorativa in luoghi angusti, scarsamente illuminati e arieggiati. Può essere costretto al trasferimento immotivato in altre sedi, o in caso di malattia essere assoggettato a visite mediche domiciliari ripetute, e al suo rientro in azienda, trovare la scrivania sgombra. Detto anche mobbing strategico (Donatiello M., 2004), si tratta di una vera e propria strategia aziendale di riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure di semplice eliminazione di una persona indesiderata.
Il bossing, invece, altra forma di mobbing spesso non del tutto consapevole, è un modo di agire lucido e razionale, una vera e propria strategia di marketing. Può inoltre essere attuato per “invitare” il dipendente al licenziamento qualora questo non fosse possibile senza giusta causa.
Il mobbing verticale viceversa è l’insieme di maltrattamenti agite da colleghi di grado superiore per timore di un possibile avanzamento di carriera da parte di un loro collega, o perché in sintonia con il datore di lavoro, si prestano servilmente alla demolizione del soggetto per ingraziarsi i favori del capo.
Dicesi mobbing trasversale, quando le parti attive – cd mobbers – vengono identificati nel datore di lavoro e in altri soggetti esterni all’azienda, impedendo così al mobbizzato di trovare apprezzamento in altre agenzie professionali.
Per mobbing orizzontale, invece, s’intende l’abuso psicologico messo in atto tra dipendente di eguale grado, isolando il mobbizzato, facendolo sentire non desiderato, rifiutato per i più svariati motivi, privandolo del dialogo, del rispetto e della collaborazione indispensabili sul luogo di lavoro. Spesso il mobbizzato è mero “capro espiatorio” di tutte le frustrazioni, ansie accumulatesi a lavoro, bersaglio sempre pronto da colpevolizzare in caso di ritardi, inadempienze, insoddisfazioni della clientela.
Il mobbing ascendente si verifica quando le condotte sono poste in essere da personale sottoposto nei confronti del loro superiore. Di solito un gruppo di lavoratori o la totalità di questi, che nutrendo antipatia per il loro datore o per il loro supervisore, può trasformarsi in mobbers. Tipo di mobbing, in effetti, molto raro.
Si parla di mobbing individuale, infine, quando le condotte mobbizzanti sono rivolte verso un solo individuo, collettivo quando la vittima degli abusi è un gruppo.
Lo studioso svedese Harald Ege, massimo esperto in mobbing, individua sei fasi attraverso le quali si delinea il mobbing. La prima è chiamata di “conflitto mirato”, s’individua la vittima designata, sfruttando ogni minimo pretesto per attaccarla. Nella seconda fase ha inizio il vero e proprio mobbing, l’isolamento. Nella terza fase emergono, nel mobbizzato, le prime avvisaglie psicosomatici come insonnia, ansia generalizzata, nausea persistente, tremore alle gambe, problemi gastrointestinali, mal di testa, periodi depressivi ecc. Il soggetto a causa di questi malesseri, può assentarsi dal lavoro per malattia anche per lunghi periodi, con grave deprezzamento delle sue capacità e della sua immagine professionale. Possiamo parlare pertanto di quella che in sociologia è chiamata la “profezia auto-avverante”. La vittima, tramite l’abuso reiterato nel tempo finisce per interiorizzare il pregiudizio negativo, inizia a percepirsi debole, non all’altezza delle competenze richieste, percependo quel marchio indelebile di “perdente” che avverte come essergli stata impresso. La vittima finisce per sentirsi realmente inadeguata, comportandosi come se non meritasse il posto occupato. Nella quarta fase il “caso del mobbizzato” si spande nell’intera azienda: le assenze per malattia prolificano, ciò viene notato dai superiori, che nel caso non fossero direttamente responsabili dell’abuso a lei riservato, la prendono di mira fino ad arrivare a sanzioni disciplinari. Nella quinta fase il soggetto in questione viene “cortesemente” invitato dal responsabile dell’azienda a cessare queste sue condotte, pena provvedimenti definitivi. La sesta e ultima fase vede la fuoriuscita dello stesso dal mondo del lavoro, o per prepensionamento causa malattia, o per licenziamento a causa del venire meno del rapporto di fiducia con il datore, o per dimissioni, visto il clima insostenibile creato nei suoi confronti (Ege H., 2002).
Aspetti normativi
Per definirsi mobbing occorre che i meccanismi di abuso si protraggano per almeno sei mesi. Il mobbing, inoltre, può essere giudicato sia in sede civile sia in sede penale con sostanziali differenze durante la valutazione. In sede civile deve essere valutato il danno (biologico e morale) che può essere stato generato dalle persecuzioni: per questo gli episodi saranno analizzati nel loro complesso. Nel caso di procedimento penale, invece, sarà studiato ogni singolo episodio per valutarne la rilevanza ai fini del processo.
La legislazione italiana riguardo il mobbing è ancora piuttosto vaga. Non esistono articoli nei codici civile e penale che chiariscano le sanzioni in cui incorre chi attua comportamenti persecutori e mobbizzanti. Tuttavia la maggior parte dei comportamenti raccolti attualmente sotto la voce “mobbing” trovano corrispondenza in numerosi articoli del codice penale. La tipologia di reato che può dirsi più vicina alle peculiarità delle eterogenee condotte sotto analisi, è il reato di maltrattamenti prescritto nell’art. 572 c.p. commesso da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione.
In via ulteriore si rammenta l’articolo 32 della Costituzione italiana a tutela del bene Salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività tanto durante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed extralavorativa. Quindi l’articolo 2043 c.c. -«qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»– si inserisce di diritto nel paradigma di norme a tutela del soggetto vittima di mobbing. Di seguito l’articolo 2094 c.c. definisce come fondamentale in un rapporto di lavoro non solo la subordinazione ma soprattutto la necessaria collaborazione. A tutela della sicurezza e della dignità umana, l’articolo 41 della Costituzione: il datore di lavoro è tenuto a prevenire i danni di varia natura ad ogni suo dipendente, prescritto che per l’individuo il Lavoro, oltre a rappresentare lo strumento per assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), costituisce un ambito essenziale per la realizzazione della sua personalità (art. 2 Cost.).
Il Decreto Legislativo 626 del 1994, infine, rappresenta altrettanto caposaldo nella normativa sul mobbing: si sottolinea, difatti, tanto l’importanza di tutelare l’integrità psico-fisica e non solo fisica del lavoratore, quanto si propone un concetto nuovo di “salute”, non più intesa come assenza di malattia, ma come espressione di benessere e soddisfazione.
La giurisprudenza, come sempre, costituisce il vero elemento di ‘avanguardia’ sul tema: la prima sentenza relativa al mobbing, risale al 16 novembre 1999, n. 9539, Tribunale di Torino, Sezione Lavoro. Il giudice accoglie le istanze di una lavoratrice che chiede il risarcimento a causa del danno biologico: «per essere stata colpita da depressione psichica in seguito a maltrattamenti subiti durante la prestazione lavorativa» e decreta la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’Art. 2087 c.c. Proprio grazie a questa sentenza, negli anni successivi sono stati presentati diversi disegni di legge, volti a disciplinare al meglio il fenomeno. Per la prima volta si ritengono vessatorie condotte in sé superficialmente insignificanti, purché dotate del carattere di ripetitività e sproporzionalità.
Un altro dei nodi principali del dibattito sul fenomeno vessatorio, riguarda il momento probatorio. Aspetto che sarà analizzato nei paragrafi successivi e sempre in riferimento ad un recente progresso giurisprudenziale.
Il danno e l’onere della prova
Non è sempre facile stabilire nel merito delle condotte da mobbing, l’onere della prova del comportamento mobbizzante grava su colui che si trova a reclamare comportamenti ingiusti. Gli eventuali responsabili potrebbero risultare difficilmente identificabili, vuoi per gli atteggiamenti subdoli, sfuggenti del mobber, vuoi per il comportamento connivente dei commober, di coloro cioè che assistono o favoriscono le azioni mobbizzanti, che con la loro compiacenza o reticenza assicurano l’impunità a tali atteggiamenti.
Si tratta inoltre di valutare se la compromissione dell’integrità psicofisica del lavoratore sia riconducibile ad una condotta colposa o dolosa del datore/collega di lavoro. In caso di condotta colposa, siamo in grado di sostenere che il datore o il collega deve considerarsi cosciente e responsabile della condotta ma non dell’effetto da essa prodotto per negligenza, ingenuità, pigrizia o mancato adeguamento a norme vigenti. Questi comportamenti indicano, quindi, un certo grado di responsabilità del datore di lavoro in quando, anche se non direttamente imputabile delle vessazioni o delle cattive condizioni in cui il mobbizzato era costretto a lavorare, non si è preoccupato di dare il via a provvedimenti tempestivi per far si che il problema non degenerasse. Si parla, invece, di dolo, quando l’azione risulta essere intenzionalmente e consapevolmente orientata a produrre l’evento danno nel soggetto. Quando le conseguenze del danno risultano essere, comportamento autolesivo come il suicidio, abuso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche o aggressivo, come l’omicidio per vendetta nei confronti del mobber o di coloro considerati responsabili delle sue sventure, si dovranno prendere provvedimenti legali nei confronti di colui che verrà considerato imputabile. Interessante un’indagine condotta da Martin Resch e Marion Schubinski (Resch M., Schubinski M., 1996), lo studio esamina la possibilità del mobbizzato di trasformarsi da abusato a mobber, situazione, questa, non infrequente.
Proseguendo nell’analisi dei singoli elementi della fattispecie di mobbing, fondamentale è indubbiamente l’attività persecutoria: essa è costituita da piccole provocazioni, tormenti quotidiani, che presi singolarmente possono avere poco peso, ma acquisendo il carattere della ripetitività possono creare grave disagio nella vittima. Inoltre, la molteplicità degli atteggiamenti ascrivibili al mobbing, rende non poco difficoltosa l’identificazione, il più possibile rigorosa, di un nesso causale tra i suddetti e i disturbi psicologici riscontrati dalla vittima. Anche perché nella maggior parte dei casi, il danno, non è determinato da un unico comportamento, ma da una serie di atteggiamenti scorretti, difficili da individuare, e nello stesso tempo da dimostrare. A causa di questa machiavellica opera di individuazione delle concause, l’atteggiamento sotto accusa, dovrebbe figurare come reato in re ipsa.
Tralasciando il tema delle modalità di accertamento del danno causati da mobbing – argomento troppo complesso per essere trattato in questa sede in modo esaustivo – nella determinazione dell’entità del danno si dovranno prendere in considerazione anche tutti quei malesseri secondari subentrati a causa di un disagio psicologico ed esistenziale più profondo, come il danno all’immagine, cioè perdita di credibilità, perdita delle relazioni significative, sentimenti di inadeguatezza nel ricoprire ruoli precedentemente svolti, ecc., anticamera del cd “secondo mobbing” o mobbing familiare (Ege H., 2002).
Recenti sviluppi giurisprudenziali
In tema di riconoscimento della fattispecie Mobbing illuminanti alcune ultime pronunce, la prima di queste è la sentenza di Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 maggio 2015, n. 10037, decisione ove gli ermellini hanno definito quelli che devono essere i sette parametri per il riconoscimento del danno da mobbing.
La Corte di Cassazione Sezione Civile aveva già affrontato il tema mobbing con una sentenza di qualche anno fa, la numero 22393/2012 del 10 Dicembre 2012[1]. Il provvedimento giurisdizionale forniva del fenomeno una definizione semplice e illuminante: «Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità».
Con il pronunciamento del 15 di maggio u.s. il consesso supremo tornando sull’argomento mobbing è riuscita a puntualizzare che ai fini del risarcimento per i danni patiti dal lavoratore sia necessario la sussistenza contemporaneamente di sette parametri, prova delle condotte mobbizzanti subite dallo stesso nell’ambito lavorativo. Nella sentenza viene rimarcato che «la Corte del merito pone a base del proprio decisum anche le risultanze della perizia, allegata agli atti, eseguita in sede penale da uno dei massimi esperti di mobbing che, esaminata la vicenda lavorativa della D.M. (la prestatrice di lavoro, n.d.r.) aveva riscontrato la presenza contestuale di tutti e sette i parametri tassativi di riconoscimento del mobbing “che sono l’ambiente, la durata, la frequenza, il tipo di azioni ostili, il dislivello tra gli antagonisti, l’andamento secondo fasi successive, l’intento persecutorio”, parametri questi di cui la Corte territoriale trova riscontro, come detto, nelle risultanze istruttorie». La fattispecie concreta su cui la Corte si è pronunciata riguarda una amministrazione pubblica (un ente locale) condannata a risarcire il danno alla salute e quello professionale patito da un’impiegata a seguito delle varie pratiche persecutorie concretizzatesi sul posto di lavoro: la stessa era stata privata delle proprie mansioni ed in conseguenza di ciò emarginata e trasferita senza ragioni plausibili da un ufficio all’altro. L’impiegata, poi, veniva subordinata ad un collega che in precedenza risultava essere suo sottoposto, in via ulteriore assegnata a un ufficio aperto al pubblico senza possibilità di poter lavorare, rendendo così ancor più dolorose le umiliazioni cui era stata assoggettata.
Ancor più esplicita sempre la Suprema Corte in una recentissima sentenza del 3 Luglio 2015 n. 13693: chiamata a pronunciarsi in relazione al danno subito da una dipendente in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro qualificati dalla stessa come mobbing, respingeva le lamentele spiegate per difetto di prova in ordine alla sussistenza della condotta vessatoria -presupposto indefettibile per la configurazione dell’eventus dammi e degli effetti risarcitori connessi-, inoltre, uniformandosi alla giurisprudenza più remota precisava come «ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr Cassazione Civile del 6 agosto 2014 n. 17698)».