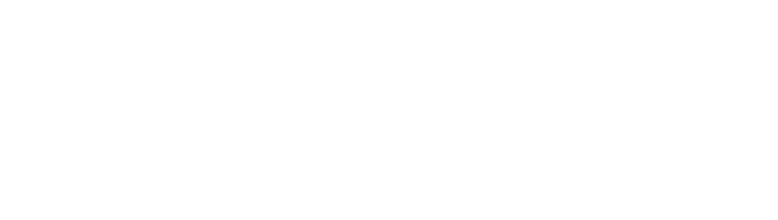La vulnerabilità della condizione umana: tra inermità e sopravvivenza
Hannah Arendt nel meraviglioso Prologo di “Vita Activa” – il suo libro fondamentale – decide di iniziare a lavorare attorno alla condizione umana partendo da un’insolita notizia: l’attenzione che i media statunitensi hanno posto all’evento epocale del primo satellite che è stato lanciato in orbita attorno alla terra nel 1957.
Così scrive: «Questo avvenimento, che non era inferiore per importanza a nessun altro, nemmeno alla scissione dell’atomo, sarebbe stato salutato con assoluta gioia se non si fosse verificato in circostanze militari e politiche particolarmente spiacevoli. Ma, per un fenomeno piuttosto curioso, la gioia non fu il sentimento dominante, né fu l’orgoglio o la consapevolezza della tremenda dimensione della potenza e della sovranità umana a colmare il cuore degli uomini che ormai, sollevando lo sguardo dalla terra verso i cieli, potevano scorgervi una loro creatura. La reazione immediata, espressa sotto l’impulso del momento, fu di sollievo per il “primo passo verso la liberazione degli uomini dalla prigione terrestre”» (Arendt, 1988, p. 1).
Il primo passo verso la liberazione degli esseri umani dalla prigione terrestre è affermazione attentamente registrata da Arendt e poi da lei stessa discussa filosoficamente. In piena guerra fredda e in pieno terrore della Bomba – lo spettro della distruzione totale dell’umanità aleggiava in una comunità internazionale che doveva ancora assorbire le ferite della Seconda Guerra mondiale mentre si accingeva ad adottare protezioni giuridiche sovranazionali per impedire all’umanità di ricadere sotto lo scempio di una disumanizzazione già portata a sistema industriale e burocratico di impensabile efficienza dal nazismo. Secondo Arendt l’affermazione di tutti coloro che vedevano nell’oggetto fabbricato che usciva dall’orbita, l’inizio di un futuro libero dalla prigione terrestre era in qualche modo un dire qualcosa che era nei desideri e nei pensieri comuni – una via d’uscita dal pericolo della distruzione totale, dal pericolo della fine, verso l’altrove. Scrive ancora: «La novità era soltanto che uno dei giornali americani più rispettabili riportò in prima pagina ciò che era confinato fino allora in una letteratura non precisamente rispettabile, la fantascienza (alla quale, purtroppo, nessuno ha ancora dedicato l’attenzione che merita come veicolo di sentimenti e di desideri di massa)» (Arendt, 1988, p. 2).
Nel libro dedicato all’analisi antropologico filosofica e politica della condizione umana, Arendt ci parla del valore della fantascienza come veicolo di immaginario collettivo. Ma in che senso si tratta di immaginario e come questa indicazione di Arendt può essere presa sul serio come invito ad accostarsi in modo filosofico a sollecitazioni che provengono dall’immaginario mediatico? Per rispondere a questa domanda sarebbe sufficiente ragionare con la molta letteratura alla mano sull’ impatto che i media hanno avuto negli ultimi decenni ed hanno oggi nell’orientare l’immaginario culturale; tuttavia è un fatto che la filosofia poco si è interessata di indagare a fondo le raffigurazioni dell’ umano culturalmente diffuse dai media, le trasposizioni, gli investimenti che la cultura non alta e veicolata da film e da telefilm, da romanzi gialli o di fantascienza, o di fantasy, ha prodotto a proposito delle aspirazioni o delle paure dell’umanità.
Anche se il messaggio in bottiglia di Arendt non è stato raccolto, la cultura degli ultimi sessanta anni è stata fortemente segnata da immagini dell’umanità e da proiezioni sulla post-umanità (robotica o extraterrestre) che hanno manifestato, a partire dalla ricerca di una uscita dalla trappola del pianeta che ci nutre e che ci dà vita, una serie diversa di istanze della modernità borghese e della loro configurazione tardo novecentesca. Di certo è servita la spinta della tecnica nel suo investimento prometeico moderno per pensare di uscire dalla trappola terrestre, ma dietro ad essa c’è lo spettro di una tecnica che ha prodotto la bomba atomica, di fatto l’unica effettiva minaccia alla vita su questo nostro pianeta. La deflagrazione della Bomba ben due volte in territorio giapponese, insieme alle disumanizzanti fabbriche della morte prodotte dal nazismo in Europa, sono state l’emblema di una umanità che si è scoperta vulnerabile, non nel senso del pericolo a cui può essere esposto ciascun essere umano o alla vita come esperienza finita, ma nella misura della specie, del nostro comune essere umani. Nel caso della Bomba, il potenziale di uccisione è quasi inimmaginabile – e il fatto che non abbiamo una grande documentazione fotografica è un dato del totale annientamento che produce; la contaminazione nucleare e la scia di morte che si porta con sé disegnano un territorio inabitabile, del tutto privo di possibilità di sopravvivenza umana e animale. Con la Bomba la Morte diventa immanente e persistente nel tempo.
Con la disumanizzazione della shoah, la ferita che è il vulnus da cui proviene la parola “vulnerabilità” diventa un insulto ontologico, una ferita all’essere stesso della nostra umanità. Sia la Bomba che la shoah, sono eventi ripetibili, per il solo fatto che la tecnica e la capacità organizzativa umana li ha prodotti e serializzati, la loro ripetibilità rende la ferita ontologica insieme all’annullamento della vivibilità di un territorio protratta nel tempo, due segnali-sintomi di una mutazione del senso stesso dell’umanità verso una consapevolezza nuova, quella di una vulnerabilità comune a tutti, perché nessun territorio è al riparo dal rischio di essere sottoposto ad un’azione seriale di distruzione del pianeta che ci dà la vita, come della nostra comune umanità. Lo scrittore David Grossman, ha fatto notare come la parola shoah, in ebraico, in yddish, o in qualsiasi altra lingua parlata dagli ebrei, è per lo più, “ciò che è successo laggiù” e non “ciò che è accaduto allora”, laggiù è un luogo che può essere ovunque e ovunque può succedere quello che è successo laggiù (Kotler, 2011, p. 72).
Simone Weil nel suo celebre testo L’Iliade o il poema della forza (pubblicato per i Cahiers du Sud nel numero di dicembre 1940 – gennaio 1941 dopo l’occupazione tedesca di Parigi) prefigurando i peggiori momenti che avrebbero infiammato l’Europa e riflettendo proprio sul topos della guerra nell’epica classica, descrive perfettamente la circolarità della ferita sulle vite e sui corpi dei contendenti alla guerra di Troia. Nella sua analisi della forza che anima la violenza umana non c’è esultanza per i vincitori, non c’è la misericordia per la fine dei vinti, perché non esistono vincitori o vinti, ma esperienze della forza agita e patita in una reversibilità senza scampo. E nel cuore dell’Europa occupata dai nazisti, nelle fasi iniziali della seconda guerra mondiale, quando ancora non c’erano le evidenze internazionali del progetto della soluzione finale e lontana era la meta della Bomba atomica, Weil si sofferma sulla vulnerabilità come segno ontologico dell’umanità rintracciabile sin dall’epica classica. «Nell’Iliade gli uomini non sono divisi in vinti, schiavi, supplici da un lato e in vincitori, capi dall’altro; non vi è un solo uomo che non sia in qualche momento costretto a piegarsi alla forza» (Weil, 2012, p. 51).
La forza è il destino di violenza che nell’economia dell’Iliade tiene insieme tutti, nessuno escluso: «Che tutti siano destinati per nascita a patire violenza è una verità preclusa alle menti degli uomini dall’imperio delle circostanze. Il forte non è mai forte in assoluto, né il debole è debole in assoluto, l’uno e l’altro però lo ignorano. Non si ritengono della stessa specie né il debole si vede simile al forte, né viene visto tale. Chi possiede la forza procede in un ambiente privo di resistenze, senza che nulla, nella materia umana che lo circonda, possa suscitare tra l’impulso e l’atto, quel breve intervallo in cui abita il pensiero. Dove il pensiero non ha posto, nemmeno la giustizia o la prudenza ne hanno. Ecco perché questi uomini armati agiscono con durezza da folli. La loro arma affonda in un nemico inerme, prostrato ai loro piedi; trionfano su un moribondo descrivendogli le offese che subirà il suo corpo; Achille sgozza dodici adolescenti troiani sulla pira di Patroclo, con la stessa naturalezza con cui noi recidiamo fiori per una tomba» (Ivi, pp. 54 – 55).
L’enorme potere di orrore che sprigiona da queste immagini era al centro dello sguardo di Simone Weil, ma non è tanto il sangue versato a fiumi, la violenza che non ha freno nello scempio dei cadaveri, a catalizzare l’attenzione, quanto il fatto di una comune – ma non consapevole – reversibilità, anzi di una condivisa condizione di dipendenza dalla forza che rende – inesorabilmente – Achille uguale all’ultima delle donne rese schiave, al più misero dei supplici. È come se Weil avesse assunto il ruolo di apripista nella rilevazione di un dato antropologico-politico ed etico diventato poi centrale nel dibattito novecentesco – la condizione umana è descritta sin dalle fonti del pensiero occidentale – come costitutivamente vulnerabile in relazione alla violenza di cui siamo capaci come umani – a partire da questo dato occorre rimetterla al centro e ripensarla. Il dato centrale è quello della violenza che si sprigiona nelle relazioni umane, amplificata e quasi spersonalizzata dalla guerra, che assume livelli di inumanità inquietanti, già a partire dal gesto di Achille a cui fa riferimento Simone Weil.
Diversa è tale considerazione da quella che ha portato Hobbes – all’origine del pensiero politico della modernità- a legare insieme vulnerabilità, uccidibilità e spinta all’autoconservazione nel quadro di una ipotetica infanzia dell’umanità prepolitica, in cui domina la legge dell’homo homini lupus. Nello sguardo di Weil e del pensiero successivo che ha indagato la vulnerabilità umana a partire dal calco in negativo della riduzione a inumanità, non è centrale la ricerca delle cause antropologiche della violenza, ma un riposizionamento della considerazione umana a partire dalla costitutiva e immanente vulnerabilità come apertura all’altro che è fonte di violenza ma anche di atteggiamento di presa in carico e di cura. Un’altra voce ci aiuta a entrare nel cuore del dibattito su questo tema, ed è quella di Joë Bousquet, poeta e scrittore ma anche ex militare che ha vissuto la ferita sulla propria pelle, o parafrasando Simone Weil, dentro la propria carne vivente (Weil, 2012, pp. 43 – 44). Costretto a vivere in un letto a causa delle ferite che un’azione bellica durante la grande guerra gli ha provocato alla colonna vertebrale, il poeta vive con se stesso come con un altro, ed è a suo tempo vivo e morto. Sdoppiato in un confronto continuo con l’altro sé, quello morto una volta per tutte e che lo guarda dal letto in cui è immobilizzato, Bousquet con enorme vitalità proprio da quel letto ripone nella sua vibrante scrittura una riflessione sulla vulnerabilità come condizione immanente della vita che lo rende molto vicino all’amica Simone Weil. Entrambi sono attenti a comprendere come il dolore dell’umanità si insinui della carne vivente di ciascuno e ciascuna.
Scrive Bousquet: «Porto in me un imbecille che nutro con la mia sostanza. In certi momenti mi fa talmente paura che lo chiamo il mio “morto” e pretendo di vedere in lui quell’essere di cui solo la morte mi libererà» (Weil – Bousquet, 1994, p. 19). L’imbecille che il poeta chiama anche il morto, non corrisponde al corpo ferito, ma all’uomo che non ha presentito la ferita, all’uomo che ha vissuto in guerra e ha ucciso come se quella ferita non fosse già presente ontologicamente nel suo destino, nell’immanenza della sua vita. Alcuni anni dopo queste parole, la voce di un altro poeta vissuto nella straniazione dell’internamento psichiatrico, Antonin Artaud, concepisce la figura del Corpo senza Organi, di quel corpo talmente aperto dalla ferita fisica e psicologica e ontologica dal reclamare per sé il superamento dell’unità, perché l’unità è impossibile da mantenere in ogni situazione dell’esperienza vissuta. E questa è propriamente la condizione del soggetto che viene espropriato del proprio corpo “da Dio e dagli altri”, solo in virtù del fatto che il proprio corpo è divisibile, smontabile in parti, in tendini, in ossa, vasi sanguigni, in una litania di separazioni, settorializzazioni, che ripetono nella fisicità quelle separazioni prima di tutto simboliche che ci separano ma anche legano indissolubilmente agli altri (Artaud, 1956 – 1994, volume XIX, 84, p. 101).
L’interrogazione etica: la figura dell’inerme
Che cosa ha a che fare la vulnerabilità con la figura dell’inerme? È ancora Simone Weil ad aiutarci nello sforzo di svolgere questa apparentemente complicata correlazione, svelando la sua originarietà ancora nei libri dell’Iliade. L’inerme è chi non ha più – o non ha mai avuto – il potere della forza tra le sue mani, chi è del tutto alla mercé della forza altrui, è ad esempio Priamo che si presenta non più come sovrano, ma come supplice, nella tenda di Achille. Priamo inerme è privato del suo ruolo sociale, la sua presenza in quel momento è quella di chi ha perso il contatto con la carne vivente che sussulta di fronte all’orrore. Scrive Weil: «Il sussulto è il primo segno di vita di un pezzo di carne vivente: la zampa di un ranocchio sussulta stimolata da un impulso elettrico. La vicinanza o il contatto con una cosa orribile o terrificante fa sussultare qualsiasi ammasso di carne, nervi e muscoli. Solo chi supplica in tal modo non trasale, non trema, non ne ha più diritto (…) lo spettacolo di un uomo ridotto a tal grado di sventura gela, quasi come gela la vista di un cadavere» (Weil, 2012, p. 44).
L’immagine del vecchio supplice, ormai privo di diritti di fronte alla forza, è l’antecedente di una serie di raffigurazioni della vulnerabilità che saranno poi analizzate da Primo Levi, Hannah Arendt e molti altri, che hanno ragionato attorno alla superfluità dell’essere umano compiuta nei campi di sterminio. Il calco in negativo dell’inumanità come privazione della carne vivente è la misura in termini di sottrazione della condizione umana prodotta una volta per tutte, dalla fabbrica della morte nazista. La filosofa italiana Adriana Cavarero sottolinea come la fabbricazione delle superfluità dell’essere umano compiuta nei campi di sterminio nazisti abbia prodotto la figura dell’internato come un inerme pervertito (Cavarero 2007, 105). L’inerme pervertito però è diverso da Priamo che supplice si accosta alle gambe di Achille per baciare e prostrarsi di fronte al nemico che gli ha sterminato la famiglia. Priamo è un uomo privato del suo potere, chiaramente vulnerabile, che però mantiene un rapporto forte con il suo passato e la sua storia, e il confronto che ha con Achille, un altro uomo a cui si rivolge parlando dolcemente del padre, attiva una relazione etica di empatia. L’empatia in questo caso è considerata come la ricostruzione nella immaginazione di qualcuno dell’esperienza di un’altra persona senza una valutazione etica di quella esperienza (Nussbaum, 2004, p. 364; Boella, 2006, p. 104).Achille allontana il supplice e si scioglie in lacrime, le parole del padre del suo nemico Ettore, gli hanno evocato l’immagine del proprio padre. Achille non viene mosso da simpatia, descritta da Aristotele come una dolorosa emozione relativa alla disgrazia o alla sofferenza di altri, il contenuto del suo pensiero non è lo stesso di quello del suo interlocutore (Retorica, 1385 b 13) ma l’empatia scaturita dalla figura del vecchio e dalle sue parole, è sufficiente perché Achille sia interrogato eticamente dalla presenza dell’altro.
A sollecitare la risposta etica di Achille, è la voce di Priamo, la storia che porta con sé nelle parole e che ne costituisce l’unicità anche nel momento in cui egli è un semplice supplice che bacia le ginocchia del violento assassino dei suoi figli. Come ci ricorda Adriana Cavarero: «Dato di un’esperienza quotidiana, la voce si offre come il principio elementare per un’ontologia dell’unicità che sia intenzionata a contrastare radicalmente la tradizione metafisica che si ostina in vari modi ad azzittire l’io in carne e ossa» (Cavarero, 1997, 30). In questa posizione l’unicità è vista come non in contraddizione con la vulnerabilità, ma in linea con essa, quale suo correlato. Nel momento della ferita e della violazione ontologica all’umanità – data dalla disumanizzazione – si spezza l’unicità e si produce il paradosso della ferita aperta, della piaga che non si rimargina e porta alla raffigurazione del Corpo senza Organi. Per Adriana Cavarero, sulla scorta del pensiero di Hannah Arendt, la vulnerabilità è condizione ontologica legata all’identità umana che presuppone sempre l’altro e che è pertanto paradossalmente identità relazionale. Noi in quanto esseri umani siamo esposti sin dalla nascita, siamo consegnati ad un’esposizione in quanto condizione dell’apparire agli altri (Cavarero, 1997, 31).
A partire dall’esposizione all’altro può essere pensata la vulnerabilità nella sua complessità di riferimenti, perché è sul corpo singolare e unico che si mette in relazione con gli altri che può essere inferta la ferita. L’essere singolare coincide con l’esistenza di ciascuno; non fa parte dell’essenza e quindi non appartiene alla metafisica o al mondo delle categorie universali, bensì alla scena politica ed etica, dove ciascuno che è nato esiste e si mostra all’altro esponendosi. Ma non tutti coloro che inermi e vulnerabili si espongono agli altri possono essere considerati uguali, la stessa Weil, sempre lavorando filosoficamente sull’Iliade, ci porta più avanti nella considerazione dell’inermità e della riduzione a disumanità possibile sotto il peso della forza – una riduzione che è stata riattivata in modo del tutto peculiare nei campi di sterminio. Così scrive: «(…) vi sono esseri più sventurati che, non morendo, diventano cose per il resto della vita. Nelle loro giornate non vi è alcun gioco, alcun vuoto, alcuno spazio libero per realizzare qualcosa di propria iniziativa. Non sono uomini che vivono più duramente degli altri o collocati socialmente più in basso di altri; è un’altra specie umana, un compromesso tra l’uomo e il cadavere. Dal punto di vista logico è contraddittorio dire che l’essere umano è una cosa; ma quando l’impossibile si fa realtà, la contraddizione diviene lacerazione dell’anima. Questa cosa aspira in ogni istante ad essere un uomo o una donna ma non vi riesce affatto. È una morte che si estende lungo una vita; una vita che la morte ha raggelato molto prima di averla soppressa» (Weil, 2012, p. 46).
Il soggetto ridotto a cosa nei campi di sterminio non aspira neppure a diventare uomo o donna, a lui o lei è stata tolta la condizione ontologica relazionale, è ormai ininfluente la sua permanenza in vita o la sua morte, è ininfluente riprendere le fila della sua vita passata, in modo diverso da quanto analizzato da Weil nell’Iliade, la «lacerazione nell’anima» esperita durante il percorso di permanenza nei campi, è diventata una ferita che non può essere più composta e che segna definitivamente un passaggio antropologico – ciò che è sempre rimasto illogico, è diventato realtà ancora un’altra volta e ancora per mezzo della forza espressa nella guerra. In questo frangente la vulnerabilità, quale segno ontologico e fisico dell’esposizione agli altri, è stata del tutto spazzata via perché paradossalmente totalizzata: l’inerme del campo di sterminio è il totalmente vulnerabile e la sua vita è senza valore alcuno perché è come se egli fosse morto, data la prossimità che ha quotidianamente con la morte, e data l’impossibilità di tornare indietro alla sua condizione di unico e irripetibile, possibilità a cui non riesce più a pensare.
All’essere umano come cosa rimane solo l’esposizione del suo corpo, che è unico, ma che è stato privato per sempre dell’irripetibilità propria dell’identità: ed è come se fosse un qualsiasi altro e non solo se stesso, un qualsiasi altro ridotto a cosa. Come riportare al centro di una domanda etica chi ha perso – perché ne è stato privato in senso duraturo – la sua condizione umana relazionale? Importante è seguire la strada che Weil, Arendt, ma anche Lévinas (1984), Ricoeur (1970) e altri autori ci hanno aperto. Pensare alla vulnerabilità dell’altro è pensare alla nostra vulnerabilità – nel regime di reversibilità che dall’analisi della violenza espressa in guerra emerge come dato ineludibile. Occorre riportare al centro il concetto di vulnerabilità allargandolo alle figurazioni diverse che ha assunto durante la storia del ventesimo secolo e tenendo l’attenzione sull’immagine della fragilità assoluta propostaci dall’inerme pervertito come prodotto del campo di concentramento.
Di fronte a chi ha perso ogni caratteristica di umanità, è il volto inteso ontologicamente come appartenenza alla nostra stessa specie, alla nostra stessa vulnerabilità, che può attivare una risposta di cura. Il fatto umano è quello dell’esposizione all’altro, che è anche non voluta, non cercata, ma che ci capita continuamente e che può sottoporci ad un altro che ci perseguita, che ci offende e ferisce. Ogni azione dell’altro ci interpella e ci suscita una risposta: il problema etico sorge di fronte alla risposta che segue la persecuzione e la violenza. Noi stessi possiamo cedere alla vendetta e alla violenza come risposta. Tuttavia se facessimo così non avremmo preso sul serio il dato di reversibilità e di reciprocità che ci proviene dalla vulnerabilità comune a tutti noi. Occorre riflettere sulla responsabilità individuale di fronte alla violenza che ci tiene uniti come uniti ci tengono la sofferenza e la vulnerabilità, e rifletterci anche tenendo l’occhio attento alle incertezze e alla cupezza dei nostri tempi. L’etica della cura può configurarsi come risposta all’esposizione dell’altro, non tanto perché la cura sia un’assunzione responsabile suscitata dal volto dell’altro, ma perché la capacità di cura fa parte della condizione umana, così come la vulnerabilità.
Sin dall’inizio «unico e immediatamente espressivo nella totalità fragilissima del suo esporsi, il nuovo nato ha infatti la sua unità proprio in questa totale e nuda autoesposizione. Tale unità è già un’identità fisica, visibilmente sessuata, e tanto più perfetta in quanto non ancora qualificabile» (Cavarero, 1997, 54); chi lo accoglie e lo accudisce, si mette nella relazione di cura, che è una relazione circolare. Tralasciando qui le tante complessità del dibattito sull’etica della cura e sul ruolo di cura improntato sulla figura della madre nelle società patriarcali (Gensabella Furnari, 2008), occorre comunque ragionare sulla reversibilità della cura, in una prospettiva di universalizzazione.
L’espressione della forza oggi: la figura del sopravvissuto
Abbiamo superato i dieci anni dall’11 settembre 2001 e chiuso un tempo dominato da una nuova consapevolezza, allo stesso tempo sociale, politica, economica, morale: anche se viviamo in paesi relativamente ricchi e pacificati, anche se la guerra, la violenza non attanagliano la nostra quotidianità, siamo comunque fragili, vulnerabili, tutto ci può accadere. Il trauma successivo all’attacco agli Stati Uniti, seguito dalle guerre in Asia e dalle bombe nelle capitali europee (Madrid, Londra), ha aperto una falla definitiva sulla certezza della invulnerabilità di fronte alla guerra.
Tutto quello che nella seconda parte del Novecento ha continuato a caratterizzare la vita di milioni di persone in Africa, Asia, Sud America, ciò che con una parola chiave la filosofa americana Judith Butler chiama la “precarietà della vita”, da quel fatidico 11 settembre 2001, ha fatto con prepotenza la sua entrata negli strati medio ricchi della società nord-americana ed europea.
In questi dieci anni il pensiero politico e la filosofia morale si sono impegnati a lavorare sulla questione della vulnerabilità umana, partendo da un punto fermo dell’antropologia filosofica: la consapevolezza della precarietà non più soltanto del settore lavorativo, ma quale condizione umana. Nietzsche scriveva che l’essere umano è un “animale non definito”, “non stabilizzato”, gli antropologi tedeschi hanno lavorato su questo punto importantissimo della filosofia nietzscheana studiando il rapporto dell’essere umano con l’ambiente esterno, la peculiarità dell’essere umano rispetto agli altri animali individuata come inadattabilità all’ambiente ma come progressiva e massiccia e sociale modificazione dell’ambiente perché con il tempo questo si adattasse alle limitazioni antropologiche. Ma se la spinta progressiva alla trasformazione di fronte alle sempre rinnovate sfide dell’esistenza è stata considerata come l’altra faccia della medaglia della precarietà dell’essere umano, oggi si è spezzato proprio il filo della proiezione in avanti.
Dal considerare la condizione di precarietà intesa come incompiutezza di un essere in continuo progredire, si è successivamente sottolineato l’aspetto della precarietà come incertezza verso il futuro, come condizione esistenziale di insicurezza e di limitazione, di estrema esposizione al pericolo. La precarietà è diventata nelle pagine della filosofa femminista Judith Butler (2004), la condizione di comune vulnerabilità del nostro essere umani, quindi del nostro essere tutti insieme accomunati da due elementi fondativi: l’esposizione del nostro corpo sempre feribile agli altri e il vivere l’esperienza della perdita (di persone care, di benessere, di salute, di beni materiali).
Oggi l’esperienza della perdita ha assunto profili nuovi di fronte al radicalizzarsi della crisi di precarietà vissuta da centinaia di milioni di persone nel mondo: la consapevolezza della perdita è immanente alla vita e apre a nuove paure collettive, piuttosto che a nuovi spazi di confronto e di rinnovata attenzione: sul cibo inquinato, sull’ambiente malato, sul rischio nucleare civile. Al culmine della paura si trovano le profezie millenarie sulla fine del mondo. Non vi è stato nulla di razionale nell’ansia collettiva che ha colpito il mondo globalizzato dell’informazione sul finire del 2012, la fine del mondo profetizzata dai Maya è stata vissuta con ansia collettiva amplificata dai media, in un modo, per certi versi opposto all’immagine scelta per iniziare il nostro percorso. Allora, come Arendt rileva, si pensava che un satellite spedito attorno all’orbita potesse rappresentare l’uscita dalla gabbia del pianeta minacciato; ora che il pianeta è completamente in balia delle minacce che sono diventate reali scenari di distruzione e invivibilità, la paura non ci porta a pensare ad una via d’uscita fuori dal nostro habitat. Qualcosa si è spezzato nell’atteggiamento prometeico della scienza, il futuro non è altrove, forse il futuro non c’è più di fronte al nostro immaginario[1].
Per aiutarci a rispondere possiamo ripartire dalla configurazione della forza, dall’immagine della violenza generalizzata e totalizzata nella guerra intesa come «il culmine dell’esperienza umana» (Alfieri, 2008, p. 9). e riprende, per svolgerla fino in fondo con coerenza partendo dalla considerazione di Elias Canetti secondo cui in guerra «si tratta di uccidere». Un approccio antropologico filosofico non può esimersi dal prendere atto di questo dato, la violenza sprigionata nella guerra è legata al dare la morte e all’essere uccisi, alla vulnerabilità. Ma c’è dell’altro dietro ad una considerazione originaria della guerra intesa come espressione della violenza di gruppo. Se si svolge un’analisi antropologico – filosofica dell’identità, in quanto dimensione collettiva che si coagula attorno ad uno spazio simbolico in cui è possibile costruire il senso del Noi, si può notare che il disporsi originario dei componenti del gruppo attorno ad un simbolo, che è di altra natura rispetto al loro essere viventi, innesca un processo di acquisizione di una identità collettiva.
La differenza originaria è necessaria in quanto svolge la funzione di fulcro attorno al quale si può dire di essere tutti uguali – ovvero tutti differenti. Il simbolo che sta al centro del cerchio, attorno a cui si costruisce l’identità, è un confine assoluto e un confine interno, un perno attorno a cui tutti i componenti del gruppo girano insieme. Per descrivere questo confine, che è allo stesso tempo «inaccessibile, intoccabile, privilegiato, impuro (…)», seguiamo l’analisi del filosofo italiano Luigi Alfieri, che sulla scorta del pensiero di Girard, lo identifica in una dimensione di sacralità (Alfieri, 2008, p. 26). All’origine dell’identità, quindi, non c’è un’autoreferenzialità iniziale che fonda il Noi, ma un girare attorno ad altro: «dunque diremo di essere quelli che hanno un non/noi comune. Un qualunque possibile non-noi comune. Un qualunque possibile non-noi, una qualsiasi dimensione del non-umano. Sarà spesso una dimensione animale. Chi siamo noi? Siamo i Parrocchetti. O gli Opossum. O i Lupi, i Leoni, i Gattopardi […]» (Alfieri, 2008, p. 27).
René Girard interpreta questo elemento differente come il frutto di una uccisione originaria e collettiva, laddove alla base dell’uguaglianza c’è la differenza primaria, quella che si stabilisce tra molti vivi e un solo morto. All’interno di una conflittualità diffusa all’interno del gruppo emerge un elemento di differenza più evidente che caratterizza un solo individuo, e su questo elemento si catalizza la violenza di tutti gli altri, che sono invece indifferenti rispetto a quella specifica differenza. Allora tutti coloro che sono uguali uccidono il diverso – che è vulnerabile – e così rendono manifesta la differenza originaria che è la Morte, rappresentata nello specifico dalla sua manifestazione, ovvero da quello che è un cadavere. In ogni uccisione che si ripete, ad essere uccisa simbolicamente è la differenza che catalizzava il conflitto, ma quella differenza è diventata la Morte. Al centro di questo cerchio della violenza sta la vittima che muore da innocente, quindi accettando la propria uccisione, senza la quale noi non saremmo noi, gli assassini, coloro che uccidono la Morte. Elias Canetti, al contrario, non identifica la violenza fondatrice della comunità con il sacrificio della vittima, ma interpreta la scena originaria in maniera capovolta.
Il confine è doppio: sia esterno che interno. Fuori c’è il Nemico che è il non-noi, la Morte esterna che assedia e che bisogna uccidere per poter rimanere vivi e uniti. Ma per uccidere la Morte esterna si ricorre ad un confine interno, che è anch’esso Morte, intesa come strumento per mantenere il gruppo entro il confine. Così scrive Alfieri: «È il tragico paradosso dell’obbedienza, il rischio estremo che viene corso da chi cerca definitiva sicurezza: per non essere uccisi si uccide, ma per poter uccidere bisogna essere uccisi. E’ così che intorno al centro si accumulano i morti, e per chi sta al centro non importa distinguere i morti altrui o quelli propri. Tutti i morti sono suoi, tutti lo rafforzano, lo innalzano, moltiplicano la sua capacità di diffondere intorno morte e obbedienza, e dunque ancora morte. In questa sopravvivenza, in questo vivere grazie ai morti e letteralmente sopra i morti, Canetti vede la sostanza del potere» (Alfieri, 2008, p. 33).
Come ricorda Alfieri, la posizione di Girard sulla vittima sacrificale e quella di Canetti sul doppio confine sono entrambe valide ma solo se prese insieme. La Morte è il confine esterno, ma è anche il confine interno, è un non-noi che sta dentro e fuori. E questo è tanto più evidente se posto in relazione alla guerra, come paradigma della violenza successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo i due orrendi estremi della morte seriale nei campi di sterminio nazisti e della Bomba atomica che ha cancellato due città del Giappone e ha lasciato dietro di sé la scia della contaminazione nucleare e della morte differita –, la guerra ha assunto una nuova dimensione. E noi continuiamo a funzionare come il gruppo originario, giriamo ancora attorno alla Morte, avendo diminuito le uccisioni che ora avvengono anche al di fuori dei territori in cui la guerra è combattuta.
Ora la Morte per antonomasia è la Bomba che potrebbe uccidere tutti definitivamente ma che tuttavia rimane virtuale: infatti, data la sua potenzialità annichilente, è il confine assoluto della nostra paura. Ma la guerra continua ad esistere, così come la condizione della “sopravvivenza”, strettamente connessa a livello simbolico alla morte degli altri. Il sopravvissuto è paradossalmente anche il suicide bomber, che nonostante la fine della propria vita, viene sublimato in una proiezione identitaria o in una visione del tutto escatologica – diventa il martire. Sopravvivere è uccidere perché «il corpo dell’uomo è cedevole, esposto alle ferite, e molto vulnerabile nella sua nudità. Tutto può penetrarvi; ad ogni nuova ferita gli riesce più arduo portarsi sulla difensiva; e in un attimo per lui è finita» (Canetti, 2004, p. 17).
Il segreto della forza che domina chiunque stia in guerra è proprio dato dal legame indissolubile che si stabilisce tra vulnerabilità e sopravvivenza. E le parole di Joë Bousquet sul modo in cui fu addestrato per il suo primo attacco, rendono bene la tragica realtà di tale considerazione: «Una raccomandazione! Divieto categorico ai combattenti di fermarsi presso i feriti. Nulla autorizza un soldato che si batte a raccogliere i lamenti o le raccomandazioni di un soldato che muore (…). Interrogai il tenente Houdard. Quell’eccellente Gesuita si dava cura di formare in me un uomo e contemporaneamente un ufficiale. “Il soldato che attacca” mi disse “appartiene alla sua missione, al suo dovere, appartiene alla grande battaglia che con stupore vede formarsi, è preda della sua immaginazione e del suo dovere. Non può disporre di sé. Parlare con un moribondo lo restituisce a se stesso e decompone la volontà che l’evento aveva generato in lui. Non è più l’uomo di quella impresa gigantesca. La pietà, la paura, fanno nascere in lui una coscienza e questa coscienza è totalmente dolore. A un uomo che ha da temere solo la morte, non si deve imporre la visione dell’agonia”» (Weil – Bousquet, 1994, p. 26).
Parlare con un moribondo sposta l’attenzione – letteralmente decompone l’attenzione dalla violenza dell’evento per portarla dalla parte della vulnerabilità comune e della condizione di inermità di chi è sottoposto alla forza e ne diventa vittima. Chi è scelto per sopravvivere, o chi vuole sopravvivere deve stare il più possibile lontano dal moribondo, perché la sua condizione di sopravvivenza esiste solo se lui stesso vivo troneggia di fronte ad un cadavere. Come ci spiega Canetti, l’esperienza della morte degli altri fa consapevole chi è rimasto in vita della sua potenza.
Così scrive: «Il vivo non si crede mai così alto come quando ha di fronte il morto, che è caduto per sempre: in quell’istante è come se egli fosse cresciuto» (Canetti, 2004, pp. 16 – 17). Oggi il sopravvissuto, è anche chi si ritrova, altrettanto paradossalmente, in piedi di fronte ad un morto che egli non ha ucciso, un morto che è per caso caduto sotto un’azione di guerra irregolare o a causa di un’esplosione di violenza. Il sopravvissuto è insieme all’inerme il segno della vulnerabilità, ma rappresenta la faccia opposta a quella dell’inermità. Solo tenendo al centro il concetto di vulnerabilità come dato ineluttabile della condizione umana si possono analizzare il sopravvissuto e l’inerme in quanto raffigurazioni contigue seppure divergenti per significato simbolico. A partire dall’integrazione di queste due figure può essere riavviata un’interrogazione etica che tenga insieme l’aspetto della violenza e quello della presa in carico di cura.
Bibliografia
Luigi Alfieri, La stanchezza di Marte, Perugia, Morlacchi, 2008.
Monia Andreani, Il terzo incluso. Filosofia della differenza e rovesciamento del platonismo, Roma, Editori Riuniti University Press, 2008.
Monia Andreani, Anatomia politica dell’orrore. La questione della vulnerabilità e la figura dell’inerme in Judith Butler e Adriana Cavarero, in Lorenzo Bernini e Olivia Guaraldo (a cura di), Differenza e Relazione. L’ontologia dell’umano nel pensiero di Judith Butler e Adriana Cavarero, Verona, Ombre corte, 2009, pp. 39 – 65.
Monia Andreani, Twilight. Filosofia della vulnerabilità, Macerata, Ev Edizioni, 2011.
Monia Andreani, Anatomia politica della guerra globale: le figure del “sopravvissuto” e dell’”inerme”, in Alberto Pirni (a cura di), Verità del potere, potere della verità., Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 153-163.
Hannah Arendt, Vita Activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 1988.
Aristotele, Opere Voll.1-11, Roma-Bari, Laterza, 2002.
Antonin Artaud, Œuvres complètes, Gallimard, Paris, 1956 – 1994.
Laura Boella, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Milano, Bruno Mondadori, 2006.
Judith Butler, Vite precarie. Contro l’uso della violenza in risposta al lutto collettivo, Roma, Meltemi, 2004.
Elia Canetti, Potere e sopravvivenza, Milano, Adelphi,2004.
Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Milano Feltrinelli, 1997.
Adriana Cavarero, Orrorismo. Ovvero sulla violenza sull’inerme, Milano, Feltrinelli, 2007.
Marianna Gensabella Furnari, Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
Sivan Kolter, recensione a Helena Janeczek, Lezioni di tenebra. In «Internazionale» n. 894 22/28 aprile 2011, Anno 18, p. 72.
Emmanuel Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Milano, Jaca Book, 1984.
Martha C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, Bologna, Il Mulino, 2004.
Paul Ricoeur, Finitudine e colpa, Bologna, Il Mulino, 1970.
Simone Weil, L’Iliade o il poema della forza, Asterios Editore AD, Trieste, 2012.
Simone Weil, Joe Bousquet, Corrispondenza, Milano, SE, 1994.
[1] Ho approfondito questo tema in un saggio dedicato alla trasformazione della figura del vampiro nella letteratura contemporanea e nell’immaginario filmico, soffermandomi sulle caratteristiche peculiari che assume il vampirismo oggi nei prodotti mediatici di largo consumo giovanile, in particolare nella saga di Twilight. La mia attenzione si è concentrata sugli aspetti legati alla mancanza di proiezione verso il futuro nei giovani che animano la saga statunitense scritta da Stephenie Meyer. Mentre Dracula voleva espandere il suo potere e ringiovanire, i giovani vampiri di oggi – pur belli e ricchi – sono fermi in un presente rassicurante e statico e anche per questo attraggono l’attenzione della ragazza umana che desidera – contrariamente ad ogni racconto sul vampirismo precedente – diventare vampira e fermare, così, la sua vita (Andreani, 2011).