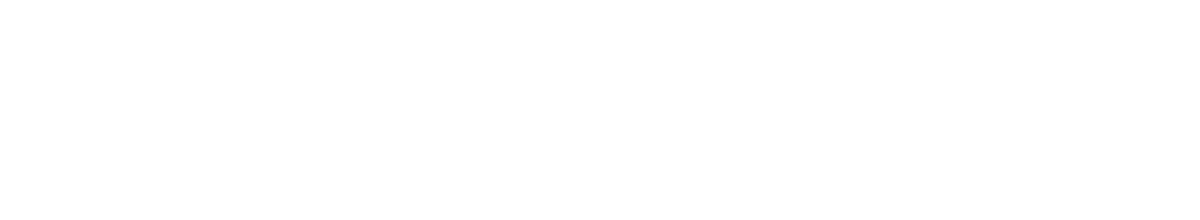L’evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e sammarinese
Il Codice penale italiano del 1930 (c.d. Codice Rocco) impiega il termine «plagio» in un’accezione del tutto inedita rispetto alla codificazione precedente. Il nuovo codice, infatti, pur confermando la collocazione della fattispecie plagiaria nell’ambito dei delitti contro la libertà individuale, ne riformula il contenuto rispetto all’analoga incriminazione dello Zanardelli[5]. L’art. 603 recita testualmente: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». Del lungo e travagliato dibattito che impegna la Commissione parlamentare in ordine all’opportunità di mantenere inalterato l’impianto normativo precedente rimane traccia nei lavori preparatori del codice Rocco. Il timore, diffuso tra i commissari e condiviso dai rappresentanti delle più prestigiose commissioni dell’Avvocatura del tempo, è che l’impiego di termini legislativi antichissimi per designare ex novo istituti sino ad ora sconosciuti generi confusione, alimentando una pericolosa indeterminatezza normativa[6]. La questione, che si traduce nella votazione di un ordine del giorno con cui si sollecita la fusione delle due fattispecie della «Riduzione in schiavitù» (art. 600) e del «Plagio» (art. 603) in un unico articolo, viene risolta dal Guardasigilli ignorando l’esito della consultazione. L’argomentazione addotta nella relazione al progetto definitivo richiama «il vantaggio indiscutibile della chiarezza e (…) la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte», come recita la Relazione al progetto del codice penale del 1930 (citata in Lemme, 1990).
La scelta del legislatore di rielaborare la tutela penale dello status libertatis – introducendo una previsione specifica accanto alla disciplina repressiva di qualsiasi posizione dominante correlata a quella servile (artt. 600-602) – è motivata dalla volontà di superamento della querelle sorta intorno all’art. 145 del Codice precedente, tesa a stabilire se per «schiavitù o altra analoga condizione» sia da intendere schiavitù come condizione di diritto, ovvero anche di fatto. L’analisi di Lemme (1990, p. 2) esprime compiutamente quanto accadrà nell’evoluzione giurisprudenziale del trentennio successivo all’entrata in vigore del Codice Rocco: «che la nuova incriminazione si riferis(ca) alla schiavitù di fatto, in contrapposizione a quella “di diritto” prevista negli artt. 600-602, (è) pacificamente accettato dai primi interpreti del nuovo codice, che, del resto, (sono) fortemente orientati in tal senso anche dalla relazione ministeriale al progetto del codice penale».
In virtù della novella legislativa, il plagio acquisisce una configurazione autonoma, parallela rispetto alla fattispecie della riduzione in schiavitù e qualificata dalla soppressione della libertà individuale indotta dal totale stato di soggezione della vittima. Tale soppressione deve ravvisarsi ogni qual volta si assista alla negazione della personalità della vittima, non essendo necessario, ai fini del perfezionamento del fatto reato, il completo annullamento di tutte le manifestazioni esplicative della libertà individuale. Da ciò discende l’impossibilità di escludere il plagio qualora alla vittima residui una qualche libertà di locomozione, di corrispondenza epistolare con terzi et similia. In proposito, si ipotizza l’identità materiale tra riduzione in schiavitù e plagio, stante la diversità delle due fattispecie solo in relazione al risultato: riduzione in condizione giuridica servile vs. riduzione in condizione di fatto servile (Manzini, 1964).
Alla sufficiente chiarezza in ordine al risultato dell’azione criminosa corrisponde una palese ambiguità sul versante delle modalità, penalmente apprezzabili, di conseguimento del risultato medesimo. Non a caso, la maggior parte della dottrina che si cimenta nell’attività interpretativa della norma, nel suo primo trentennio di vita, abbraccia la nozione di reato a forma libera[7] proposta dal Manzini (1964). L’incertezza esegetica che investe la fattispecie non manca di manifestarsi nelle pronunzie giurisprudenziali, tutte di segno assolutorio, con formula «perché il fatto non sussiste», «perché il fatto non costituisce reato» oppure perché il fatto non integra gli estremi del plagio, dovendo essere diversamente rubricato. In questa prima fase, dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nel privilegiare un’interpretazione teleologica della norma, che individua l’elemento distintivo, soprattutto rispetto al sequestro di persona ex art. 605 c.p., nello scopo di porre la vittima al servizio del plagiante, traendone un lucro o un profitto di altra natura. Il problema della materialità del fatto punibile viene, sostanzialmente, eluso (Lemme, 1990).
Le incertezze in ordine all’elemento materiale del reato – i.e. padronanza corporea o padronanza psichica esercitata sulla vittima – non consentono di pervenire ad un’interpretazione concreta ed univoca della formula normativa dell’art. 603 c.p., almeno fino alla pronunzia della Cassazione del 1961. La svolta avviene quando la Suprema Corte, accogliendo un ricorso per carenza di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato, dichiara espressamente la natura psichica del reato e dei suoi elementi costitutivi. La massima della sentenza di legittimità recita, infatti: «il reato di plagio consiste nella instaurazione di una assoluta soggezione psicologica del soggetto passivo al soggetto attivo in modo che il primo venga sottoposto al potere completo del secondo, con quasi integrale soppressione della libertà e dell’autonomia della persona» (Cass. pen., sez. II°, 26 maggio 1961, p. 151). La sussistenza dell’elemento materiale del reato deve desumersi dalla natura della relazione psichica tra i due soggetti, da accertarsi mediante un’accurata indagine sulle condizioni psichiche della vittima piuttosto che sulle sue «condizioni materiali di vita», le quali assumono valore di «mero riscontro indiziario». I presupposti di una siffatta presa di posizione andrebbero rinvenuti nell’evoluzione del contesto socio-culturale italiano del dopoguerra, unitamente alla diffusione dei primi studi sui diritti della personalità e ai timori in ordine all’impiego di nuove tecniche di persuasione di massa (Lemme, ?, p. 3).
L’inedito orientamento giurisprudenziale trova concreta applicazione nell’unica sentenza di condanna per il reato di plagio, pronunciata dalla Corte di Assise di Roma il 14 luglio 1968 a carico del filosofo Aldo Braibanti[8]. Confermata in appello e in Cassazione, è stata ribadita in altre due pronunce della Suprema Corte di poco successive (citate in Lemme, 1990, p. 3). Le motivazioni addotte dal giudice di merito, e riaffermate da quello di legittimità, chiamano in causa l’elemento del dominio psichico sulla vittima, al quale può eventualmente – e non già necessariamente – accompagnarsi una signoria materiale e corporale sulla medesima, tale da comportare la negazione della sua personalità a seguito della soppressione delle manifestazioni essenziali dello status libertatis. In merito all’azione del plagiante, questa può esplicarsi con qualsiasi mezzo, anche di natura psichica, in grado di annullare totalmente la libertà del soggetto di autodeterminarsi: «nel plagio, pertanto, non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la mente e l’anima, asservite al volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno pensieri ed emozioni proprie» (Corte App. Roma, 28 novembre 1969, p. 2).
La pronuncia suscita numerose polemiche, non solo in ambito medico-forense ma anche nella stampa non specializzata (Moravia, 1969) e nell’opinione pubblica, alimentando il dubbio che il biasimo, implicito nella sentenza di condanna, si appunti sulle tendenze omosessuali e sulle idee anarchiche dell’imputato. Si afferma, inoltre, come nelle relazioni interpersonali sia di frequente riscontro l’instaurarsi di condizioni di sudditanza psichica mediante la semplice suggestione (Corte Ass. Roma, sez. I°, 14 luglio 1968). Le posizioni del dibattito dottrinario dell’epoca vengono magistralmente riassunte nella monografia di Flick (1972), nella quale l’illustre giurista propone una ricostruzione del plagio in una prospettiva psicologica che valorizza la funzione di presidio della libertà morale, cui la fattispecie incriminatrice può validamente assolvere.