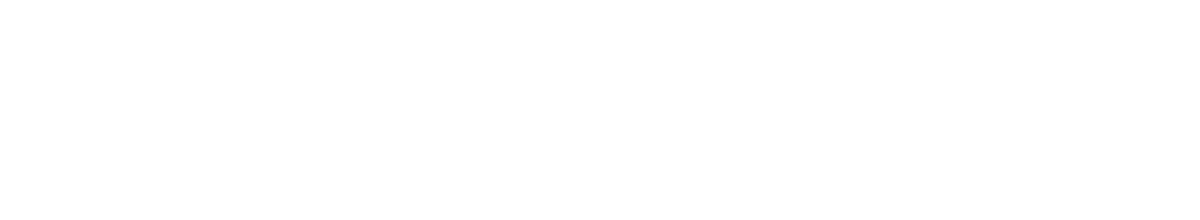Il profiling vittimologico nella scomparsa di persona
Il vero viaggio di ricerca non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere occhi nuovi (Proust)
La gestione della scomparsa di persona in territorio italiano[1] integra la missione istituzionale del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse: ufficio ad hoc di recente istituzione presso il Ministero dell’Interno, sulla scorta dei dati forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, elabora periodiche Relazioni di monitoraggio del fenomeno, garantendone una costante revisione quali-quantitativa, con ciò intendendosi la duplice attività di aggiornamento del dato numerico dei casi registrati e di inquadramento della tipologia di scomparsa (Marvelli, 2015). Inquadramento che manifesta le sue potenzialità anche qualora l’evento critico sia ascrivibile alla categoria dell’allontanamento volontario[2] e non, necessariamente, al perfezionarsi di un fatto-reato. Altrimenti detto, «pur considerando la possibilità che un PM decida che il fatto non costituisce reato, cionondimeno questa scomparsa deve essere contestualizzata da parte degli operatori istituzionali e tanto più il profilo dello scomparso appare chiaro tanto più si riuscirà a dettagliarne gli ambiti di riferimento trovando una risposta al perché una persona abbia potuto allontanarsi dalla propria famiglia e dalla propria comunità» (Rel. XIV, 2015, 6).
Opportunamente, il passo della Relazione sollecita l’elaborazione del profilo psicologico e comportamentale[3] della vittima di scomparsa, indipendentemente dalla motivazione sottesa all’evento critico (o presunta tale al momento della denuncia), al fine di «trarre elementi utili per una più proficua razionalizzazione e pianificazione delle operazioni di ricerca, intervenendo sui tempi e sulle risorse nonché immaginando e individuando “zone geografiche di probabilità di rinvenimento/ritrovamento”» (Rel. XIV, 2015, 13). L’analisi delle caratteristiche personologiche del soggetto, unitamente all’«individuazione di fattori vittimogeni (correlati) a variabili socio-culturali ed ambientali» (Rel. XIV, 2015, 14), dovrebbe successivamente confluire in un’apposita «scheda di “profiling” vittimologico […] atta a indicare fattori specifici e non (possibili e probabili) della causa di scomparsa» (Rel. XIV, 2015, 13). L’esplorazione retrospettiva della dimensione soggettiva della vittima – ossia quel processo finalizzato alla caratterizzazione psico-sociale dello scomparso mediante la raccolta di elementi anamnestici, che consenta di tratteggiarne un profilo di supporto all’attività investigativa (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006) – risponderebbe, pertanto, alla logica del rintraccio, consentendo agli operatori di circoscrivere strategicamente potenziali aree di ricerca. «I risultati attesi, dopo un periodo sperimentale congruo, integrerebbero standard e/o modelli di “profiling” vittimologico degli scomparsi che – validando possibili futuri protocolli operativi – migliorerebbero le performance di ricerca» (Rel. XIV, 2015, 14), così da contribuire al perseguimento della missione istituzionale del Commissario, ossia la «costruzione del sistema nazionale di ricerca delle persone scomparse» (Rel. XIV, 2015, 7).
Il c.d. fattore umano potrebbe rivelarsi, perciò, imprescindibile «patrimonio di conoscenza» del fenomeno in esame (Rel. XIV, 2015, 5), favorendo «la creazione di un metodo comune di lavoro utilizzabile dagli operatori e dalle diverse figure professionali (unitamente allo) sviluppo di un metodo standardizzato di scambio dati e informazioni su tutto il territorio nazionale» (Rel. XIV, 2015, 14). Come sottolinea il Commissario, difatti, «dalla scomparsa […] discendono tutta una serie di interventi, di tipo operativo e pratico oltre che di tipo sociale e psicologico» (Rel. XIV, 2015, 6), che postulano la costruzione di un’ipotesi sufficientemente attendibile in merito agli antefatti, a maggior ragione nei casi di morte violenta o dubbia, sia essa da imputarsi a cause suicidarie, omicidarie o accidentali (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006). Lo sviluppo di un protocollo operativo uniforme consentirebbe, altresì, il superamento della principale criticità in tema di investigazione retrospettiva[4] (Gulotta, 2008), ossia la mancanza di procedure standard, posto che ciascuna équipe decide come procedere nella raccolta e nella successiva analisi dei dati (Selkin, 1994).
Coerentemente, il Commissario auspica l’approfondimento di «campi innovativi, quali l’autopsia psicologica o il profiling psicologico delle persone scomparse» (Rel. XIV, 2015, 14), attingendo allo strumentario metodologico proprio della psicologia investigativa[5], intesa come «quella parte della scienza dei fatti umani in cui da un fatto se ne può inferire un altro, in particolare, da un accadimento è possibile inferire: che cosa e perché è successo; chi potrebbe esserne l’autore (se non lo si sa già); cosa potrebbe accadere nuovamente» (Gulotta, 2008, XXI). La scelta appare appropriata, posto che l’autopsia psicologica (AP) – sorta agli albori degli anni Sessanta, negli Stati Uniti, ad opera di Shneidmann e Farberow (1961) – rappresenta uno dei più recenti e accreditati approcci investigativi in tema di indagine retrospettiva (Gulotta, 2008; Picozzi & Zappalà, 2002).
La letteratura specialistica descrive l’AP come quella particolare forma di perizia psicologica, impiegata nei casi di morte violenta o dubbia, tesa alla raccolta dei dati relativi alla vittima, al fine di ricostruirne il profilo psicologico nonché lo stato mentale ed esistenziale prima del decesso, così da valutare le specifiche condizioni che possono essere co-occorse nella genesi dell’evento letale. Definita «una sorta di psicoanalisi post-mortem» – seppure in maniera azzardata, dal momento che «il più importante aspetto di ogni branca della psicologia è l’integrità del paziente e nel caso della autopsia psicologica il paziente è deceduto» (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006, 9) – essa consiste in una ricerca discriminativa di elementi e testimonianze provenienti dalla storia clinica, dalle relazioni sociali e affettive, dai rapporti professionali e da qualsiasi altra fonte qualificata[6], che consenta di elaborare una conclusione diagnostica fondata in merito agli antefatti del decesso, sia esso riconducibile a suicidio, omicidio o incidente.
In sostanza, essa consentirebbe di porre un’adeguata diagnosi differenziale in merito all’eziologia del decesso, pacifica la natura (altamente) probabilistica delle sue conclusioni. «L’autopsia psicologica […] tende a stabilire retrospettivamente lo stato mentale di una persona scomparsa nell’ambito di un determinato momento di interesse giudiziale (penale e/o civile), per chiarire la sequenza dei fatti, le modalità degli stessi, per dare una spiegazione sostenibile, concreta e conseguente ai fatti stessi». Più precisamente, «uno studio minuzioso dei fatti antecedenti, lo studio dei comportamenti e delle azioni precedenti del soggetto, lo scoprire le condizioni uniche e speciali che hanno determinato l’accaduto, consentirà agli investigatori di chiarire e dare una spiegazione fondata della genesi, del movente e della dinamica dell’evento» (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006, 10-11). La tipizzazione della vittima mediante la ricerca della c.d. informazione retrospettiva – con ciò intendendosi la ricostruzione della vita della vittima in senso biografico, enfatizzandone aspetti quali lo stile di vita, la personalità, gli stress recenti, l’enunciazione di idee
orientate alla morte, gli eventuali screzi psicopatologici, ecc. (Litman, 1989) – si dimostra procedimento tecnico irrinunciabile in numerose controversie legali e assicurative, presentando una varietà di utilizzi anche nelle investigazioni criminali, soprattutto nei casi di omicidio di cui si ipotizzi il carattere seriale.
Senz’altro apprezzabile è l’approccio multidisciplinare che la caratterizza, poiché «frutto di un lavoro interdisciplinare che vede coinvolti, in un minuzioso lavoro di esplorazione, psichiatri, psicologi, medici, investigatori di polizia e tra questi, ovviamente, gli intervistatori, a cui sarà affidato il compito di avvicinare le fonti dirette quali familiari, conviventi, amici, compagni di lavoro e quant’altri, in genere, ebbero relazioni e rapporti con la persona scomparsa o, comunque, con il soggetto di interesse giudiziale» (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006, 12). Il riconoscimento della fallacia di un qualsivoglia studio unidimensionale dell’essere umano – che trova compiuta espressione nella «teoria della complessità» di Morin, il cui postulato è da ravvisarsi nella diversità di istanze e motivazioni che animano la dimensione individuale – si riverbera, così, anche sul contesto investigativo, nella misura in cui facilita «l’accesso all’ambito giudiziale, nell’ottica, più generale, dell’avere la possibilità di dialogare e confrontarsi sui diversi aspetti che presentano i comportamenti umani» (Nunez, 1999 cit. da Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006, 18).
Ciononostante, l’AP non è risultata immune alle critiche metodologiche rivolte anche agli altri approcci di indagine retrospettiva (i.e. Equivocal Death Analysis, Criminal Profiling) – segnatamente per ciò che concerne l’assenza di protocolli standardizzati universalmente validi, a partire dalla necessità obiettiva di uniformare la raccolta di informazioni (Litman, 1968) – tanto da indurre i suoi sostenitori a riconoscere l’esistenza di un numero imprecisato di modelli investigativi differenti (Isometsä, 2001), di fatto coincidente con il numero di Autori che ne hanno proposto una variante (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006). Come a dire che la carenza di un modello strutturato e sistematizzato di AP rischiava di invalidare il procedimento stesso, inficiando i risultati ad esso riconducibili (Annon, 1995). In risposta a tali critiche, e con il dichiarato intento di uniformarne le procedure, un gruppo di ricerca cubano è approdato alla definizione di un modello integrato di AP – inizialmente denominato MAP (Modelo de Autopsia Psicologica), è stato ribattezzato MAPI (Modelo de Autopsia Psicologica Integrado) a seguito dell’incorporazione di ulteriori items rispetto a quelli originari, durante il processo di validazione dello strumento[7] – a partire da revisioni multiple dei modelli, delle scale di valutazione nonché delle Linee Guida e dei formulari tratti dalla letteratura specializzata e dai lavori precedenti (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006).
A differenza degli altri modelli, dal carattere semi-strutturato o aperto, il MAPI risulta interamente strutturato e sistematizzato, così da ridurre al minimo il margine di errore, prevalentemente riconducibile all’interpretazione soggettiva dei ricercatori (Gulotta, 2008). Gli operatori, infatti, sono tenuti ad un’applicazione rigorosa del protocollo operativo, «dovendosi attenere alle indicazioni di un manuale che contempla e richiede risposte prestabilite, al fine di evitare l’inclusione di elementi soggettivi nella valutazione di ogni caso e rendere verificabile e riproducibile da terze persone il risultato della ricerca» (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006, 16). Ne è scaturito uno strumento di esplorazione retrospettiva e indiretta della personalità, che contempla un’intervista strutturata, applicabile a fonti dirette qualificate[8] in un lasso temporale congruo (da due a sei mesi dopo il decesso della vittima), volta ad indagare una nutrita serie di items biografici, oltre agli antecedenti patologici familiari e sociali della vittima, preceduta da uno studio accurato del rapporto medico-legale e da una stretta collaborazione con gli investigatori, al fine di ottenere informazioni complementari sul soggetto di interesse giudiziale.
La previsione degli items contemplati sembra chiamare in causa il noto “principio di interscambio di Locard[9]”, posto che «la vita psichica dell’essere umano lascia tracce in molte forme, nell’arco della sua intera esistenza (documenti, diari, fotografie, l’abitazione, le forme di relazione con le altre persone, gli affetti, ecc.), ed è partendo da questa per quanto apparentemente ovvia considerazione che si attua il processo di autopsia psicologica. Questo processo inizia dal luogo dove è accaduto il fatto di interesse giudiziale, dove non possono sempre essere riscontrate tracce obiettive dai periti criminali, ma dove, comunque, permangono tracce “psicologiche”, tracce che restano impresse non solo nei luoghi dove soggiornò la vittima ma anche nelle persone che interagirono con la stessa» (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006, 17). Considerazioni rilevanti anche in relazione alle dinamiche sottese alla scomparsa e, segnatamente, sul piano delle interazioni soggettive della vittima che possono averne motivato, o quantomeno favorito, l’allontanamento (Marvelli, Massaro, Argentieri et al., 2011).
Pacifica la natura probabilistica dell’attività di profiling, l’applicazione del metodo di AP all’analisi della vittima di scomparsa potrebbe manifestare le sue potenzialità sul duplice versante del rintraccio tempestivo della medesima e della costruzione di una valida ipotesi di lavoro, tesa ad implementare il «sistema nazionale di ricerca delle persone scomparse» (Rel. XIV, 2015, 7). Orbene, in assenza di modelli di AP elaborati ad hoc, quella proposta dalla penultima Relazione potrebbe dirsi una vera e propria attività pionieristica, consistente nell’impiego di uno strumento investigativo post-mortem per tratteggiare un identikit tipologico dello scomparso, con l’intento di valutare l’indice di vulnerabilità e di rischio di categorie affini sul piano psico-comportamentale: il che richiederebbe, ovviamente, un opportuno “aggiustamento” dello strumento originario in ragione delle peculiarità dell’oggetto d’indagine. Altrimenti detto, se il presupposto applicativo del modello di AP è costituito dal decesso della vittima, nel fenomeno in esame si auspica il rintraccio in vita dello scomparso, ipotizzandone la morte solo in subordine: caso in cui il protocollo di ricerca dovrebbe favorire il rinvenimento del cadavere.
Ad apparire innovativo, quindi, non tanto lo strumento (Rel. XIV, 2015), al più poco utilizzato nel contesto forense europeo ma, certamente, non sconosciuto (Gulotta, 2008), quanto, piuttosto, il relativo ambito di applicazione. Del resto, tentativi di estensione della predetta metodica a contesti investigativi differenti da quello originario sono stati registrati con successo nei Paesi latino-americani[10] e non sembrano sussistere motivi ostativi ad un’analoga attività nella presente area di interesse. L’assenza di formulari, Linee Guida o altri strumenti di AP dedicati – la consapevolezza in merito è maturata all’esito della revisione bibliografica della letteratura specialistica – milita, dunque, in favore della costruzione di un modello apposito per lo studio scientifico di una categoria vittimologica di recente emersione, che vedrebbe così rafforzato il riconoscimento della propria identità.
Tanto premesso, occorre definire alcune pregiudiziali, p
rima fra tutte quella relativa all’approccio idoneo all’elaborazione dell’identikit tipologico dello scomparso. Attualmente, due sono le metodiche accreditate nel panorama scientifico internazionale, rispettivamente riassumibili nel metodo induttivo e in quello deduttivo. Il profiling induttivo, di origine statunitense, si avvale di riferimenti statistici; sfrutta processi di comparazione e correlazione; presuppone l’esistenza di un database, risultante dalla catalogazione di casi precedenti (i.e. tratti comportamentali, tipologia di vittima, ecc.), approdando ad un profilo probabilistico mediante la ricerca di similitudini con episodi anteriori[11] (Turvey, 1999).
Viceversa, il profiling deduttivo si realizza mediante un processo che richiede una dettagliata analisi dei pattern comportamentali co-occorsi nel singolo caso di interesse: il che postula l’esame minuzioso di tracce e indizi, non ultime le caratteristiche della vittima (Picozzi & Zappalà, 2002). Il carattere deduttivo della procedura sottesa al modello di AP risulta, perciò, incontestabile (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006). Inoltre, poiché il metodo induttivo si avvale di inferenze elaborate a partire da dati già a disposizione degli investigatori e posto che, nel caso di scomparsa, la creazione di un database dedicato riveste importanza prioritaria, quella dell’approccio deduttivo appare una scelta necessitata. Per quanto concerne la validazione dello strumento, la procedura potrebbe avvalersi della somministrazione di un apposito questionario allo scomparso, qualora ne avvenga il rintraccio in vita: in tal modo, infatti, l’informazione raccolta dalla vittima fungerebbe da conferma/disconferma delle ipotesi investigative formulate a partire dalle risultanze della denuncia di scomparsa. Una simile procedura di calibrazione, precedentemente suggerita in altra sede (Marvelli, Massaro, Argentieri et al., 2011), risulta, per giunta, condivisa anche dagli Autori che estendono l’applicazione dell’AP alle ipotesi omicidarie e accidentali, nell’ovvio caso di sopravvivenza della vittima (Bonicatto, Garcìa Pèrez & Rojas Lòpez, 2006).
Circa il reperimento delle informazioni inerenti l’evento critico, spunti di sicuro interesse potrebbero derivare dall’impiego della c.d. intervista cognitiva (IC): procedura originariamente sorta per la conduzione degli interrogatori (Canter, 2002) e rivelatasi utile anche per l’escussione testimoniale relativa ad episodi criminosi (Gulotta, 2008), migliorerebbe l’accuratezza delle dichiarazioni (Canter, 2002), specialmente qualora i dati raccolti dagli investigatori costituiscano l’unica fonte conoscitiva disponibile al momento della scomparsa. Ora, poiché tale metodica consta di strategie progressive di recupero guidato dell’informazione[12] (Gulotta, 2008), la sua somministrazione nell’immediatezza dell’evento target, quando, cioè, il dato mnestico appare ancora vivido e relativamente incontaminato, potrebbe accelerare il rintraccio della vittima: considerazione, quest’ultima, confortata dalla messe di studi relativi all’incidenza dei fattori cognitivi e metacognitivi[13] sul processo testimoniale (in termini di quantità e di accuratezza dell’informazione), sia nella fase di codifica e di immagazzinamento del dato mnestico che nella fase di richiamo del medesimo.
A tal proposito, infatti, la letteratura di merito non dubita dell’influenza del decorso del tempo sulla traccia mnestica, soprattutto nella fase compresa tra la codifica dell’informazione e la sua successiva rievocazione (De Cataldo Neuburger, 2000; Gulotta, 2002, 1987; Gudjonsson, 1992; Kassin, Tubb, Hosch et al., 2001; Loftus, Wolchover & Page, 2006; Pansky, Koriat & Goldsmith, 2005): Gulotta (2008), tra gli altri, riferisce come la maggiore compromissione della quantità del ricordo avvenga nell’arco delle prime 4 settimane dalla codifica dell’evento, mentre successivamente lo stesso pare subire un deterioramento più lento e graduale. Per ciò che concerne l’accuratezza, invece, gli effetti temporali sembrano essere variabili.
Tra i fattori cognitivi di indubbio rilievo, spicca quello della «salienza dell’evento target» (Gulotta, 2008, 131), in ragione del quale l’attribuzione di importanza soggettiva all’evento critico influisce positivamente sia in termini di qualità che di quantità di informazioni riportate. Coerentemente con tale assunto, l’accuratezza della testimonianza risulterebbe direttamente proporzionale all’investimento affettivo del dichiarante nei confronti della vittima, posto che la sua scomparsa rappresenta una cesura traumatica nel tessuto relazionale. Anche la conoscenza anteriore rispetto all’evento target incrementerebbe l’ampiezza informativa in ossequio al fattore dei «processi ricostruttivi», inteso come il bagaglio di conoscenze precedenti della realtà e del mondo maturate dal soggetto (Gulotta, 2008, 132); tuttavia, la cognizione pregressa potrebbe provocare effetti distorsivi sull’informazione stessa, peraltro amplificati dai legami affettivi con lo scomparso.
Tale circostanza permetterebbe di annoverare l’intervistato nella categoria dei soggetti «vulnerabili» in relazione allo stato emotivo, accogliendo la classificazione proposta da Canter (2002, 145), a parere del quale l’eventualità potrebbe essere affrontata impiegando procedure d’approccio centrate sulla relazione intervistatore/intervistato nonché sulle modalità di formulazione delle domande e di facilitazione delle risposte. Da non sottostimare nemmeno gli effetti degli stressors e degli stati emotivi concomitanti con la codifica dell’informazione correlata all’evento critico (Hilgard, Atkinson & Atkinson, 1975): «é dato ormai acquisito che lo stress ed altri stati di stimolazione emotiva migliorano le performance percettive fino ad un punto critico dopo il quale la codificazione peggiora […]. Il punto di stimolazione ottimale varia a seconda della complessità della codifica e dell’operazione sensoriale, più l’operazione è complessa, più la qualità della stessa verrà influenzata negativamente dall’azione dello stress», sebbene la performance ottimale coincida, generalmente, con livelli moderati di stress (Gulotta, 2008, 132). Ciò chiama in causa sia le modalità della scomparsa – si pensi, anche, al fattore della «qualità percettiva dell’evento» (Gulotta, 2008, 131), che giustificherebbe la riduzione dell’accuratezza della testimonianza in condizioni di illuminazione insufficienti (Busey & Loftus, 2007) – sia le motivazioni ad essa sottese: altrimenti detto, lo scenario di riferimento, rispetto al quale influirebbe negativamente anche il fattore della «attenzione allocata» poiché, come riporta Gulotta (2008, 131), «aumentare il carico attenzionale di una scena aumentando […] il numero degli agenti, riduce la quantità di memoria e diminuisce l’accuratezza».
Osservazioni analoghe valgono, altresì, per la «profondità di elaborazione» (Gulotta, 2008, 131): se è vero, infatti, che il testimone in grado di elaborare semanticamente lo stimolo ricorderà una mole più ampia di informazioni, è altrettanto vero che incontrerà maggiori difficoltà a discernere tra informazioni osservate e informazioni generate e/o attivate da processi connessi all’interpretazione dell’evento. Scarsamente significativi appaiono, invece, la «durata dell’esposizione all’evento target» – che correla positivamente l’accuratezza della testimonianza al protrarsi della medesima nel tempo – e la «intenzionalità della memorizzazione[14]», posta la dimensione improvvisa e repentina della scomparsa: la codifica accidentale, in modo particolare, incidereb
be negativamente proprio sulla localizzazione spaziale e sulla combinazione di caratteristiche, quali la forma e il colore (Gulotta, 2008), con ripercussioni facilmente intuibili sul reperimento dei dati inerenti alla vittima concomitanti all’evento critico (es. abbigliamento al momento della scomparsa).