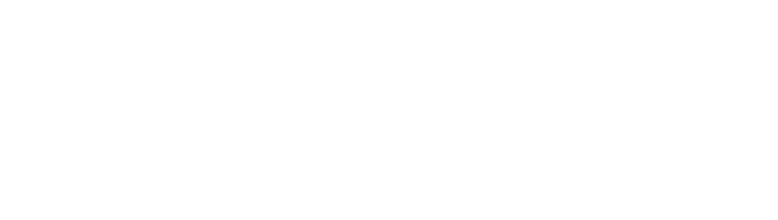Il linguaggio della violenza
Molti e complessi sono i fattori che regolano la condotta umana, poiché questa risente non solo delle esperienze soggettive ed ambientali, ma anche dei costituenti legati alla biologia del soggetto tanto che «negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato interesse per lo studio dei rapporti tra biologia e crimine, con particolare riferimento all’aggressività ed alla violenza. Tale “ritorno” alle interpretazioni biologiche della condotta antisociale è stato facilitato dalle sempre più numerose ricerche che cercano di identificare le basi genetiche, biochimiche e morfologiche del comportamento umano, sia normale sia patologico» (Gatti & Rocca, 2013). Un approccio, quello suscitato da queste nuove teorie bio-criminologiche, che però non deve essere letto in una prospettiva “deterministica”, all’interno della quale i fattori costituzionali svolgono un ruolo determinante nella caratterizzazione dell’essere umano (Rafter, 2008), piuttosto attraverso un lavoro sistemico e interdisciplinare che, studiando l’interazione continua di fattori genetici, neuropsicologici, ambientali e evolutivi, possa fornire una lettura interpretativa coerente della condotta umana.
Tenendo presente quanto sopra, ovvero di una possibile predisposizione ereditaria alla violenza, anche attraverso forme patologiche della stessa, esamineremo l’aspetto intergenerazionale e psicosociale dell’aggressività e della violenza. Da sottolineare che “aggressività” e “violenza”, non devono essere considerati sinonimi, poiché l’aggressività di per sé non prevede necessariamente la messa in atto di comportamenti violenti (Ferguson & Rueda, 2009); si parla di aggressività anche quando intendiamo descrivere una sfida con sé stessi o verso altri, come per esempio avviene in una competizione sportiva. Inoltre, essendo l’aggressività innata, questa ha perciò una base biologica che implica una serie di processi fisici e chimici che si attivano automaticamente consentendo, al soggetto, di entrare in uno stato di allerta e di difesa in caso di pericolo.
Una definizione biologica dell’aggressività data da Valzelli è la seguente: «una componente del comportamento normale che in forme differenti, a seconda dei finalismi da raggiungere e degli stimoli che la suscitano, viene messa in atto per rimuovere o superare qualsiasi minaccia all’integrità fisica e/o psichica, garantendo la salvaguardia del singolo e della specie, non risultando necessariamente, eccetto nell’aggressività predatoria, nella distruzione dell’oppositore» (Valzelli, 1989). L’aggressività si trasforma in violenza quando il soggetto non riesce a controllarla, modularla, adeguarla alle situazioni o a “sublimarla”; in questi casi può anche assumere aspetti di impulsività o irrazionalità quando è agita attraverso azioni potenzialmente criminali e/o afinalistiche.
Dal punto di vista psicologico la violenza è sostanzialmente una modalità, tra le tante, di entrare in relazione con l’altro. L’attitudine alla violenza è un costrutto ampio e complesso che non prevede distinzioni in ordine al sesso o al ceto sociale, va ricercata in quella “naturale” componente delle condotte umane codificate dall’aggressività. È, infatti, una modalità “espressiva” dell’aggressività quale reazione a vere o presunte ingiustizie subite. Questa, quindi, può non rappresentare soltanto l’esplosione di un conflitto, ma lo sfogo di insoddisfazioni, tensioni, rabbie, frustrazioni che possono essere originate precedentemente e/o trattenute fino alla loro manifestazione nell’azione violenta. Una forma di linguaggio originato dalla messa in atto di schemi mentali appresi da esperienze acquisite in famiglia e/o sociali, o se vogliamo una forma mentis quale elemento caratterizzante il comportamento messo in atto. La violenza, in questi termini, può essere intesa come l’acquisizione di modelli relazionali disfunzionali appresi dalle figure genitoriali. Siegel, per esempio, sottolinea come i bambini che assistono ad azioni violente all’interno della coppia genitoriale corrono un rischio maggiore di riproporla nelle loro relazioni da adulti (Siegel 2013).
Rapporto tra genitorialità e violenza
Da tempo il rapporto tra genitorialità e violenza è oggetto di studio, compreso come questa possa essere trasmessa, attraverso schemi comportamentali appresi, da una generazione all’altra. Particolare importanza è stata data ai modelli d’attaccamento e alla capacità di regolazione emotiva, in quanto fattori che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di una adeguata funzionalità relazionale fra gli esseri umani. In questo campo diversi sono i contributi della ricerca neurobiologica sul rapporto esistente tra violenza e regolazione emotiva (Briere, 2002; Gunnar & Fisher, 2006; Perry, 2009; Yates, 2007; Siegel, 2013), tali studi pongono l’attenzione su come la violenza possa essere connessa ad una disfunzione della regolazione emotiva, che non permette al soggetto di sviluppare le competenze necessarie per risolvere le divergenze e/o i problemi in maniera costruttiva.
Rapporto tra identità e violenza
Anche il rapporto tra identità e violenza è stato oggetto di studi e ricerche. Gli esseri umani ottengono le loro prime esperienze sociali e la realizzazione di competenze all’interno dell’ambiente famigliare. Bowlby, ad esempio, sostiene di come le esperienze infantili, prime fra tutte quelle relative all’attaccamento, siano codificate in sistemi di rappresentazione definiti modelli operativi interni (MOI) capaci di influenzare le successive relazioni costituendo, in questo modo, l’elemento di trasmissione intergenerazionale (Bowlby, 1996). Sempre secondo Bowlby «Nel modello operativo del mondo che ciascuno si costruisce, una caratteristica fondamentale è il concetto di chi siano le figure di attaccamento, di dove le si possa trovare, e di come ci si può aspettare che reagiscano. Analogamente, nel modello operativo del Sé che ciascuno si costruisce, una caratteristica fondamentale è il concetto di quanto si sia accettabili o inaccettabili agli occhi delle figure di attaccamento. Sulla struttura di questi modelli complementari l’individuo basa le sue previsioni di quanto le sue figure di attaccamento potranno essere accessibili e responsive se egli si rivolgerà a loro per aiuto. E […] dalla struttura di quei modelli dipendono inoltre la sua fiducia che le sue figure di attaccamento siano in genere facilmente disponibili e la sua paura più o meno grande, che non lo siano: di quando in quando, spesso, oppure nella maggior parte dei casi[1]» (Bowlby, 1975). Infatti, dal punto di vista cognitivo, al processo di formazione dell’identità personale concorre l’interiorizzazione dell’immagine che viene rimandata da altri. Alla costruzione dell’identità, quindi, contribuiscono fattori diversi, in particolar modo quelli collegati alle relazioni interpersonali, per cui pur esistendo un patrimonio nativo, ereditario e congenito, l’ambiente con le sue influenze comparteciperà in maniera significativa al suo adeguato sviluppo.
Esiste uno stretto rapporto fra l’identità e le peculiarità individuali del carattere e degli atteggiamenti. Ovvero tra identità e personalità. Quest’ultima può essere definita come l’insieme delle caratteristiche biologiche, psicologiche e sociali che individuano una persona nel suo modo unico di essere e di volere. La personalità è stata definita nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una «modalità strutturata di pensiero, sentimento e comportamento che caratterizza il tipo di adattamento e lo stile di vita di un soggetto, il risultato di fattori costituzionali, dello sviluppo e dell’esperienza sociale[2]». Ancora una volta viene sottolineato l’importanza, tra le altre cose, «dello sviluppo e dell’esperienza sociale», del soggetto in formazione, facendoci tornare al tema cruciale della rilevanza che le prime figure di riferimento, ovvero quelle genitoriali, hanno quale fondamentale nucleo primario relazionale. È, infatti, la famiglia la sede primaria dove si sviluppano le iniziali e più importanti interazioni sociali, la qualità delle stesse diviene perciò determinante per rendere socialmente competente un fanciullo. Ecco perché le possibilità di un ragazzo di interagire in modo “naturale” con gli altri dipendono inizialmente dalla competenza dei genitori. Il processo di adattamento avviene attraverso la partecipazione a routine sociali condivise e ripetutamente trasmesse da genitore a figlio nella normale interazione quotidiana. In famiglia il bambino impara sia ad interpretare le azioni e le espressioni sia a riprodurle egli stesso, sviluppando in questo modo una serie di capacità cognitive, sociali ed emozionali, attraverso le quali si mette in relazione con le persone ed entra progressivamente a far parte del suo ambiente. La famiglia è quindi il gruppo sociale primario dove il fanciullo riceve i suoi primi orientamenti nella vita, orientamenti che poi influenzeranno gran parte delle sue esperienze successive. Per cui modelli relazionali in cui l’espressione dell’affettività è strettamente connessa alla sopraffazione e dove l’uso dell’aggressività e della violenza non solo è ammesso ma anche giustificato, potrebbe condurre a reiterare la stessa, quale modalità di entrare in relazione con l’altro (Siegel, 2013).
Per approfondire la terminologia
Violenza: deriva da violare=infrangere i limiti. Il torcere con forza, lo spezzare, il limite o confine di una soggettività al fine di ‘piegarla’ al proprio volere. Ogni violenza è un abuso, ma non tutti gli abusi sono violenti.
Nell’abuso psicologico rientrano anche le Strategie di Persuasione:
Sedurre: lat. Sedūcere (sē) = via e (dūcere) = condurre. L’uso della seduzione, nell’intento di manipolare i sentimenti altrui con il proposito di «condurre» a sé, allo scopo di (ab)usare l’altro.
Abùso: lat. abūsus da ab-ūti (ab)=consumare, usare (ūti)=male =usare male. Un uso sbagliato (illecito), un’alterazione e/o il superamento non autorizzato, non voluto del limite proprio dell’uso. Nel rapporto con gli altri l’(ab)uso è ogni usoimproprio della relazione:
- È il superamento, con parole e comportamenti, del naturale confine interpersonale dallo spazio nel quale il corpo si muove.
- È entrare nella dimensione psico-fisica dell’altro e violare il suo diritto all’autodeterminazione.
- È alterare con azioni e parole la capacità di “percepirsi così come abitualmente ci si percepisce”.
- È l’attuazione di comportamenti che ledono il corpo e/o mortificano lo sviluppo psicologico dell’altro.
La violenza, all’interno della quale si consumano comportamenti abusanti, produce una identificazione vicaria che altera la percezione di fiducia e sicurezza del soggetto sottoposto ad essa. La percezione è un processo psicologico di creazione di un’immagine interna del mondo esterno. Si tratta di un processo cognitivo attraverso il quale gli individui raccolgono, organizzano e interpretano le informazioni dando loro un significato. Le emozioni influenzano la percezione della realtà, per cui influenzare gli stati emotivi significa influire sul processo decisionale. Le forme di riconoscimento sociale consentono la formazione dell’identità personale dell’individuo sul piano cognitivo, l’individuo interiorizza l’immagine che gli viene rimandata dagli altri, la interpreta, la accetta, la modifica o la rinnega, elaborando attivamente un’autodefinizione.
Rapporto tra violenza e trauma
Anche il suo rapporto tra violenza e trauma è stato lungamente indagato nel corso della storia, già nella Francia della fine del 1800 e la prima metà del 1900, il filosofo e psichiatra Pierre Janet (1859-1947), considerato il padre della moderna psicotraumatologia[3], indagava l’effetto frammentante e disorganizzante delle esperienze traumatiche, identificabili in base alle «emozioni veementi», sullo sviluppo affettivo e cognitivo dell’individuo. (Liotti & Farina 2011). Da allora molti autori si sono occupati del trauma psicologico e delle sue conseguenze psicopatologiche. Ancora oggi, quale riferimento della psicologia moderna e delle discipline affini, resta la Teoria dell’Attaccamento (Bowlby, 1996), quale approccio al problema del bambino traumatizzato e le sue conseguenze.
Chiaramente non tutti gli avvenimenti negativi causano un trauma, come del resto non tutti gli episodi traumatici generano l’intensa sofferenza psicologica dovuta ai sintomi post-traumatici. Tuttavia, ci sono condizioni all’interno delle quali l’individuo si trova a vivere «emozioni veementi», per usare il linguaggio di Janet, che innescano delle risposte fisiologiche capaci di “bloccare” l’evento traumatico “costringendo” il soggetto a riviverne le sensazioni, le emozioni e i pensieri, fino a perdere talora il contatto con il presente. Per cui quando ci si riferisce ad un trauma psicologico si intende una esperienza minacciosa, considerata insostenibile e inevitabile, di fronte alla quale il soggetto si percepisce impotente. L’eccesso di stimolazione, la paura e l’insostenibilità del dolore producono una reazione emotiva e corporea così densa da generare un’alterazione dello stato psichico della persona, che il cervello non riesce ad elaborare, causando un blocco delle funzioni integrative della memoria, originando una esperienza di disconnessione e disintegrazione, dando luogo a stati di coscienza dissociati e all’esclusione dalla coscienza delle esperienze traumatiche, poiché l’evento traumatico non essendo immagazzinato come ricordo, rimane separato dalle altre esperienze percettive e quindi non organizzate in maniera unificata.
Etimologicamente la parola trauma deriva dal greco dal greco τραῦμα = ferita, nel significato di “perforare”, “danneggiare”, “ledere”, “rovinare[4]. Contiene in sé un duplice riferimento: una ferita con lacerazione; uno shock violento sull’insieme dell’organismo (Laplanche &Pontalis, 1967).
Quando si parla di trauma psichico il concetto di effrazione diviene centrale nell’analisi antropologica della violenza; intesa come ferita con effrazione. L’immagine traumatica penetra nel profondo dell’apparato psichico permanendo al suo interno come “corpo estraneo”, riemergendo poi come stato emozionale e senso-percettivo, attraverso sensazioni somatiche, immagini visive, odori, suoni. L’esperienza traumatica, infatti è conservata sotto forma di:
- Ricordi angoscianti, ricorrenti e intrusivi, che comportano immagini visive, pensieri o percezioni, reazioni emozionali che si presentano sempre come minacciosamente attuali.
- Sogni e/o incubi ricorrenti dell’evento.
Ogni ri-attualizzazione del trauma conduce a un livello superiore di stress.
Il trauma deve esser riconosciuto per quello che è: la ferita della psiche durante gli stati di terrificante impotenza. Dopo “nulla sarà più come prima”.
Rapporto tra Intenzionalità e violenza
Parlare di violenza non può esulare dal concetto di intenzionalità. Concetto ripreso anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha definito la violenza come «l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del proprio potere […] tale da determinare lesioni fisiche, danni psicologici ed esistenziali, problemi nello sviluppo, morte».
A livello interpersonale, il principio costituente più rilevante per la violenza è rappresentato dalla relazione. Ogni relazione, per la sua funzionalità, necessita dell’elemento dialettico del confronto che mantenga un bilanciamento tra le parti. Relazione fondata sul rispetto reciproco e la cooperazione, finalizzata al raggiungimento di scopi comuni e valori condivisi. Viceversa, la violenza viene espressa quando un soggetto (o entrambi), è incapace di differenziazione, anzi la stessa è vista come una componente minacciosa della relazione stessa. La violenza, quindi, non è semplicemente la conseguenza di un conflitto, ma proprio il suo contrario: rappresenta un’inadeguatezza nello stare nel conflitto, ritenendo che la problematicità legata alla differenziazione sia colpevolmente dovuta alla persona stessa, che non accetta una risoluzione unilaterale del problema.
La riattualizzazione del contesto traumatico
L’ambiente famigliare è il luogo ove più di frequente avviene l’esposizione di un soggetto al trauma relazionale, spesso si tratta di minori costretti a rapportarsi con figure di riferimento trascuranti/abusanti e/o spaventate/spaventanti. Bambini intrappolati in relazionali disfunzionali, quanto paradossali, dovute alle esplosioni incoerenti di violenza, dove le figure di riferimento sono da un lato impotenti e disperate, dall’altro spaventanti e pericolose. Il loro mondo interiore, solitario e confuso, è caratterizzato dall’imprevedibilità e confusività, ovvero la coesistenza di paura, rabbia e desiderio di vicinanza, cosa che sfocia poi in comportamenti esternalizzati e internalizzati (Herman, 1992). Essi, quindi, sono costretti a sperimentare l’ambivalenza di una relazione che pur incutendo paura è al tempo stesso la fonte della loro sopravvivenza: nel conteso di accudimento il caregiver è contemporaneamente la fonte e la soluzione dell’allarme provato, ovvero una «paura senza soluzione» (Main, 2008).
Crescere in un contesto spaventante/abusante espone il minore a sviluppare gravi problemi cronici di regolazione emotiva e di controllo degli impulsi, oltre, e non solo (la lista sarebbe lunga), dei sistemi cognitivi e degli schemi relazionali o più propriamente, modelli di sé-con-l’altro (Liotti, 2001). Resta evidente che le memorie dei vissuti infantili (Bowlby, 1996) influenzeranno le successive relazioni, costituendo gli schemi di rappresentazione mentale (MOI), dell’esperienza precoce vissuta, che costituiranno la matrice per le interazioni successive, realizzando l’elemento di trasmissione intergenerazionale delle modalità interpersonali genitoriali acquisite. Infatti, «l’attaccamento che emerge nelle prime fasi della vita, continuerà a caratterizzare il rapporto figura di attaccamento-bambino anche in seguito, ma in forme via via più mature» (Ferraris & Oliverio, 1992).
Ovviamente non tutti i minori che hanno vissuto esperienze di violenza domestica poi riprodurranno lo stesso schema nella loro vita. Sarebbe errato pensare che la mente umana una volta strutturatasi secondo certi modelli operativi interni, sui quali il soggetto organizza le proprie relazioni sociali, perda ogni possibilità di cambiamento successivo. Dobbiamo sempre tenere presente che le rappresentazioni mentali hanno un carattere dinamico, che se confutate da esperienze successive possono venire riformulate (Grazzani, 2014), ma è indubbio che un elemento rilevante della riattualizzazione del contesto traumatico sia una delle cause principali della violenza intergenerazionale.
La violenza come forma di Linguaggio
Quando l’azione violenta viene trasmessa da una generazione all’altra attraverso la sua ripetitività o il suo ciclo intergenerazionale, diviene una forma di linguaggio originato dalla messa in atto di schemi mentali appresi da esperienze acquisite in famiglia e/o sociali. La modalità violenta diventa l’unico canale espressivo appreso nell’infanzia, essa prende il posto della destrutturazione del mondo interiore e della sofferenza che ne deriva.
I figli, vittime indirette, assistono impotenti alla violenza perpetrata sulle figure di rifermento, anch’esse impotenti di fronte all’evento violento. Allo stesso modo i figli, vittime dirette, subiscono impotenti la violenza perpetrata su di loro, osservando le figure di rifermento «inermi-impotenti» davanti alla violenza subita. L’angosciante terrore dato all’evento violento produrrà nel bambino conseguenze psichiche importanti (anche di natura patologica). Per cui, come abbiamo già esposto, alla base di un comportamento violento/abusante c’è quasi sempre un trauma, una ferita violenta o meglio una ferita con effrazione che per sua natura, o vastità, non ha potuto essere:
- Né Assorbita.
- Né Elaborata.
- Né Riformulata.
La violenza traumatica o trauma psichico definito anche il dolore degli impotenti (Herman, 2005), genera innanzitutto terrore, sgomento, sentimento d’impotenza che altera la percezione di Sé e dell’Altro, spesso in modo pressoché definitivo, dando luogo a varie modalità comportamentali disfunzionali, fra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Autolesionismo.
- Riproduzione del ruolo di vittima.
- Riproduzione di violenza/abuso.
Per quanto riguarda la riproduzione di comportamenti violenti/abusanti, l’esperienza continuativa di impotenza (Malacrea, 2006), oltre a provocare problemi di tipo comportamentale, come per esempio una maggiore aggressività, può essere associata a minori competenze sociali e prosociali. Queste sono accompagnate anche da difficoltà di regolazione emotiva, compresa la tendenza ad attribuire agli altri intenzioni ostili e la messa in atto di un meccanismo d’azione, quale espressione di un contenuto psichico improrogabile, non verbalizzabile per l’incapacità a tradurlo in pensiero. Una forma di linguaggio originata da una forte tensione interna, dove l’agire diviene elemento catartico: il comportamento agito, infatti, porta alla luce, come una valvola di sfogo che scarica l’angoscia, un problema inconscio non altrimenti gestibile a causa un deficit della capacità di mentalizzazione (Allen e Fonagy, 2008), che ha invalidato la trasformazione e l’arricchimento di nuovi termini ed espressioni capaci di descrivere e comunicare, con il linguaggio delle parole, un’interiorità sempre più articolata e complessa, come quella dell’età adulta. Questo impedimento espressivo, di fatto, preclude la via di uno sfogo verbale e facilita il passaggio all’atto, un agito che tuttavia veicola un’intenzione, sebbene inconscia, di mettersi in relazione con l’altro. Il soggetto, inoltre, tenderà, come conseguenza di una carenza dell’incapacità di procrastinare il passaggio all’azione, ad avere una scarsa attitudine ad assumere una posizione riflessiva e attiva orientata alla soluzione dei problemi o alle possibili conseguenze negative delle proprie azioni.
Il fallimento della funzione riflessiva (Fonagy et al. 1991; Fonagy, Target 2001), ovvero dei processi psicologici sottostanti la capacità di mentalizzare, conduce all’inabilità del soggetto di compiere adeguate riflessioni sul proprio e l’altrui comportamento, attività che sottostà la competenza di capire gli stati mentali, in termini di sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri. È la funzione riflessiva che permette all’individuo di riconoscere le azioni violente per quelle che sono, impedendo in questo modo di identificarsi con l’aggressione. Funzione che viene acquisita attraverso il rispecchiamento emotivo, o un rispecchiamento con le figure genitoriali che trasmettono al bambino di essere in grado di differenziarsi da loro quale individuo pensante, dotato cioè di intenzionalità. La mancanza di rispecchiamento emotivo non permetterà al bambino quella comprensione condivisa che costituisce la base del Sé riflessivo, ma al contrario «conduce infatti l’individuo a percepire eventuali maltrattamenti subiti o la carenza di cure genitoriali come conseguenza della propria indegnità; se l’abuso non viene ricondotto all’intenzionalità specifica di chi lo compie, i sentimenti di vergogna, di rabbia, l’identificazione con l’aggressore e lo sviluppo di modalità altrettanto violente nella vita adulta diventano elementi centrali nella descrizione clinica del trauma[5]».
L’identificazione con l’aggressore quale modello comportamentale (Bandura, 1973), verrà percepito dal soggetto come funzionale allo scopo desiderato, diventando elemento centrale nel processo di sviluppo. Il ricorso all’agito violento diverrà quindi un abito mentale, o una forma mentis quale elemento caratterizzante il comportamento messo in atto, che per la sua ripetitività o del suo ciclo intergenerazionale, rappresenta una forma di linguaggio tramandata da soggetto a soggetto. Condotta che solo raramente viene compresa dal soggetto come riattivazioni seriali di eventi accaduti in passato.
Il ciclo della violenza
L’intenzione del violento è garantirsi e conservare potere e controllo sulla vittima, infliggendole sistematicamente un trauma psichico, allo scopo di distruggerne la coscienza del sé e dell’Altro da Sè, limitandone contemporaneamente la libertà di scelta, al fine di perpetuare lo squilibrio di potere (Herman, 2005). Lo scopo ultimo è quello di convincere che la vita della vittima dipenda dall’ottenere misericordia attraverso la sua totale sottomissione. Deve esserle chiaro che egli è onnipotente e che quindi ogni resistenza è inutile poiché la sua vita dipende totalmente dalla sua volontà: qualsiasi minaccia all’equilibrio, determinato e stabilito, può essere controllato e ristabilito con un ciclo crescente di punizioni. “correzioni” che possono, in escalation, andare da intimidazioni e minacce a esplosioni vere e proprie di violenza.
La violenza e l’abuso possono assumere molte espressioni, o motivazioni intrinseche, alcune intenzionali altre non del tutto consce al suo esecutore.
La violenza «risarcitoria»
Il bisogno inespresso e non riconosciuto dal soggetto di risarcimento, che si manifesta con sentimenti di rabbia, rivalsa e bassa tolleranza alla frustrazione, mina le relazioni interpersonali distorcendole, riattivando il ciclo della violenza. In questo circuito vanno inseriti ed esplorati i cosiddetti sentimenti negativi. Il bisogno di risarcimento nutre la motivazione del suo agire negativamente nei confronti dell’altro, è il motore, di cui la rabbia è il carburante, che rappresenta la stabilizzazione di un sentire negativo che cerca il suo oggetto di rivalsa.
La violenza «riparatrice»
La violenza riparatrice figlia del risentimento, consegue la finalità di punire il soggetto–oggetto ritenuto possessore di aspetti positivi di cui lui si sente deprivato. Quale soggetto danneggiato ha il diritto di rivalersi e di invertire il suo ruolo con quello del proprio sostituto-offensore, affliggendogli umiliazioni e procurandogli la percezione di avere un debito che non potrà mai essere estinto.
La violenza «predatrice»
Nella violenza predatrice realizza il trionfo della volontà e l’attuazione del possesso (es. stupro). L’atto violento si manifesta con il repentino ed irresistibile impulso non a conoscere l’altro, ma ad impossessarsi dell’altro. La de-umanizzazione del soggetto-oggetto, fa parte della quota di aggressività e rabbia, insita nel gesto violento predatorio.
Violenza e potere
Il bisogno di risarcimento o il sentimento di rivalsa portano il soggetto al desiderio di riappropriarsi del controllo e del potere della relazione, invertendo il proprio ruolo di vittima impotente, con quello dell’aggressore capace, (potente) di sottomettere l’Altro alla sua volontà. Infliggere sofferenza e umiliazione al sostituto-offensore, diviene segno di emancipazione dal proprio ruolo di vittima impotente e l’attestazione del potere conquistato. Le varie teorie sotto esposte che, in sintesi, descrivono le trasformazioni graduali della vittima assoggettata ad un legame traumatico, devono essere lette non solo con uno sguardo attento all’evoluzione o meglio involuzione dell’identità della vittima, ma anche con un’attenta analisi di quello che rappresenta per l’aggressore/abusante e quali bisogni e/o desideri ne soddisfa, alla luce di quanto sopra esposto.
Teoria del «Legame Traumatico» (Carnes, 1998)
Conosciuti anche come legami di tradimento, i legami traumatici si formano quando un membro della relazione abusa ripetutamente delle risorse emotive e psicologiche dell’altro. Il legame traumatico è caratterizzato dalla formazione di potenti attaccamenti emotivi all’interno di una relazione abusante. Si verifica mediante un atteggiamento positivo nei confronti dell’aggressore e/o abusante. Si manifesta attraverso un bisogno di rimanere o ritornare dall’abusante nonostante i danni inflitti. Le relazioni disfunzionali causano anche legami traumatici poiché, le stesse, sono intervallate da periodi di apparente “normalità”. L’ambiente in cui si verifica un legame traumatico implica intensità, complessità, incoerenza ed una promessa. Le vittime rimangono perché si aggrappano a quella ‘promessa’ e/o speranza nella sua realizzazione. C’è sempre una manipolazione attiva anche se spesso invisibile. Le vittime ‘prede’ della manipolazione sono disposte a sopportare qualsiasi cosa nella speranza di realizzare quella promessa. Speranza, sempre presente, poiché rappresenta l’adempimento di un intimo e profondo bisogno della vittima.
Teoria della «impotenza appresa» (Seligman, 1995)
L’impotenza appresa, tradotta anche come sensazione di sfiducia persistente e totalizzante, nella possibilità di controllare gli eventi, si manifesta con sensazioni di ansia, depressione, apatia. Il dolore dato dal trauma psichico incontrollabile e non superabile, determina il trasferimento del proprio senso di impotenza da una situazione a quella successiva. L’impotenza appresa viene fissata dall’esperienza fallimentare di ripetute prove di sottrarsi alla sofferenza. Il percepirsi impotenti di fronte ad eventi vissuti come incontrollabili, porta conseguenze che vanno al di là di ciò che ha originato questa stessa percezione. Il senso di rassegnazione, generalizzato e interiorizzato, diviene un tratto della personalità acquisita. Si caratterizza con un’anomala passività, un senso di impotenza che porta ad un esaurimento delle proprie energie. Con conseguente instaurarsi di una condizione di immobilità e di assenza di qualsiasi tentativo finalizzato al sottrarsi al dolore o alla frustrazione.
Tre i Tipi di Deficit che fanno seguito a questo tipo di esperienza
- Deficit motivazionale: diminuisce la spinta ad attivare nuovi comportamenti e viene meno la motivazione a far fronte a minacce e ad eventi nocivi.
- Deficit cognitivo: aumenta la difficoltà nei nuovi apprendimenti a causa della perdita di fiducia nelle relazioni affettive, per cui l’idea dominante è che “tanto non serve a niente”, “tanto andrà male anche questa volta”.
- Deficit emozionale: si apprende che gli eventi non possono essere controllati. La paura iniziale svanisce e viene sostituita da frustrazione e depressione.
Teoria della «disperazione appresa» (Walker, 2017)
La disperazione appresa, ovvero il senso di paralisi ed anestesia sperimentato dalle vittime di violenza, all’interno di una relazione intima/famigliare. La vittima si arrende e prende come assoluta la visione del mondo del carnefice. Si trova a percepire il mondo attraverso gli occhi del suo aguzzino: lo legge come lo leggerebbe lui, si considera come la considera lui. Questo pensiero altrui rimane nell’ombra, ma onnipresente e acquisisce una densità psichica, ostacolando il percorso del pensiero proprio. La vittima, prigioniera della propria sottomissione, garantita dalla sopraggiunta dipendenza psicologica, viene sottoposta in maniera sistematica e ripetitiva al trauma psichico. L’obiettivo perseguito, dal carnefice, non è solo che venga dimostrata assoluta fedeltà e obbedienza, ma anche una volontaria rinuncia a tutto ciò che esula dal rapporto di coppia. Le vittime hanno descritto situazioni in cui erano convinte che sarebbero state uccise e risparmiate all’ultimo momento. Dopo ripetute sospensioni della “pena di morte”, la vittima può giungere a considerare il persecutore, paradossalmente, come il suo salvatore e provare verso di lui un sentimento positivo, fino alla convinzione di amore.
Agli occhi della vittima il maltrattante apparirà onnipotente e si convincerà che la propria vita è nelle sue mani. La paradossale conseguenza è il sentimento di gratitudine della vittima per il semplice fatto di essere lasciata in vita o di non essere gravemente lesa. La vittima è definitivamente spezzata. De-umanizzata, rinuncia alla vita per procede nella quotidianità in una sorta di automazione.
La de-umanizzazione del soggetto-oggetto, rappresenta il trionfo del predominio, la prova certificata del potere riconquistato, quale ‘giusto’ compenso della deprivazione subita in passato. Quale danneggiato non può chiedere al diretto (o diretti responsabili) di ricostituire la situazione, di fatto, antecedente al procurato trauma, per cui con modalità ascrivibile ad un seriale individua la vittima sostituta che dovrà risarcire e/o riparare, il danno subito. Un danno che lo ha reso incapace di provare fiducia, empatia o rimorso e che, quindi, per sua natura non troverà mai possibilità di risoluzione, se non con una presa di coscienza e una conseguente volontà di cambiamento, attraverso una adeguata richiesta di aiuto. Se questo non accade l’azione violenta, quale forma di linguaggio, continuerà probabilmente ad essere trasmessa da una generazione all’altra, attraverso la sua ripetitività o il suo ciclo intergenerazionale.
Bibliografia
Allen, J.G., & Fonagy, P., (2008), La mentalizzazione. Psicopatologia e trattamento, Il Mulino.
Bandura, A., (1973), Aggression: A Social Learning Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bowlby, J., (1975), Attaccamento e perdita. Vol. 2: La separazione dalla madre, Boringhieri.
Bowlby, J., (1996), Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento, Cortina Raffaello.
Briere, J., (2002), Treating adult survivors of severe childhood abuse and neglect: Further development of an integrative model, In J. E. B. Myers, J. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny, & T. A. Reid (Eds.), The APSAC handbook on child maltreatment (2nd ed.), Sage.
Buccoliero, E., & Soavi, G., (2018), Riconoscere le vittime. In E. Buccoliero, & G. Soavi, Proteggere i bambini dalla violenza assistita (Vol. I), FrancoAngeli.
Carnes, P.J., (1998), The Betrayal Bond: Breaking Free of Exploitive Relationships, Hci.
Erikson, E., (1982), I cicli della vita, Armando Editore
Ferenczi, S., (1933), La confusione delle lingue (2002). Tr. it. In Opere Raffaello Cortina.
Ferguson, C.J., & Rueda, S.M., (2009), Examining the validity of the Modified Taylor Competitive Reaction Time Test of ag- gression. Journal of Experimental Criminology, 5, 2, 121-137.
Ferrarsi, A.O., Oliviero, A., (1997), Capire il comportamento, Zanichelli.
Fonagy, P., & Target, M., (2001), Attaccamento e funzione riflessiva, Cortina Raffaello Editore.
Fonagy, P., et al. (1991), The capacity for understanding mental states: The reflective self in parent and child and its significance for security of attachment. Infant Mental Health Journal, 13, 200-216.
Gatti, U., & Rocca, G., (2013), Il comportamento violento tra biologia ed ambiente: la criminologia verso un “nuovo” approccio biosociale?, Rassegna Italiana di Criminologia, Anno VI, n. 1.
Grazzani, I., (2014), Psicologia dello sviluppo emotivo, Il Mulino.
Gunnar, M.R., & Fisher, P.A., (2006), Bringing basic research on early experience and stress neurobiology to bear on preventive interventions for neglected and maltreated children. Development and Psychopathology, 18, 651–677.
Herman, J.L., (1992), Trauma and Recovery, Basic Books.
Herman, J.L., (2005), Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall’abuso domestico al terrorismo,Magi Edizioni.
Janet, P., (2016), Trauma, coscienza, personalità. Scritti clinici di Pierre Janet. Raffaello Cortina Editore.
Laplanche, J., & Pontalis,, J. B. (1967), Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza.
Liotti, G., (2001), Le opere della coscienza. Psicopatologia e psicoterapia nella prospettiva cognitivo-evoluzionista, Raffaello Cortina Editore.
Liotti, G., Farina, B., (2011), Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa, Raffaello Cortina Editore.
Main, M., (2008), L’attaccamento. Dal comportamento alla rappresentazione, Raffaello Cortina Editore.
Malacrea, M., (2006), Caratteristiche, dinamiche ed effetti della violenza su bambini e bambine. In Bianchi D. & Moretti E. Vite in bilico: Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile, Centro Nazionale Documentazione e Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza, Quaderno 40.
Perry, B.D., (2009), Examining child maltreatment through a neurodevelopmental lens: Clinical applications of the neuro-sequential model of therapeutics, Journal of Loss and Trauma, 14, 240–255.
Peterson, C., Maier, S.F., Seligman, M.E.P., (1995), Learned Helplessness: A Theory for the Age of Personal Control, Oxford University Press, U.S.A.
Rafter, N.H., (2008), The criminal brain: Understanding biological theo- ries of crime, University Press.
Siegel, J., (2013), Breaking the Links in Intergenerational Violence: An Emotional Regulation Perspective, Family Process.
Valzelli, L., (1989), Psicobiologia dell’aggressione e della violenza, Faenza Editrice.
Waker, L.E., (2017), The battered women syndrome, Fourth Edition, Springer Publishing Company.
World Health Organization, (2014), Global status report on violence prevention 2014, World Health Organization.
Yates, T.M., (2007), The developmental consequences of child emotional abuse: A neurodevelopmental perspective, Journal of Emotional Abuse, 7(2).
Sitografia
www.neuroscienze.net/modelli-operativi-interni/
www.stateofmind.it/2012/12/funzione-riflessiva/
www.treccani.it/vocabolario/trauma/
www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=personality&wordsMode=AnyWord
[1] www.neuroscienze.net/modelli-operativi-interni/
[2] www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=personality&wordsMode=AnyWord
[3] La psicotraumatologia è una branca della psicologia dell’emergenza che indaga le reazioni delle persone a eventi traumatici e come questi si cristallizzano e strutturano in sintomi.
[4] www.treccani.it/vocabolario/trauma/
[5] www.stateofmind.it/2012/12/funzione-riflessiva/