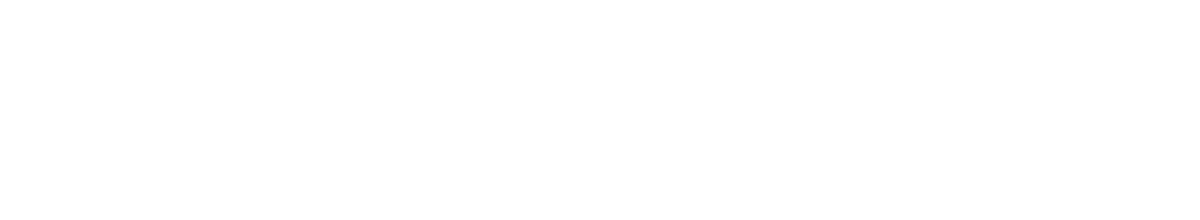Approccio psico-socio-antropologico alla scomparsa di persona
Ogni uccello vola nel proprio stormo, anche quello che pensa di non averne uno (M. Jergovic)
L’ultima Relazione, in ordine di tempo, redatta dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse – datata luglio 2014 e undicesima dall’insediamento dell’Ufficio commissariale – definisce «allarmante» (Rel. 2014, 1) il fenomeno della scomparsa di persona fisica rilevato all’interno dei confini nazionali, poiché stimato attualmente in crescita. Alla data del 30 giugno 2014 sarebbero, infatti, 29.763 le persone ancora da rintracciare, 558 in più rispetto al dato statistico nazionale registrato al 31 dicembre 2013. In particolare, 9.816 italiani e 19.947 stranieri, di cui 14.405 maggiorenni (7.862 italiani e 6.543 stranieri) e 15.358 minorenni, 1.954 dei quali italiani e 13.404 di altra nazionalità. Per quanto concerne la variabile del genere, il fenomeno coinvolge prevalentemente il sesso maschile, con 20.463 uomini (6.236 italiani e 14.227 stranieri) mentre la scomparsa femminile colleziona 9.300 casi, 3.580 dei quali relativi a donne italiane e 5.720 a donne di altra nazionalità. Ammonta, inoltre, a 178 il numero dei cittadini italiani di cui si sono perse le tracce all’estero, 131 dei quali maggiorenni (21 gli ultra65enni) e 26 minorenni (All. 2, Rel. 2014). Nell’ultimo biennio, sono oltre 23.000 le denunce di scomparsa registrate: le categorie statisticamente più rappresentate quelle delle donne; degli ultra65enni affetti dal morbo di Alzheimer; dei minori, prevalentemente stranieri non accompagnati, voce che ammonta complessivamente ad oltre 15.000 unità (All. 2, Rel. 2014). Sotto il profilo geografico, Lazio (6.766 casi), Sicilia (3.900 casi), Lombardia (3.680 casi), Campania (3.146 casi) e Puglia (2.475 casi) le Regioni in cui il fenomeno appare maggiormente ricorrente (All. 3, Rel. 2014).
La revisione quali-quantitativa del dato statistico nazionale[1], operata dal Commissario nella citata Relazione, consente l’analisi dinamicamente orientata di un fenomeno «multifattoriale nella genesi e multiforme nelle manifestazioni» (Marvelli et al., 2011, 53), nell’intento di «favorire la comprensione ottimale del problema» (Rel. 2014, 1) mediante un corretto inquadramento del c.d. scenario di riferimento della scomparsa, con particolare attenzione alle motivazioni ad essa sottese, o presunte tali, al momento della ricezione della denuncia da parte degli organi di polizia. Del resto, un’appropriata classificazione della tipologia di scomparsa manifesta la sua positiva incidenza sia sul piano strategico, ai fini dell’acquisizione di elementi utili all’attività di ricerca (Marvelli, 2013), sia su quello descrittivo, nella misura in cui garantisce una lettura puntuale delle caratteristiche salienti del fenomeno di cui si tratta. La gestione dell’evento critico, giova ripeterlo, non può prescindere da un’accurata indagine del contesto nel quale matura la scomparsa, qualunque sia la dimensione – volontaria, accidentale o giuridicamente rilevante, poiché connessa al perfezionarsi di un fatto di reato – cui la medesima appaia ascrivibile nelle immediatezze del fatto (Marvelli, 2012).
Attualmente, tra le motivazioni di scomparsa maggiormente incidenti sul piano statistico si attesta quella dell’«allontanamento volontario», categoria che annovera il 40,93% degli episodi registrati, pari a 2.938 casi dei 7.178 seguiti dall’Ufficio commissariale a far data dal 2007[2], anno della sua istituzione, fino al 30 giugno 2014 (All. 1, Rel. 2014); percentuale che scende, tuttavia, al 16,26% (pari a 4.841 casi su un totale di 29.763) con riferimento al fenomeno complessivo[3], ossia al totale delle persone italiane e straniere scomparse in Italia e ancora da ricercare a partire dal 1° gennaio 1974, data di inizio del monitoraggio degli eventi critici a livello nazionale (All. 4, Rel. 2014). A tal proposito, due sono i profili che si reputano meritevoli di approfondimento: l’uno, di carattere spiccatamente operativo, in ordine al corretto inquadramento della tipologia di scomparsa; l’altro, di natura squisitamente ermeneutica, in merito all’interpretazione dell’evento critico in chiave psico-socio-antropologica (Rel. 2014, 3), ossia quale manifestazione riconducibile, per un verso, al microcontesto di appartenenza del soggetto (dimensione individuale, familiare, professionale, ecc.) e, per altro verso, all’organizzazione sociale ampiamente intesa.
Per ciò che attiene al primo dei due profili delineati, si suggerisce prudenza nell’inquadramento della scomparsa all’interno della dimensione volontaria, soprattutto in fase di ricezione della denuncia: la volontarietà dell’allontanamento, cioè, dovrebbe configurarsi quale ipotesi residuale e solo eccezionalmente quale motivazione principale sottesa all’evento critico. Ciò postula un’attenta valutazione degli elementi raccolti dal denunciante e/o acquisiti nell’immediatezza del fatto[4], pena una fuorviante classificazione della scomparsa – fino al rischio di strumentalizzazioni o, addirittura, di «depistaggi», come recenti fatti di cronaca sembrano suggerire – con ripercussioni deleterie sia sulla pianificazione di adeguate strategie di ricerca sia sull’esito delle medesime. Inoltre, sebbene la normativa in materia preveda l’obbligo di «immediato avvio delle ricerche» (art. 1 co. 4, l. 14 novembre 2012) a prescindere dalla tipologia di scomparsa ipotizzata[5], la natura apparentemente «rassicurante» del requisito della volontarietà potrebbe frustrare il ruolo propulsivo degli organi di polizia, vanificando le indubbie potenzialità insite nella novella legislativa. L’esperienza vale a dimostrare, infatti, l’efficacia dell’intervento tempestivo nella gestione dell’evento critico, soprattutto negli scenari di scomparsa che coinvolgono categorie soggettive c.d. a rischio, in quanto potenzialmente vulnerabili[6] (Marvelli, 2013). In ogni caso, posta la rilevanza della classificazione ai fini operativi, si ritiene che essa debba garantire un sufficiente margine di flessibilità all’attività di ricerca, in modo particolare qualora l’evolversi degli eventi suggerisca un differente inquadramento dell’episodio di scomparsa. Diversamente, l’attività classificatoria si tradurrebbe in un “etichettamento” disfunzionale dell’evento critico, cristallizzando una situazione in fieri con grave pregiudizio per la vittima potenziale, allorché il medesimo integri gli estremi di un reato contro la persona[7].
Assai più complesse appaiono le considerazioni, di natura ermeneutica, connesse al fenomeno della scomparsa motivata dal requisito della volontarietà. Benchè il predetto carattere possa essere interpretato come espressione della libera scelta del soggetto, l’allontanamento dal contesto di appartenenza dovrebbe intendersi, in ogni caso, come manifestazione di una condizione di disagio, talvolta oggettivamente motivata – si pensi a «una situazione intra-familiare di animosità protratta nel tempo, alimentata da incompatibilità caratteriali, episodi di violenza e sopraffazione, interessi economici contrastanti, difficoltà di convivenza» (Marvelli et al., 2011, 53-54) – talaltra riconducibile a vissuti soggettivi abnormi, elaborati in assenza di «critica adeguata e non conformemente al vero» (Balloni, 2004, 42). Com’è intuibile, il maturarsi di quest’ultima evenienza comporterebbe un sensibile affievolimento del requisito della volontarietà, configurando un differente scenario di scomparsa in quanto psicopatologicamente motivato[8]. In entrambi i casi, tuttavia, pare lecito conferire alla condotta il valore di “scomparsa sintomo”, ossia espressiva dell’esistenza di uno o più fattori disturbanti (o percepiti come tali) nel contesto di appartenenza del soggetto. L’acting-out – o passaggio all’atto, qui concretizzatosi nell’allontanamento – sarebbe, cioè, indicativo del malessere del soggetto, una sorta di “evento sentinella” che genera una frattura significativa all’interno di uno “stile di vita” fino a quel momento apparentemente coerente e sufficientemente organizzato. Non di rado, la condizione di disagio permane latente, larvata, fino a quando un evento oggettivamente traumatizzante – o vissuto con drammatica partecipazione affettiva – non irrompe nella quotidianità, facendola affiorare nella condotta mediante agiti improvvisi, non pianificati, con modalità che si discostano dalle risposte comportamentali consuetamente emesse dal soggetto, tanto da essere definite “incomprensibili” dagli stessi familiari e conoscenti.
Ciò posto, l’allontanamento potrebbe interpretarsi come la risultante di un processo reattivo ad un evento (psico)traumatizzante, agito nell’ambito di un contesto problematico che stimola risposte egodistoniche[9] – emesse «a proprie spese», ossia secondo criteri antieconomici per il funzionamento psico-sociale dell’individuo (Fornari, 2004, 324) – integranti condotte c.d. autoplastiche[10] del tipo rinuncia, evitamento e fuga. Definizione con la quale si intende cogliere non solo l’innegabile rilevanza del profilo introspettivo e di attribuzione di significato all’evento precipitante ma, altresì, la cesura unilaterale di quel «compromesso psicosociale» (Fornari, 2004, 322) che permette la costruzione e il mantenimento di relazioni umane funzionali e gratificanti.
A tale impostazione non pare estranea la componente del “senso di autoefficacia”, recentemente prospettata da Bandura (1996) e intesa come l’insieme delle convinzioni relative all’influenza personale sugli eventi, nel quadro di un processo adattivo rispetto ai molteplici ambiti del funzionamento umano. Altrimenti detto, la self-efficacy[11] rappresenterebbe la consapevolezza della persona circa la propria capacità di acquisire e di mantenere forme di controllo sul corso della propria vita, all’interno di contesti sociali dinamici, sottoposti a repentini mutamenti tecnologici e ad una crescente interdipendenza globale. Un forte senso di efficacia eserciterebbe una benefica influenza sulle condizioni psico-fisiche, sulla realizzazione personale e sull’orientamento della propria esistenza, sia favorendo gli scenari futuri auspicati sia prevenendo quelli indesiderati. Viceversa, la percepita incapacità di incidere sugli eventi potenzialmente spiacevoli o dannosi contribuirebbe, in maniera significativa, a generare stati ansiosi, apatia o disperazione (Bandura, 1996). I risultati di numerosi esperimenti concorderebbero, inoltre, nell’attribuire all’autoefficacia un ruolo di primaria importanza tra i meccanismi di autoregolazione – intesi come quei processi che concorrono a determinare il funzionamento psico-sociale dell’individuo – in termini di motivazione e di successo (Bandura, 1992).
Posta la natura intenzionale di larga parte del comportamento umano, l’incidenza del senso di autoefficacia si manifesterebbe principalmente mediante i processi cognitivi. Com’è stato autorevolmente asserito, infatti, «le convinzioni delle persone circa la propria efficacia disegnano il tipo di scenari futuri che vengono costruiti ed esplorati nell’immaginazione» (Bandura, 1996, 19): basse aspettative di efficacia personale correlano con la visualizzazione di immagini fallimentari, così da influenzare negativamente l’apprendimento di strategie predittive e di regolazione della condotta, soprattutto a fronte di richieste ambientali difficili. Taluni Autori (Wood & Bandura, 1989) hanno, invero, dimostrato come una bassa stima soggettiva delle proprie capacità pregiudichi l’efficienza del pensiero analitico e le abilità di problem-solving, riducendo i livelli di aspirazione e peggiorando lo standard delle prestazioni individuali. Non a caso, un debole senso di autoefficacia si è rivelato il principale fattore di vulnerabilità individuale a fronte di cambiamenti esistenziali critici (lutto, divorzio, malattia, difficoltà economiche, ecc.), condizionando la percezione degli stessi in termini di minaccia o di eventi soggettivamente incontrollabili (Jerusalem & Mittag, 1996). Risultanze, queste ultime, che avvalorerebbero la tesi formulata nella Relazione commissariale 2014, la quale sembra ricondurre la maggior parte degli allontanamenti c.d. volontari all’incapacità di gestione attiva di eventi potenzialmente stressanti.
Ebbene, il concetto di “gestione attiva”, se per un verso richiama le c.d. esperienze di gestione efficace[12] – quelle, cioè, in cui la persona affronta con successo situazioni di vita complesse, così da rafforzare la stima nelle proprie capacità (Bandura, 1996) – per altro verso rinvia alle strategie di coping (Gross et al. 2006), intese come modalità di gestione delle richieste emotivamente stressanti attraverso i meccanismi di regolazione delle emozioni. La capacità di modellare la condotta emotiva di fronte ad un evento emotigeno[13], così da orientarne adeguatamente la manifestazione rispetto al medesimo, risulterebbe, infatti, determinante ai fini dell’adozione di un comportamento sociale appropriato e adattivo (Legrenzi et al., 2012). La regolazione del processo emozionale si è dimostrata, altresì, efficace a garantire il benessere psicofisico dell’individuo, mediante la riduzione dell’attivazione prolungata del sistema nervoso autonomo – ossia la componente del SN che regola le funzioni vegetative – favorita dalla diminuita attività amigdaloidea e insulare[14], così come acclarato da recentissimi studi di neuroimaging[15]. L’indagine delle basi neurofisiologiche e neuroanatomiche dei processi di regolazione emotiva ha contribuito, inoltre, a dimostrare l’esistenza di rilevanti implicazioni anche in rapporto alle funzioni esecutive: in particolare, la capacità di adottare decisioni sarebbe compromessa dagli esiti del meccanismo di regolazione concretamente attivato dall’individuo (Legrenzi et al., 2012).