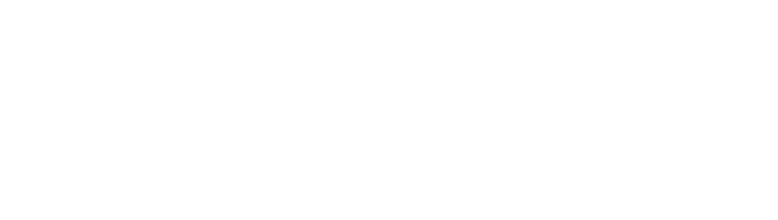L’uomo e il potere
«Merita il potere solo chi ogni giorno lo rende giusto»
D. Hammarskjöld
Nel campo del diritto il termine potere ha un significato piuttosto preciso, indica autorità ed autonomia decisionale del soggetto (o organo) che lo detiene ad agire producendo determinati effetti giuridici, generalmente un atto o precetto normativo (norma, legge, regolamento).
Sempre nello stesso ambito, nella variante in cui il potere viene esercitato al fine di garantire e proteggere i diritti di altri, da soli impossibilitati a farlo, prende il nome di potestà.
In entrambi i casi, si sottende al possesso ed all’esercizio di un “potere di”, una condotta decisionale attiva in cui il detentore direttivo stabilisce, in autonomia ed indipendenza, regole e norme da seguire[1].
Nelle altre scienze sociali, viceversa, il termine estende i propri confini e, travalicando la materialità del prodotto, assume un senso relazionale sottendendo alla capacità di influenzare o controllare altre persone. Per la psicologia sociale, difatti, ogni contatto o scambio a livello interpersonale tra singoli soggetti, o a livello intragruppo o intergruppo tra soggetti riuniti in collettivo, sono permeati dall’assunzione e dall’esercizio delle facoltà di potere.
In tal senso si parlerà di “potere su”, e si richiameranno da un lato il concetto di “obbedienza”, dall’altro quello di “carisma”.
Lì dove il potere è l’espressione della propria volontà su altre persone, inevitabile è che quest’ultime si inducano in obbedienza, poiché come diceva Bateson, il potere in realtà non esiste, o meglio altro non è che il frutto di processi circolari di “attribuzione di significato”: a colui che lo detiene, ed al significato che egli attribuisce al proprio potere, devono rispecchiarsi gli altri, che al primo devono riconoscere quel potere, nella circolarità del processo di significazione. «Il potere non è solo quello che realmente hai, ma quello che i nemici pensano tu abbia[2]».
A tal riguardo, sembra utile citare la distinzione di Max Weber (in “Ecomonia e società”) tra potenza (Macht) e potere (Herrschaft): la prima è «qualsiasi possibilità di far valere, entro una relazione sociale, anche di fronte a un’opposizione, la propria volontà[3]». In contrapposizione troviamo la volontà e la potenza, le due facce della stessa medaglia, e dunque si ha potenza quando la volontà piega l’opposizione (a sua volta, espressione di altra volontà). Il potere è viceversa «la possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un comando che abbia un determinato contenuto». In questo caso, la coppia contrapposta è formata da comando ed obbedienza: anche se il comando è in rapporto con la volontà (e quindi con la potenza) di chi lo detiene, ciò che manca è la “resistenza”, l’opposizione. Il comando viene accolto con obbedienza.
Altresì, ben diverso è che la volontà di uno sugli altri si attui con la forza e l’induzione in soggezione, o con una persuasione al consenso che, dal basso, derivi dal riconosciuto rispetto verso la superiorità del potente: in questo secondo caso, il concetto di potere è più vicino a quello di carisma.
Già nel XVIII capitolo del suo “Il Principe” – trattato di politica in cui dall’osservazione delle dinamiche di influenza sociale veniva descritta quella che per quel tempo doveva essere la più opportuna personalità della figura detentrice di potere (per l’appunto il Principe) – Machiavelli distingueva tra forza e consenso descrivendo le doti di governo tramite il paragone con il comportamento di due animali, il leone e la volpe: laddove i primi usano la sola forza per ottenere il potere, i secondi si affidano invece al consenso, ottenuto con furbizia.
Machiavelli giungeva peraltro ad altri più specifici consigli sull’arte di governare, spiegando che «Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano», ovvero coloro che si limitano ad essere leoni non conoscono l’arte di governare: la sola forza non basta, tanto che alla lunga il loro potere sarà esaurito, ed essi verranno sconfitti. Serve viceversa anche la furbizia, per Machiavelli addirittura tale da far credere di possedere giuste qualità morali (bontà, lealtà, onestà, rispetto), anche lì dove esse non esistono: «A uno principe, dunque, non è necessario avere tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle. Anzi, ardirò di dire questo, che avendole et osservandole sempre, sono dannose, e parendo di averle, sono utile; come parere pietoso, fedele, umano, intero, relligioso, et essere; ma stare in modo edificato [predisposto] con l’animo, che, bisognando non essere, tu possa e sappi mutare el contrario».
Guardando alla storia evolutiva della nostra società, si possono citare molti nomi di uomini di potere: si pensi a grandi strateghi e leader di Stato quali Pericle, Giulio Cesare, Alessandro Magno, Napoleone Bonaparte, e poi nell’epoca più moderna Nikolaj Lenin, Joseph Stalin, Adolf Hitler e Benito Mussolini.
Tutti hanno assolto l’esercizio del proprio potere, nelle proprie “facoltà di e su”, sicuramente con carisma; alcuni con forza e violenza, o per tratti caratteriali propriamente di orgoglio o per copertura compensatoria di un Io fragile, lì dove la delirante grandiosità del Sé aveva ancor più bisogno di adulazione ed assoggettamento sociale[4]. E certo, in questi casi, la violenza e brutalità delle loro condotte poggiava anche su opportunistici processi di disumanizzazione di coloro che la ricevevano (sempre ulteriore effetto della grandiosità del Sé): considerando gli altri come oggetti, utili solo a soddisfare i propri bisogni, privati di caratteristiche di umanità, veniva in loro ridotto l’impatto emotivo (il danno, il dolore) causato dalla condotta adottata, poiché i processi decisionali con i quali veniva eseguito il potere dovevano essere quanto più efficaci possibile, ovvero rapidi, con maggiore probabilità di successo e minore dispendio di energie e costi.
Ma, se da un lato la “storia è maestra”, dall’altro non si può accettare in pieno l’ideologia machiavelliana, e si desidera almeno che l’uomo di potere sia “moralmente integro”: coraggioso, ma non impositivo, onesto ed equo, nobile nell’animo, negli intenti e nella condotta. Un “liberatore” del popolo e degli oppressi…e qui ci piace pensare a Mosè, che liberò gli ebrei dal Faraone, da colui che, almeno formalmente, deteneva il potere. Come a dire che «un uomo forte non ha bisogno del potere; un debole ne viene schiacciato» (Nicola II Romanov, ultimo Imperatore di Russia).
[1] Si consideri che, in merito alle differenti forme di potere, i latini distinguevano tra “auctoritas” e “potestas”: il primo designa un potere simbolico, il secondo un potere giuridico. Come è noto, nel Medioevo la potestas spettava all’Imperatore e l’auctoritas al Papa, i cosiddetti “due Soli” di cui anche Dante si interessò nel “De Monarchia” (III libro) e nella “Divina Commedia” (Purgatorio, Canto XVI).
[2] “Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have” (Saul David Alinsky, “Rules for Radicals”, 1971).
[3] In lingua tedesca il termine Herrschaft significa inoltre “signoria” (il prefisso “Herr” vuol dire signore) e “dominio”: vi è quindi una forte identificazione del concetto con il soggetto che è detentore di potere.
[4] Secondo le teorizzazioni psicoanalitiche sull’origine e l’evoluzione, con annesse eventuali forme patologiche, del Sé (e qui si riveda Heinz Kohut), un Sé grandioso è la compensazione di un Io fragile, a sua volta determinato da un’inadeguata rispondenza delle figure di accudimento alle necessità fisiologiche ed emotive del bambino: la scarsa empatia e sensibilità genitoriale induce ad una frammentazione del Sé che, in parte, può ingenerare forme patologiche espresse attraverso bisogni di grandiosità ed esibizionismo.