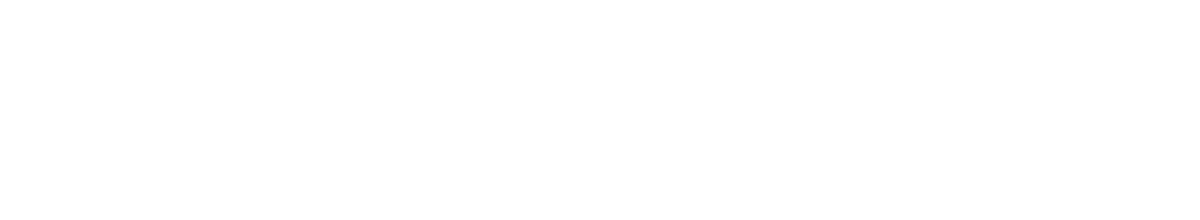L’agito aggressivo: la gestione della situazione di crisi
«Nell’isola senza coltelli c’è un uomo che pensa, ed è l’antitesi dell’uomo presente, la cui caratteristica dominante è, assieme alla violenza, l’ignoranza» V. Andreoli
Com’è stato affermato da autorevole dottrina, l’aggressività, in quanto condotta diretta contro conspecifici sotto forma di agiti distruttivi[1], si manifesta in molteplici contesti, «svela(ndo) ciò che dovrebbe rimanere sempre nascosto: il dominio violento dell’uomo su altri uomini» (Ceretti, 2011, p. 6). Il tema dell’aggressività ‑ rispetto al quale si sono confrontati e continuano a confrontarsi incessantemente differenti approcci e metodologie di indagine (Merzagora Betsos, 2001) ‑ si connota per la sua dimensione sociale, configurandosi come fenomeno interpersonale capace di influenzare i rapporti di prossimità anche in relazione a condotte che non perseguono necessariamente esiti offensivi. Si pensi all’impiego dell’aggettivo «aggressivo» declinato nei confronti della donna in carriera o dell’atleta determinato a vincere, casi nei quali l’aggressività si identifica con «una carica interna ad affermarsi e a dominare le difficoltà» (Arcuri, 2008, p. 337) piuttosto che con una propensione all’offesa eterodiretta, rievocando quel concetto di «autoaffermazione» di adleriana memoria perfettamente conciliabile con il sentimento di socialità. Del resto, l’ambiguità semantica del termine (dal lat. ad-gredior, andare verso o contro) richiama la multidimensionalità della fenomenologia aggressiva (Arcuri, 2008), a suo tempo evidenziata da Fromm nella nota distinzione tra aggressività «benigna» ‑ filogeneticamente programmata e funzionale all’autoconservazione dell’individuo e della specie (Merzagora Betsos, 2001) ‑ e aggressività «maligna» o distruttiva, culturalmente determinata e finalizzata all’esercizio di «(…) un controllo assoluto e illimitato su un essere vivente» (Fromm, 1983), di fatto coincidente con il sadismo e anticipatoria di talune osservazioni successivamente formulate in merito alla psicologia dei serial killers (Merzagora Betsos, 2001). Pertanto, l’aggressività rinvia a un variegato ventaglio di strategie comportamentali, connotate da differenti gradi di desiderabilità sociale, che spaziano dall’adattamento all’ambiente in modo creativo e disponibile alla condotta distruttiva e socialmente deprecabile (Maremmani, Di Muro & Castrogiovanni, 1999).
Confinando la fenomenologia aggressiva alle sole condotte orientate ad arrecare un’offesa ai conspecifici[2], si intende limitare la presente riflessione alla c.d. aggressività ostile, ossia a quel complesso di manifestazioni eterodirette nelle quali l’offesa altrui costituisce il fine primario della condotta posta in essere[3] (Feshback, 1970). In proposito, la letteratura di merito identifica tre elementi a valenza classificatoria, ravvisabili rispettivamente nell’intento, nell’azione e nello stato emotivo dell’attore. Nel prototipo aggressivo eterodiretto, all’intenzionalità, quale volontà consapevole di arrecare un danno altrui, deve fare seguito l’azione coerentemente orientata a provocare il danno medesimo, con concomitante stato emotivo di rabbia o di emozioni ad esso correlate che, in ragione dell’intensità, possono assumere coloriture variabili, dalla lieve irritazione alla grave ira (Maremmani, Di Muro & Castrogiovanni, 1999). Merita segnalare, tuttavia, come le attuali direttrici di ricerca siano orientate all’abbandono della tradizionale impostazione omologante ‑ ossia tendente ad uniformare le differenti manifestazioni aggressive sotto il comune denominatore dell’offesa volontariamente eterodiretta – in favore dell’approfondimento delle componenti specifiche che improntano singole categorie di condotta[4]. In seno alla ricerca contemporanea, si colloca il paradigma bidimensionale proposto da Geen (1990), che descrive una duplice forma di aggressività: una «reattiva, ostile affettiva», caratterizzata dalla prevalenza di componenti affettivo-emotive, e una «proattiva o strumentale», con predominanza di componenti cognitive e intenzionali, in relazione al differente grado di incidenza, sull’agito aggressivo, degli elementi eccitatori e di autoregolazione cognitiva dell’attore (Arcuri, 2008, p. 354).
L’accentuazione del ruolo della componente emotiva a scapito di quella cognitiva e viceversa, sostiene una gamma di manifestazioni aggressive assai ampia e articolata, soprattutto in termini di programmazione ed esecuzione della condotta, con rilevanti ripercussioni sul versante del contenimento dell’«attore violento»[5] in situazioni di crisi. Accanto a forme di aggressione correlate a significative oscillazioni dell’umore, non di rado esacerbate dall’abuso di sostanze e capaci di inibire il dominio del soggetto attivo sulla propria condotta, si ravvisano manifestazioni di aggressività che richiedono un elevato grado di autocontrollo e di pianificazione, unitamente ad un’attenta valutazione delle conseguenze in termini prospettici[6] (Arcuri, 2008), con implicazioni gestionali intuitivamente differenti. Si pensi alle diverse tecniche di approccio ad un soggetto in stato di intossicazione acuta indotta da sostanze psicotrope – evenienza assai frequente in occasione dei c.d. controlli del fine settimana operati dalle forze di polizia – rispetto a quelle necessarie a contenere un paziente psichiatrico che minaccia con un’arma (Nivoli, Lorettu & Sanna, 1999) oppure a fronteggiare la cattura di ostaggi da parte di soggetti armati (Marullo, 2002). Particolarmente complessa appare la gestione di situazioni borderline di c.d. barricamento, caratterizzate dall’assenza di richieste specifiche da parte dell’autore e da manifesti intenti suicidiari. Non a caso, l’esperienza maturata in tali ambiti si è concretizzata, soprattutto negli Stati Uniti, nella costituzione di unità operative con competenze specifiche, composte da personale addestrato e in grado di intervenire nell’immediatezza degli eventi per ridurre le perdite di vite umane mediante l’attività di negoziazione (Kupperman & Trent, 1979; Noesner & Dolan, 1992).
Recenti fatti di cronaca impongono una seria riflessione in merito alle molteplici forme di iniziazione alla violenza, nell’ambito di contesti socio-culturali che facilitano la messa in atto di condotte offensive attraverso la disponibilità di mezzi dalla spiccata lesività (Arcuri, 2008). Ne è un esempio la frequente risoluzione dei conflitti interpersonali con l’impiego delle armi da fuoco, il cui ruolo criminogenetico è stato ampiamente documentato dalla Scuola modenese di Medicina Legale (De Fazio, Castelli, Cipolli, et al., 1981). Già Berkowitz e La Page (1967) avevano verificato sperimentalmente il valore di cue[7] e/o di arousal[8] aggressivo delle armi, riconducibile all’associazione delle medesime all’aggressività espressa dalla (sotto) cultura di appartenenza dell’attore violento (c.d. weapons effect). Com’è noto, infatti, tali sottoculture manifestano un’ampia tolleranza nei confronti della violenza quale modalità di regolamentazione dei rapporti interpersonali, coerentemente con un sistema valoriale il cui mancato rispetto genera ostracismo ed emarginazione da parte degli altri consociati (Mantovani, 1984). In ogni caso, l’arma pare assumere il ruolo di stimolo determinante e/o predisponente l’acting out aggressivo soprattutto nell’esecuzione di reati relazionali e passionali (c.d. family crimes), nell’ambito dei quali la componente impulsiva è, spesso, elicitata dai mezzi a disposizione dell’aggressore (Arcuri, 2008).
Sull’onda lunga dell’ipotesi frustrazione-aggressività (Dollard, Doob, Miller et al., 1939), osservazioni empiriche del fenomeno hanno dimostrato come lo scoppio della scintilla aggressiva possa essere favorito dal concorso «di uno stato interno di eccitazione e di una provocazione esterna» (Arcuri, 2008, p. 353), con concomitante impiego di mezzi lesivi di varia natura. In tali contesti, in cui la manifestazione aggressiva si appoggia ad un temporaneo discontrollo dell’umore accompagnata dalla minaccia dell’uso ‑ auto e/o eterodiretto ‑ di un’arma, la gestione dell’evento critico da parte degli operatori richiede il rispetto di alcuni elementari ma efficaci princìpi di comportamento, quali esposizione al rischio di un numero minimo di soggetti tramite allontanamento di terzi che potrebbero, seppur involontariamente, sollecitare il passaggio all’atto; stimolazione del dialogo attraverso una comunicazione verbale e gestuale che inviti alla calma e alla distensione, evitando atteggiamenti provocatori e controminacciosi tali da indurre, nell’aggressore, perdita di controllo emotivo e motorio; uniformità di condotta, con evitamento di gesti eroici o inconsulti. Sarebbe, pertanto, auspicabile sollecitare la consegna dell’arma piuttosto che tentare di impadronirsene in maniera callida o furtiva oppure ingaggiando una colluttazione con l’aggressore finalizzata a disarmarlo, a meno che la situazione concreta non consenta la messa in atto di specifiche tecniche di neutralizzazione del medesimo. Com’è stato opportunamente osservato, «(…) la persona che minaccia con un’arma non lo fa solo per terrorizzare e spaventare gli altri, ma lo fa anche perché è terrorizzata e spaventata. L’arma rappresenta una forma di sicurezza che chi minaccia e si sente minacciato non può lasciare, almeno nelle immediatezze di tempo, in mano agli altri» (Nivoli, Lorettu & Sanna, 1999, pag. 645).
È assai improbabile che le stesse misure risultino efficaci qualora il ricorso alla condotta aggressiva e violenta sia sostenuto da un sistema valoriale che lo legittima o qualora le controspinte all’azione ‑ empatia, senso di colpa o di vergogna ‑ siano attenuate da «meccanismi di disimpegno morale» (Arcuri, 2008, p. 355), quali sottostima delle conseguenze dell’agito deviante, disumanizzazione delle vittime[9] (Andreoli, 1996) e appello a princìpi superiori. Ne sono un esempio la graduale modifica del valore morale dell’omicidio che si attua mediante l’indottrinamento dei gruppi militari in tempo di guerra – contesto nel quale i meccanismi di auto-censura dei combattenti vengono costantemente neutralizzati attraverso una varietà di dispositivi di auto-assoluzione, quali giustificazioni ideologiche, descrizione del nemico in termini di fanatismo e di brutalità et similia (Bandura, 1986) – e gli episodi di cattura di ostaggi per motivi politici o terroristici, in cui l’aggressore appare intenzionato, sin dalle prime fasi, a condurre l’azione criminosa alle estreme conseguenze[10]. In casi simili, la gestione dell’evento critico richiede il coinvolgimento di unità di negoziazione e di intervento tattico, specializzate nella risoluzione di eventi ad alto rischio di vittime, in attesa delle quali non andrà intrapreso alcun tentativo di trattativa con il sequestratore (Marullo, 2002). Significativa, ai fini strategici, appare la distinzione tra atteggiamento strumentale (instrumental behavior) e atteggiamento espressivo (expressive behavior), elaborata da taluni Autori (Strenz, 1986) in relazione alla condotta adottata dal sequestratore durante le trattative: mentre la verbalizzazione di richieste chiare e circostanziate consente un’adeguata pianificazione dell’intervento tattico, la manifestazione di stati emotivi quali frustrazione, disperazione e rabbia complica i tentativi di negoziazione, accrescendo considerevolmente i rischi per l’incolumità degli ostaggi. Talvolta, è lo stesso sequestratore a creare i presupposti per un intervento letale delle forze di polizia (suicide by cop), nel qual caso scopo ultimo dell’agito violento è la ricerca della propria morte per mano altrui (Divasto, Lancely & Gruys, 1992).