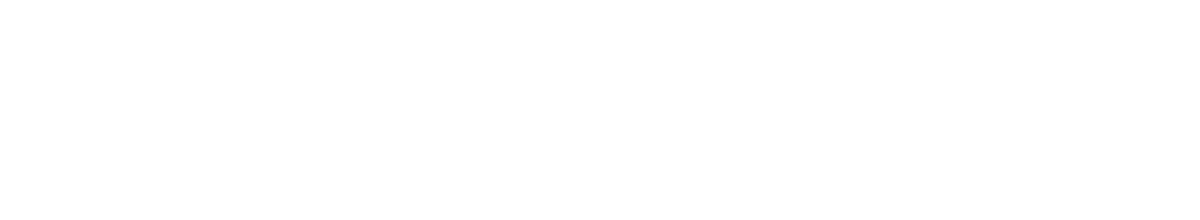L’evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e sammarinese
“Ubi dubium, ibi libertas” (Proverbio latino)
Come accertato dalle indagini storiche e riportato dagli antichi scrittori latini, il termine «plagio» deriva verosimilmente dall’aggettivo greco πλάιος, che significa «obliquo, tortuoso, astuto», sebbene taluni Autori lo riconducano al verbo πλάςω, «batto, spingo, fuorvio» e, per estensione, anche «sottraggo» (Molè, 1982). Le prime notizie relative alla sua diffusione nel linguaggio giuridico risalgono al III° sec. a.C., quando viene impiegato per indicare la condotta illecita di impossessamento e di commercio di un uomo libero o di uno schiavo altrui. Nel diritto romano designa l’azione delittuosa di colui che, dolosamente[1], si impossessi, trattenga o faccia oggetto di transazione economica un uomo libero o assoggettato alla schiavitù altrui.
Nel corso dei secoli, il contenuto lessicale del termine si evolve progressivamente, identificando differenti fattispecie criminose. Si pensi all’uso, in senso figurato, compiuto da Marziale [Epigr., 1, 52,: (…) impones plagiario pudorem] ‑ laddove paragona la falsa attribuzione di opere letterarie altrui all’illecito assoggettamento di schiavi altrui al proprio servizio[2] ‑ generando un significato traslato rispetto a quello originario, che sopravvive negli idiomi moderni: «(v. l’italiano plagio, il francese plagiat, l’inglese plagiarism, il tedesco Plagiat) indicante l’azione di farsi credere autore di prodotti dell’ingegno altrui e quella di riprodurli fraudolentemente» (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Trattasi di un’accezione analoga a quella integrante la fattispecie del c.d. plagio letterario, contemplata, nella legislazione italiana, dagli artt. 61 e 62 della legge 18 marzo 1996, n. 562.
È la Lex Fabia ‑ di autore incerto e databile tra la fine del III° e l’inizio del II° sec. a.C. – a riunire, sotto la denominazione di «plagio», specifiche condotte di reato, delineando un’incriminazione autonoma, distinta da quella del furto e da altri reati analoghi in ragione della peculiarità dei suoi elementi costitutivi. In ossequio all’etimologia originaria, essa punisce la condotta consistente nel trattenere dolosamente un uomo libero, ingenuo o liberto o nel renderlo oggetto di negozi giuridici quali vendita, donazione o permuta. Il crimen plagii si sostanzia, dunque, nell’esercizio abusivo di una potestas dominicale su un cittadino romano o su un liberto, essendo irrilevanti le modalità attuative dell’abuso. Secondo taluni Autori, detta figura di reato contemplerebbe, altresì, l’azione dolosa di colui che induce lo schiavo a fuggire dal proprio padrone, sebbene le opinioni in merito siano discordanti (Molè, 1982).
La disciplina giuridica è assai severa: dalla pena pecuniaria fissa di 50.000 sesterzi a carico dell’autore del plagium e del suo eventuale correo (Ulp., Coll., 14, 3, 4 e 5) al successivo inasprimento della sanzione in epoca imperiale, quando i plagiari delle classi più abbienti subiscono la confisca della metà del patrimonio e gli humiliores «la condanna ad metalla o il supplizio della croce» (Molè, 1982, pp. 119-120). Peraltro, dall’interpretazione di un passo della relazione del giurista Paolo – avente ad oggetto la riforma, attribuita a Caracalla, che segna il mutamento di specie delle misure sanzionatorie – si evincerebbe l’esercizio di un potere discrezionale del giudice nella graduazione della pena, in rapporto alle circostanze del reato. In età giustinianea, il regime del plagio si mantiene sostanzialmente invariato rispetto alla legislazione anteriore, quando la pena capitale è, di fatto, riservata alle ipotesi più gravi (Inst., 4, 18, 10); differenziazione verosimilmente riconducibile alla distinzione, introdotta da Costantino, tra ipotesi plagiarie aventi ad oggetto uomini liberi o schiavi altrui (Molè, 1982).
Il significato tecnico del termine si mantiene costante nel diritto barbarico e nelle fonti giuridiche medioevali, designando l’atto di colui che assoggetta illegittimamente un essere umano ad un regime di schiavitù o lo trasferisce altrove contro la sua volontà, rendendolo oggetto di negozi giuridici di varia natura. Crimine di particolare gravità, è represso con pene severissime, come testimoniano la Lex Salica del V° e del VI° sec. e la Lex Frisionum dell’VIII° sec., che equiparano il plagio di nobili e di uomini liberi all’omicidio, assoggettandolo sostanzialmente alla medesima disciplina[3]. Detto significato persiste anche nel diritto intermedio e fino agli albori dell’epoca moderna, afferendo all’istituto giuridico della schiavitù inteso come stato della creatura umana non avente personalità giuridica. La sua repressione mira, infatti, a proteggere il diritto di proprietà del padrone dello schiavo nonché a colpire la riduzione in schiavitù, o in condizione di fatto analoga, di un uomo libero (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Si dovranno attendere gli eventi della Francia rivoluzionaria e la Convenzione Internazionale di Saint-Germain del 1919 – che sancirà il carattere illecito della schiavitù in tutte le sue declinazioni – per assistere alla metamorfosi della natura giuridica della fattispecie plagiaria: da delitto contro la proprietà di esseri umani a delitto contro la libertà individuale.
Alla maggior parte delle legislazioni italiane preunitarie sono estranee norme che puniscano la schiavitù e il commercio di schiavi, essendo sanzionata unicamente la riduzione di fanciulli e di uomini liberi in condizioni di servaggio. Parzialmente diversa la condizione degli Stati assoggettati al dominio napoleonico, poiché il Codice penale francese del 1810 – sebbene non utilizzi il termine plagiat, peraltro diffuso nel linguaggio forense – sanziona una pluralità di condotte che contemplano l’arresto illegale e il sequestro di persona (artt. 341–344); il rapimento, la sottrazione e la sostituzione di minore, il trasferimento illegale di minori, l’esposizione e l’illegale abbandono in ospizio di un minore di 7 anni (artt. 344–355). Disciplina analoga quella contenuta nel «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» del 1819, che contempla la categoria dei delitti contro l’asservimento di persone, così come la legislazione pontificia dell’epoca, che punisce severamente anche l’ingaggio e l’arruolamento di sudditi pontifici per assoggettarli al servizio militare di sovrani stranieri[4]. Nessuna delle predette incriminazioni, tuttavia, viene identificata con la rubrica legis di «plagio».
La sola legislazione italiana preunitaria ad impiegare il termine «plagio» con una specifica valenza giuridica è il Codice penale del Granducato di Toscana del 1853, il quale punisce con la pena detentiva colui che si sia ingiustamente impadronito di una persona contro la sua volontà o di un infraquattordicenne, seppure consenziente (art. 358). La pena è aumentata qualora la vittima sia stata consegnata ad un «servigio estero militare o navale» o sia stata ridotta in schiavitù. A commento dell’articolo, il Carrara fornisce una nozione di plagio che verrà frequentemente richiamata in dottrina ed accolta da larga parte della giurisprudenza anteriore agli anni Ottanta del secolo scorso, definendo il medesimo in termini di violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta. Della stessa opinione anche il Puccioni, che ravvisa gli estremi del delitto di plagio nella violazione della libertà personale dell’individuo; nella modalità violenta o fraudolenta con la quale la condotta viene posta in essere in danno di colui che esercita la potestà sulla vittima; nella finalità lucrosa della condotta plagiaria (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96).
La tutela penale dello status libertatis nel Codice Zanardelli del 1889 è racchiusa nella previsione contenuta nell’art. 145, che punisce con la pena della reclusione da dodici a venti anni chiunque riduca taluno in schiavitù o in una condizione ad essa analoga. La norma, inserita nel capo relativo ai «Delitti contro la libertà individuale» (artt. 145-156), figura come «plagio» sia nelle rubriche ufficiali del progetto sia in varie edizioni del codice. Secondo la migliore dottrina (Lemme, 1990), gli antecedenti storici di tale disposizione andrebbero individuati nella normativa internazionale in materia di schiavitù sviluppatasi in Europa a far data dal Congresso di Vienna del 1815, parallelamente all’abolizione dello stato servile negli ordinamenti giuridici extraeuropei. In un tale clima di fermento giuridico e culturale, l’inserimento della fattispecie plagiaria risponderebbe ad un duplice intento, ravvisabile nell’adempimento dell’ordinamento italiano ad un impegno internazionale e nella riaffermazione della sua vocazione libertaria e progressista.
La previsione codicistica del 1889 presuppone un’attività umana esclusivamente fisica, il cui risultato si sostanzia nel porre il soggetto passivo in una condizione materiale di dipendenza altrui senza, tuttavia, privarlo della condizione giuridica di uomo libero (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Inoltre, l’esplicito riferimento alla «condizione analoga alla schiavitù» sembra porre seri problemi interpretativi già ai commentatori dell’epoca circa l’intento del legislatore di accomunare, alla servitù di diritto – coincidente con la privazione totale della capacità giuridica e dello status libertatis – la servitù di fatto, condizione nella quale la vittima appare totalmente impedita nel concreto esercizio dell’una e dell’altro, benchè entrambi formalmente integri (Lemme, 1990).