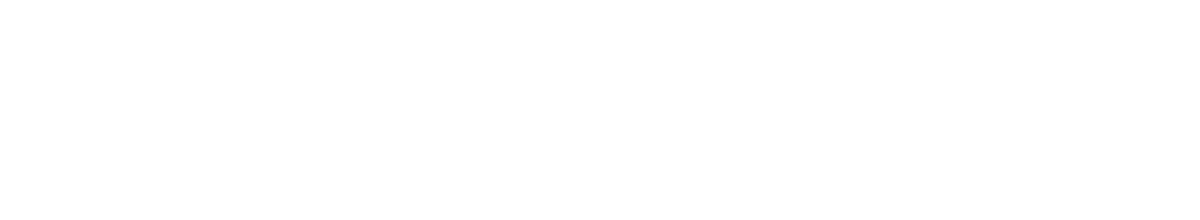“L’ergastolo bianco”
Il tema centrale fa riferimento alla condizione degli internati nelle case di lavoro in cui permangono ex detenuti soggetti alla misura di sicurezza ed alla condizione dei cosiddetti “infermi di mente” rinchiusi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Situazioni esemplari di abuso in rapporto al mancato riconoscimento di persona umana come soggetto di diritto.
La commissione di inchiesta del Senato della Repubblica sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, ha evidenziato una situazione di sistematica violazione dei diritti umani radicata ormai da tempo soprattutto in riferimento alle condizioni degli internati in OPG.
Alcune delle violazioni messe in evidenza sono imputabili alla carenza delle strutture, al loro malfunzionamento, alla loro cattiva gestione o scarsa dotazione finanziaria. Un aspetto, questo, che sottolinea l’infelice condizione di chi sconta la misura di sicurezza dell’internamento in OPG in cui prevale l’aspetto custodiale che la caratterizza, rispetto invece ai fini terapeutici e/o riabilitativi; condizione assimilabile a quella patita dai detenuti comuni.
La situazione degli internati nelle case di lavoro, e, in questa circostanza mi soffermo in particolare ad evidenziare ciò che accade nella casa di lavoro di Sulmona (PE), recentemente ha indignato il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, e in generale il mondo forense, per la condizione disumana subita da ex detenuti considerati, ancora in modo indeterminato, socialmente pericolosi.
Nella casa di lavoro di Sulmona (PE), quello che appare immediatamente evidente all’osservazione, è la commistione tra detenuti e internati. Questi ultimi sono situati al I e III piano dello stessa casa di reclusione che ospita, al II piano, detenuti che stanno scontando la pena assegnata.
Il trattamento cui sono sottoposti gli internati quindi, in queste condizioni, è del tutto simile a quello dei detenuti. Una tale situazione di fatto, pertanto, genera una condizione di promiscuità, in contrasto con quanto previsto dall’ordinamento penitenziario negli articoli 14 e 62 e con la disposizione normativa contenuta nell’articolo 213 del codice penale, secondo cui, le misure di sicurezza devono essere eseguite negli stabilimenti ad esse destinati. Gli internati, invece, vengono tenuti chiusi nelle proprie celle per la quasi totalità della giornata, usufruendo del medesimo numero di ore d’aria e di socialità previste per i detenuti. [1]
Di recente, e precisamente nel febbraio 2011, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, inviando una relazione al Ministero di Giustizia, e a tutte le figure istituzionali più rappresentative, ha rimarcato la condizione degli internati nella casa di lavoro di Sulmona, sottolineando la condizione di angoscia dei soggetti internati sottoposti alla misura di sicurezza detentiva connotata proprio dalla peculiare indeterminatezza temporale della misura che, proprio per quel sistema di proroghe continue e reiterate, rischia di proseguire anche in termini di mera perpetuità. Si rimarca anche l’endemica carenza di personale addetto all’osservazione e la strutturale mancanza di opportunità lavorativa o culturale all’interno della sezione, che a sua volta non consentono alla Magistratura di Sorveglianza di acquisire gli elementi essenziali sui quali poter formulare il giudizio prognostico di cessazione o attenuazione della pericolosità sociale, ai fini della revoca o della trasformazione della misura di sicurezza detentiva in quella della libertà vigilata. [2]
Sono, così evidenti gli stessi effetti de-socializzanti che la carcerazione comporta e, dal punto di vista del rispetto dei diritti della persona alle stesse degenerazioni, ma con alcuni aggravi aggiuntivi. Se da una parte, infatti, la degenza coattiva in uno di questi centri si configura come percorso di cura e riabilitazione, dall’altra il sistema degli OPG e delle case di lavoro, è predisposto in maniera tale che i “pazienti” non possano essere seguiti in maniera costante, sia attraverso la terapia farmacologica, sia attuando un vero e proprio percorso psicoterapeutico/riabilitativo e risocializzante.
Ad esempio i pazienti-detenuti sono sistematicamente costretti ad assumere terapie farmacologiche prescritte, senza poterle modificare entro intervalli ragionevoli di tempo, mancando del tutto la possibilità di incontri ravvicinati tra degenti e personale medico-psichiatrico. In questi pazienti la terapia farmacologica viene percepita come un’intrusione, una forzatura, piuttosto che come un accudimento e, tale elemento è di per sé sufficiente a compromettere la serietà del tentativo di cura, nonostante l’importanza che per questo tipo di percorsi terapeutici assume l’adesione e la collaborazione attiva del paziente al progetto di cura.
Per quanto riguarda la pericolosità sociale degli internati nelle case di lavoro, inevitabilmente, la revoca non avviene mai poiché vengono a mancare i presupposti fondamentali per attuare un vero cambiamento. Si pensi all’inesistente trattamento psicoterapeutico che, invece, potrebbe supportare la socializzazione ed un pieno reinserimento nel mondo del lavoro. Questa situazione produce di fatto, uno stato di cose che si può definire “ergastolo bianco”.
Per una rivisitazione del “Codice Rocco”
La natura della gravità dei fatti rilevati, non si riferisce semplicemente al malfunzionamento delle strutture e, di conseguenza, alla cattiva applicazione della legge penale, quanto piuttosto nella legge penale stessa. L’istituto dell’internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, così come formulato dal codice penale all’art. 222, è il risultato di elaborazioni dottrinali superate, difficilmente conciliabili con l’odierna cultura della tutela dei diritti umani. La misura di sicurezza dell’internamento in manicomio giudiziario, prevista dal codice Rocco all’art. 222, fa riferimento alla così detta Scuola Positiva di Diritto penale.
Il Codice Rocco prevede accanto alla tradizionale pena retributiva, fissa nel suo ammontare e proporzionata alla gravità del reato, le misure di sicurezza. Introduce al contempo, il sistema del doppio binario, che si sviluppa sul dualismo della responsabilità individuale, a cui segue una pena retributiva con durata “determinata”, e della pericolosità sociale a cui segue, invece la misura di sicurezza con durata “indeterminata”.
La misura di sicurezza, quindi, è destinata a soggetti considerati pienamente imputabili o semi-imputabili, ai quali, in relazione alla loro pericolosità si applica, dopo la pena, anche la misura di sicurezza detentiva (casa di cura e custodia per seminfermi di mente e altri semi-imputabili, riformatorio giudiziario per i minori tra i 14/18 anni giudicati capaci di intendere e di volere, casa di lavoro o colonia agricola per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza).
La conseguenza aberrante di questo sistema è che, mentre al soggetto imputabile, ma non pericoloso, si applica la sola pena e, ai soggetti non imputabili, la sola misura di sicurezza, nel caso di soggetti semi-imputabili e imputabili pericolosi, la misura segue alla esecuzione della pena e successivamente vengono ricoverati in riformatori o case di custodia e cura dove dovrebbero essere curati o rieducati. In tal caso, si corre il rischio che le principali categorie di delinquenti pericolosi imputabili, rischiano l’applicazione di una pena detentiva indeterminata.
Nella seconda metà dell’800, in seno alla Scuola Positiva del Diritto penale, Cesare Lombroso concepì la teoria del delinquente nato secondo cui, il delitto è un fenomeno naturale, si manifesta nei comportamenti di alcuni degli esseri umani al pari di quanto avviene per le altre specie animali. Salvo rare eccezioni, l’essere umano che delinque, commette reato non per propria scelta, ma perché delinquere è la sua natura: si delinque perché “si nasce delinquenti”. Ne deriva che rimproverare un delitto ad un delinquente, sarebbe come rimproverare ad una pantera di essere una belva feroce: dai delinquenti occorre semplicemente difendersi.
L’ordinamento penale, quindi, cambia prospettiva e, da meramente retributiva si focalizza sulla pericolosità sociale del delinquente, desumibile sulla base di criteri scientifici a prescindere dalla commissione stessa del fatto costituente reato. La sanzione penale, dunque, dovrà consistere in una misura che ponga rimedio alla pericolosità sociale di determinati soggetti dettata, non da esigenze punitive, ma di difesa sociale. Si delinea in tal modo, il ruolo delle misure di sicurezza; misure differenti dalla sanzione penale tradizionalmente intesa, da applicarsi a prescindere da un criterio di proporzionalità tra durata della misura (applicabile a tempo indeterminato) e fatto commesso.
Come si può notare, prevale un’ottica di esclusione in cui, cioè, è la società a dover essere difesa e preservata mentre, ai così detti socialmente pericolosi, si nega il riconoscimento dello status di persona umana compreso nella stessa definizione di “pericolosità”, violando l’art. 2 della Costituzione che sancisce «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Nessuna categoria di persone può essere deprivata, se non in maniera parziale e proporzionata a necessità cogenti, dei propri diritti basilari, quali il diritto alla vita, alla dignità di persona umana, ad un trattamento non discriminatorio, alla salute, alla libertà intesa in tutte le sue specificazioni. Si auspica quindi che, l’ottica dell’esclusione effettui un viraggio a favore del trattamento e della riabilitazione del “socialmente pericoloso” ai fini di una piena reintegrazione nella società.
La pericolosità sociale
L’intero impianto delle misure di sicurezza si regge, dunque, sul concetto di “pericolosità sociale”. Un concetto, tra l’altro, che deriva da una prospettiva fondata su teorie sociologiche, senza prendere in considerazione gli aspetti di pura pregnanza medico-scientifica. E invece, l’accertamento della pericolosità sociale, viene affidato dai giudici, proprio alla valutazione di periti tecnici, psicologi, psichiatri e medici, i quali obiettano da tempo la loro incompetenza al riguardo.
Ugo Fornari (2008), medico psichiatra e Docente Ordinario di Psicopatologia forense presso l’Università di Torino condivide l’opinione assai diffusa secondo la quale la nozione di pericolosità sociale psichiatrica è concettualmente amorfa, imprecisa, inadeguata e fondamentalmente funzionale a esigenze di controllo piuttosto che terapeutiche. Aggiunge che allo stato attuale, è impossibile dare un contenuto “scientifico” alla risposta al quesito circa la pericolosità sociale psichiatrica, se intesa nella sua originaria accezione di “prognosi”. Questa, infatti, secondo Fornari, deve essere lasciata al Magistrato ed aggiunge che è opportuno porre una distinzione fondamentale tra pericolosità sociale psichiatrica e pericolosità sociale giudiziaria.
Mi preme evidenziare alcuni punti che, sempre secondo Fornari, emergono dalle ricerche in tema di recidiva :
- La patologia di mente è percentualmente poco rappresentata tra gli autori di reato. Per lo meno, i malati di mente non delinquono in misura superiore al resto della popolazione;
- Non esistono rapporti di equivalenza tra malattia mentale e pericolosità sociale, anche se persone con doppia diagnosi, malattia mentale e abuso di sostanze risultano statisticamente a rischio di comportamento violento;
- La maggior parte dei soggetti socialmente pericolosi appartengono, nella criminalità individuale, alle categorie delle così dette varianti abnormi dell’essere psichico, spesso forzatamente iscritte nel vizio di mente; ovvero a forme di criminalità organizzata;
- Spesso viene sottovalutato, o ignorato, l’aspetto dinamico-evolutivo della patologia mentale, per privilegiarne caratteristiche di staticità e permanenza;
- Troppo poco si tiene conto delle modificazioni cui può andare incontro il quadro psicopatologico, se sullo stesso si interviene tempestivamente con tecniche adeguate.
Aggiungo, inoltre, che se si fa riferimento al carattere psicopatico che sottostà alla definizione di “socialmente pericoloso”, tipico della maggioranza dei cosiddetti “delinquenti abituali”, la caratteristica che li distingue è l’impulsività e la mancanza di coscienza morale; aspetti ampiamente descritti da Shapiro (1969) nella elaborazione dello stile impulsivo, secondo cui “nelle persone psicopatiche si può osservare un interessante atteggiamento quando considerano un’azione che in qualcun altro produrrebbe rimorsi di coscienza; è l’atteggiamento di “non tutto il male vien per nuocere”, un atteggiamento che dice … Peccato, ma nessuno ne ha colpa – chiunque avrebbe fatto altrettanto in quelle circostanze. Questo atteggiamento è notevole per l’assenza non solo di coscienza, ma anche del senso di aver scelto di agire in questo modo particolare – e di aver agito deliberatamente quando esistevano delle possibili alternative“. [3]
Risulta ben evidente che, la condizione vissuta dagli internati, favorisce un continuo alimentare gli aspetti dell’impulsività, e non una vera riabilitazione poiché necessiterebbe oltre che di trattamento farmacologico, anche di interventi tipo psicoterapeutico. Un simile stato di cose, contribuisce alla permanenza dello stato di pericolosità sociale. L’accezione tipica di “revisione” della pericolosità sociale, sottintende la valutazione di un cambiamento oltre che esterno, a cui gli psicofarmaci contribuiscono come dimostra l’esperienza della psichiatria, anche di un mutamento interiore che può avvenire solo attraverso la maturazione di aspetti di sé divenuti disfunzionali al mantenimento di un’armonia sociale nella comunità di riferimento. Una simile modificazione, si realizza solo attraverso una giusta combinazione di trattamento farmacologico e psicoterapia, tenendo conto delle ultime evoluzioni scientifiche in tal senso.
Inoltre, nel prospettare possibili scenari di trattamento, alternativi all’OPG, si dovrebbe essere in grado di individuare non solo fattori di rischio correlati al quadro psicopatologico diagnosticato, ma anche di tracciare concrete possibilità di intervento terapeutico, alla luce della duplice richiesta di questi pazienti: avere il miglior sistema possibile di trattamento/riabilitazione e fare in modo che questo trattamento “controlli”, o quanto meno riduca, il rischio di recidiva criminale. È però importante mantenere una sana aderenza al reale e prospettare al Magistrato con chiarezza i limiti dell’intervento, tenendo nella giusta considerazione i rischi di entrambe le prospettive: negazione pregiudiziale della pericolosità (assunzione di eccessive quote di rischio con ampi margini di responsabilità professionale) oppure una sua enfatizzazione per nascondere inadeguatezze soggettive o strutturali.
Come già argomentato, trovando il presupposto della pericolosità sociale inadeguato e di scarsa possibilità di validazione scientifica, la disposizione della misura di sicurezza, rischia di rivelarsi arbitraria. Un concetto poco idoneo e che mal si presta ad una verifica nel caso concreto. In tale contesto emergono anche fondate preoccupazioni di ordine costituzionale, per un possibile contrasto tra la disciplina codicistica in tema di pericolosità e il comma 3 dell’art. 25 Cost., che estende il principio di legalità anche alle misure di sicurezza. Scrive in proposito Adelmo Manna che il vincolo costituzionale della sottoposizione a misure di sicurezza soltanto “nei casi previsti dalla legge”, comporta che questi ultimi siano esattamente descritti, cioè che siano ben definiti gli elementi caratteristici della personalità assunta dalla legge come “socialmente pericolosa”. [4] Data l’impalpabilità del concetto di pericolosità sociale su cui il sistema delle misure di sicurezza si regge, risulta chiaramente indefinibile, e non adatto a soddisfare le esigenze di determinatezza e tassatività previste.
Gli “ergastoli bianchi”
Un articolo apparso il 9 giugno 2011 sul quotidiano La Repubblica riportava le seguenti notizie: «Barcellona Pozzo di Gotto – Giuseppe è da 18 anni dietro le sbarre dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto per aver rapinato 7mila lire con le mani in tasca, a fingere un’inesistente pistola. […] Fabio è qui da anni perché ha rubato una bicicletta, Dario non esce da almeno cinque anni, ha reagito violentemente con gli agenti dopo essersi rifiutato di pagare un conto in pizzeria. Sono centinaia gli ergastoli “bianchi”, le vite fragili interrotte, imprigionate. Con scadenza fine pena mai […]».
Un resoconto pubblicato sulla rivista mensile di Emergency, riporta altre testimonianze: «Un uomo di 58 anni, rinchiuso da otto nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, una notte va in bagno e con un lenzuolo trasformato in corda si uccide. Poche ore prima aveva saputo che la sua pena era stata prorogata ancora una volta e che, nonostante da tempo fosse stato giudicato non più “socialmente pericoloso”, sarebbe rimasto rinchiuso lo stesso. Maurizio, 30 anni, nel 2004 viene arrestato per aver guidato contromano con il motorino. Finisce in un OPG dopo aver dato segnali di psicosi. Di proroga in proroga sono passati sei anni. […] Di storie simili se ne potrebbero raccontare tante, purtroppo. A Napoli, un detenuto – paziente, internato per essersi presentato davanti una scuola vestito da donna, venne condannato a due anni. Ne sono passati venticinque, lui è ancora lì. Questo accade perché fuori non c’è nessuno – non la famiglia né una struttura sanitaria territoriale che sia in grado di prendersi cura di lui».
Il fenomeno degli “ergastoli bianchi” in Italia, sembra essere piuttosto un qualcosa di sistematico: sono quattrocento, un quarto del totale, gli internati giudicati dimissibili perché non più socialmente pericolosi, e che nonostante tutto, si trovano ancora rinchiusi. L’art. 69 della legge n. 354/75 attribuisce al Magistrato di Sorveglianza, la competenza a provvedere al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 208 del codice penale, nonché all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Nell’esercitare questa prerogativa, in relazione alla misura dell’internamento in OPG, i Giudici di Sorveglianza basano spesso le proprie decisioni su elementi che hanno ben poco a che fare con la persona sottoposta a misura di sicurezza, in virtù di una prassi alquanto infelice.
Ad essere determinante ai fini della revoca o della proroga della misura è, infatti, la disponibilità sul territorio di strutture sanitarie civili pronte ad accogliere coloro che vengono dismessi dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Qualora manchino strutture che li accolgano all’esterno, in buona sostanza, c’è un’elevatissima probabilità che i detenuti in OPG “rimangano dentro”: il Giudice di Sorveglianza proroga la misura.
Le carenze dello stato sociale, la quasi totale assenza di un servizio assistenziale e di recupero, si traduce così, per centinaia di persone, in una oggettiva privazione della libertà.
Bibliografia